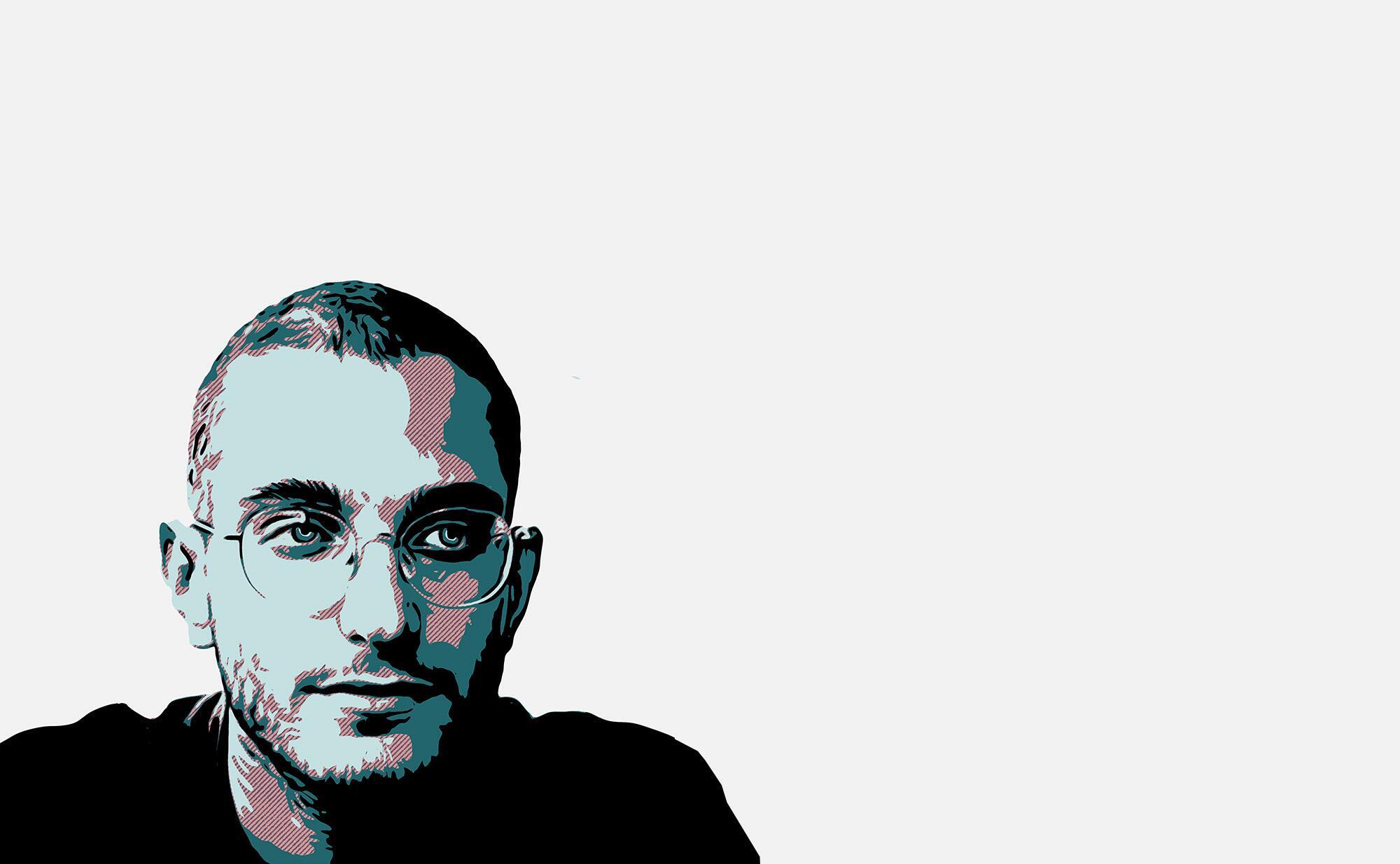Indi Gregory morirà. La neonata di soli otto mesi, affetta da aciduria combinata D,L-2-idrossiglutarica, una malattia neuro-metabolica scoperta dall’Università di Bari circa dieci anni fa, di cui si conoscono circa cinquanta casi nel mondo, non verrà in Italia. Il governo italiano le ha dato la cittadinanza e i genitori hanno provato in ogni modo, con ricorsi e appelli pubblici, a farla trasferire a Roma per delle cure diverse da quelle tentate in Gran Bretagna. Tuttavia, i giudici interpellati si sono affidati al parere dei medici, che hanno stabiliscono in modo unanime che la sofferenza della piccola non può essere alimentata e protratta. I benefici di un eventuale trasferimento, infatti, non superano il dolore provato dalla piccola. Tendenzialmente, malattie del genere non hanno cura. I genitori citano un caso eccezionale, un bambino americano vissuto fino a nove anni, perché è chiaro che per mamma e papà i figli non siano un numero e ogni speranza batte la statistica. Ma ci sono buoni motivi per lasciar morire Indi e valgono sia per i progressisti che per i conservatori, a patto che ci si fidi dei ragionamenti (anche quelli fatti con il cuore).
Partiamo dalla sentenza del giudice della Royal Court of Justice di Londra, Justice Peel. Al di là dei precedenti e delle questioni meramente giuridiche, la sintesi del giudice aiuta a comprendere di cosa si stia parlando. Come si può leggere nel documento del 13 ottobre 2023, Indi Gregory ha ricevuto diverse consulenze, team di cardiologi di due diversi ospedali, cinque esperti, pediatri e così via. Il parere medico è netto e non sono stati riscontrate opinioni differenti da quelle fornite dai medici che hanno Indi in cura. In altre parole, non c’è appiglio medico per sostenere un riesame del caso o un ritardo nelle procedure di interruzione delle cure. Ciò che si fa notare, inoltre, è la sofferenza incredibile della piccola. Il giudice evidenzia come, probabilmente, i “genitori non riconoscono la sua sofferenza, perché vedono Indi Gregory attraverso i loro occhi” di genitore e non di medici. Ma non vederla, o non capirla, per motivi strazianti come l’amore e la “devozione” - così la definisce il giudice - della famiglia alla neonata, non significa cancellarla. La legge britannica, a differenza di quella italiana, dà la priorità agli interessi della piccola su quello dei genitori, così scelgono la strada che la faccia soffrire per il minor tempo possibile. A questo si associa un’altra considerazione. Quale potrebbe essere la qualità della vita? Secondo il giudice, per quanto sia possibile concedere un livello minimo di coscienza della piccola, l’evidenza clinica stabilisce con chiarezza che la piccola non arrivi ad avere un grado di autonomia, men che meno stabile, tale da poter avere in futuro una vita migliore di quanto non sia ora: “Sembra trarre conforto dal fatto che la madre le accarezzi i capelli. Ma accetto le osservazioni cliniche secondo cui non segue con lo sguardo, non risponde agli stimoli e i movimenti degli arti non sono intenzionali”.

La difesa della scelta dei medici è, quindi, di senso comune. Siamo tutti inclini a considerare saggio evitare ulteriori e inutili sofferenze, soprattutto a fronte di una bassissima probabilità, se non nulla, di avere una vita migliore in futuro. Questa inclinazione viene usata in modo molto naturale da tutti i progressisti sostenitori dell’eutanasia e costituisce un argomento forte e quasi indiscutibile. Questo argomento è persino più forte di quello basato sulla libertà di scelta. Il senso comune, infatti, è molto più disposto a rifiutare il diritto di lasciarsi morire di un individuo che non il semplice argomento secondo cui la sofferenza debba essere evitata. La libertà di scelta, cioè, sembra molto più insensata di un argomento basato sul dolore. Dunque l’argomento che abbiamo usato è davvero difficile da discutere, perché molto semplice e intuitivo. E qualsiasi progressista sostenitore dell’eutanasia dovrebbe accettarlo. Tuttavia, a sostenere il trasferimento sono soprattutto conservatori, cristiani e gruppi pro-life.
Il discorso è in realtà più semplice di quanto possa sembrare. L’idea che sta dietro il concetto di vita difeso in questo specifico caso viene normalmente rifiutato in qualsiasi altro contesto. Prendiamo aborto e gestazione per altri. Nel dibattito su questi temi, l’obiezione fondamentale dei pro-life riguarda il fatto che la vita non è solo qualcosa di meccanico, che puoi gestire attraverso tecniche di aborto o di procreazione. Se alla nascita si pretende che la tecnica non abbia un ruolo (né nell’interruzione né nella procreazione), nei casi di morte vorremmo che le macchine tenessero in vita degli individui che neanche agli occhi degli esperti di quel tipo di tecnica (i medici) può avere senso. Questa contraddizione è tipica dei cristiani che criticano l’eutanasia. Ed è un’ambivalenza talmente evidente da essere difficile da negare. In generale, quindi, questo doppio standard dei pro-life non funziona né per l’eutanasia, né per Indi Gregory. Aggiungiamo che, cristianamente, non si dovrebbe avere paura di andare incontro alla morte e incontro a Dio. Quindi, qualsiasi cattolico dovrebbe accettare l’idea che Indi Gregory possa morire.
C’è poi un altro tema espresso in modo molto provocatorio dalla filosofa Judith Thompson riguardo all’aborto, ma che può valere anche per il caso di Indi Gregory: “Non è sufficiente mostrare che il feto è una persona e rammentarci che tutte le persone hanno diritto alla vita – occorre che ci si mostri anche che uccidere il feto sia lesivo del suo diritto alla vita, vale a dire che l'aborto è una uccisione ingiusta. Ma lo è?” Anche dato per scontato che Indi conservi quel po’ di umanità che le permette di riconoscere i capelli della madre, per esempio, davvero possiamo considerare la scelta di porre fine alla sua vita un omicidio, cioè un’uccisione ingiusta?