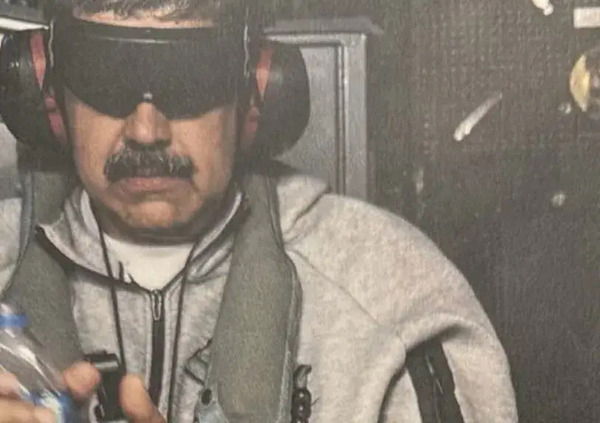“L’amara scoperta che Dio non esiste ha ucciso la parola destino, ma negare il destino è arroganza”. Da quando esiste MOW è, probabilmente, il decimo BeFolk che prende in prestito questo incipit di Un Uomo. Però se Oriana Fallaci è stata così immensa da sintetizzare in poche parole il pensiero moderno rispetto alle profondità c’è solo da copiare. Perché certe frasi valgono sempre. Sono adatte sempre. Questa, in particolare, quando c’è di mezzo un qualche disegno bastardo del destino. Come i ragazzi morti e quelli feriti a Crans Montana, nel delirio di un 31 dicembre che doveva essere di festa e invece è diventato letteralmente inferno. Ecco, c’è un pezzo in più, però, da aggiungere. Perché se è vero che negare il destino è arroganza, arrogarsi il diritto del giudizio di Dio, proprio come la Fallaci sottolineava, è follia autentica. Deriva terribile. Prova palese e lampante che mentre la capacità di pensiero umano viene meno, si prova a tendere al divino con la stessa semplicità con cui si accede a un qualche social. E’ il male – devastante e inquietante – di quei “uno vale uno” che andavano di moda nel decennio scorso. Il destino esiste. Dio, invece, forse no, ma sarebbe comunque l’unico titolato a un certo tipo di giudizi. E, invece, in questi giorni s’è sentito e letto di tutto, mentre i corpi carbonizzati di una quarantina di ragazzi e le ferite tremende di un centinaio di altri avrebbero meritato “solo” pietas.

Nel teatro di ogni tragedia, dove morte e sofferenza giocano da sempre il loro ruolo crudele, la recente strage di Crans Montana non ha fatto che aggiungere un altro capitolo a quel romanzo macabro che racconta la nostra incapacità di comprendere la sofferenza senza filtrarla attraverso il rancore. Un rancore che, paradossalmente, più ci allontana dall’umano, più ci spinge a credere di aver compreso il mondo. E’ un istinto moderno, ma scambiato per primitivo, di giudizio: miserabili lezioni di “giustizia” sociale, dove la sofferenza altrui, non importa quanta, diventa un simbolo di un qualche riscatto. Sì, la strage di Crans Montana ci ha dimostrato che "anche i ricchi piangono", ma pure che le loro lacrime troppo spesso sembrano servire solo a bagnare il terreno sul quale si fonda l’acrimonia sociale. E persino la giustizia non è più un valore, ma un trofeo da esibire in faccia a chi ha osato, forse inconsapevolmente, essere più fortunato. Più ricco. O più potente. E s’è potuto “permettere” di andare a crepare in un posto di lusso, dentro un bar da 300 euro a bottiglia. E in questa farsa, fatta di giudizi e di accuse, è chiaro che il vero pericolo non risiede nelle leggi svizzere – che pure, con il loro incedere gelido, sembrano ricordarci che l'equilibrio fra giustizia e severità deve essere ineluttabile – ma nella psicologia distorta di chi della sofferenza degli altri sembra nutrirsi. Anche, paradossalmente, chiedendo giustizia. Tranquilli: quella è la Svizzera, non l’Italia, dove si arresta per emotività e si assolve per burocrazie e incompetenze. Lì, sul momento, non hanno arrestato nessuno, ma presto – visto che è evidente che le responsabilità ci sono state – qualcuno non avrà santi a cui appellarsi e pagherà tutto quello che avrà da pagare.
Il debito eterno, invece, rischiano di averlo tutti quelli che hanno lasciato trasparire – neanche troppo velatamente – quella sorta di piacere oscuro e sotterraneo che ha pervaso molte delle reazioni più comuni alla tragedia: quella soddisfazione strisciante, quella piccola e sardonica consolazione che sorge dal pensiero che “anche i ricchi, alla fine, sono vulnerabili”. Quasi che il dolore altrui fosse una rivincita personale, una riparazione del torto subito, un ritorno al proprio posto nel mondo, come se l’ordine universale dovesse rispondere a un principio elementare di giustizia sociale: per ogni abisso di ricchezza e privilegio, il prezzo da pagare dev’essere un buco nero di sofferenza. Solo che questo tipo di risentimento sociale, che finisce per diventare una vera e propria religione dell’insoddisfazione, non è altro che una proiezione di insicurezze e frustrazioni personali. L’elemento comico, in tutto ciò, è che questo giudizio senza fondamento, questa voglia di riscatto nel vedere “il ricco che piange”, “gli svizzeri fuorilegge”, è solo l’ennesima manifestazione dello sconfinato disprezzo che gli esseri umani hanno, ormai, per l’umanità, travestendolo però da compassione per l’altro o da desiderio di giustizia.

E così, vedendo cadere –o addirittura bruciare - qualcuno che, magari, in vita ha goduto di tutti i benefici della fortuna, si finisce per assolversi rispetto all’odio che si prova. Come se per compensare il dolore, il mondo dovesse diventare più giusto, più equo, più "proprio". Eppure, nel cuore di chi celebra il dolore altrui, c'è il vuoto di chi non sa più distinguere la giustizia dal rancore, la compassione dall’umiliazione. Le leggi svizzere, così duramente criticate, non sono un’alternativa alle “emotive” e a volte esibizionistiche risposte giuridiche italiane, ma l’ennesima manifestazione di come il diritto, quando è praticato con rigore, non ha bisogno di urla o di clamore. La Svizzera non è un paese dove la giustizia si esprime attraverso il battage mediatico, ma piuttosto attraverso un’implacabile e silenziosa severità che fa della legge una vera e propria muraglia contro ogni elusione. Eppure, dietro la sua freddezza, la sua precisione quasi chirurgica, c’è un aspetto che sembra sfuggire a chi è troppo preso dalle proprie convinzioni ideologiche: la giustizia, anche se non sempre immediata, è sempre esaustiva. In Svizzera. Proprio perché si evita di applicare la stessa logica della giustizia sociale emotiva a un contesto che non ha nulla a che fare con l'emotività, ma con la realtà intransigente di una legalità che non fa sconto a nessuno. Anche se si è sbagliato prima acontrollarepoco. A controllaremale.
La morte, il dolore, la sofferenza sono, in fondo, le vere forze che muovono l’esistenza umana, non le rivendicazioni ideologiche di chi pensa di aver capito tutto. E se è vero – come purtroppo è vero - che “anche i ricchi piangono” e che “anche gli svizzeri sbagliano”, chi si nutre della sofferenza degli altri, nonostante tutto, è il più lontano dalla realtà, quello che alla fine si troverà a fare i conti con la propria miseria morale. Perché la legge o il destino li puniranno? No, ma perché ci si è ridotti a gusci vuoti mascherati da giudizi, da criminologi, da esperti di pubblica sicurezza, da moralizzatori, da riequilibratori sociali, quando invece si è solo incapaci. Incapaci di comprendere che l’umano non si misura nella vendetta, ma nel riconoscimento degli errori. Nella fragilità. Nel rispetto. Nell’essere, insomma, umani veramente.