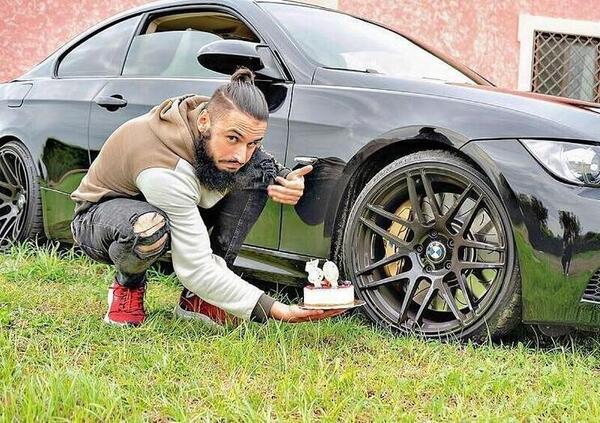L'autologia, in linguistica, indica una parola che esprime sé stessa, oppure una sua proprietà. Ma potrebbe indicare anche l’articolo scritto da Guido Meda in cui spiega la passione per il proprio lavoro: parlare di auto (e moto), con un taglio a metà tra il narrativo e il filosofico. «Parlare di auto è una scusa. Per parlare d’altro. Di vita, magari. In nome di una passione. Per parlare della voglia di partire senza avvisare. Della nostalgia di quando bastava girare una chiave per sentirsi adulti. Di come il rumore giusto di cilindri in armonia tra loro sappia far tacere pensieri sbagliati e opprimenti, soprattutto quando sanno di solitudine. Per parlare delle persone che siamo stati, e di quelle che, per fortuna o per caso, siamo ancora. Gli altri dicono: “Ma voi, alla fine, campate parlando di auto e di motorette?”. Sì, per fortuna. Ma mica solo. Parliamo anche di nostro padre, quando metteva le mani nel cofano con la certezza di sapere bene cosa stesse facendo - a volte - e con la speranza di farcela - altre volte». L’auto, secondo Meda, diventa un linguaggio per raccontare altro. Qui Meda si spinge quasi nel territorio filosofico e sociologico: il tempo, i legami, la costruzione di una memoria condivisa. Non si tratta di nostalgia sterile, ma di riconoscere nell’automobile un oggetto carico di significato. C’è l’eco della manualità trasmessa da un padre, la scoperta dell’autonomia, il valore simbolico quanto emozionante, a partire da quando si è bambini, di un gesto semplice come avviare un motore. È una riflessione su chi si è diventati, a partire da quei primi momenti di passione e scoperta. Conosci te stesso: un classico del pensiero occidentale, dai greci in avanti.

«Parliamo della prima volta in cui abbiamo guidato da soli: nessuno sul sedile accanto, solo noi e un Pandino sfiatato che sapeva d’estate. Parliamo delle curve sbagliate nella vita e di quelle che ci hanno salvati. Dei motori che abbiamo finto di capire, complicati come certe decisioni epocali. Degli amici persi di vista. Delle strade che conoscono il nostro nome, anche se le abbiamo dimenticate. Un’auto, a pensarci, è uno specchio. Riflette chi siamo, ma anche chi vorremmo essere. C’è chi si compra un Suv per sembrare solido. Chi una spider per sentirsi ancora giovane, libero e leggero, pur non essendolo più del tutto. Chi, come me, si tiene stretta un’Alfa del ’71 che cigola qua e là, ma come una nonna buona sa aspettare quando ho fretta e ha la parola giusta da sussurrare per mettere serenità dove c’è inquietudine». Guido Meda lo mette nero su bianco: le auto sono estensioni della personalità, ma anche contenitori di esperienza. La scelta del modello non è mai del tutto neutra: racconta aspirazioni, compensazioni, ritorni. L’identità automobilistica viene descritta con consapevolezza, senza forzature. E l’Alfa del ’71, vissuta e imperfetta, rappresenta l’accettazione del tempo e la ricerca di un’intesa affettiva con la macchina, più che di prestazione. L'eterno paragone col mondo femminile regge sempre, no?

«A volte parliamo di sedili. Ma in realtà si potrebbe dire che parliamo di schiene stanche, di posture sbagliate dopo giornate complicate. O di avventure dell’anima, in viaggi comodi ed entusiasmanti. Parliamo di fari full Led per raccontare che anche la notte, se la guardi bene, ha dei margini netti - e l’importante è dove metti la luce. Parliamo di trazione integrale perché capita di non fidarsi più di nessuno, ma c’è ancora la voglia sana di salire su una montagna innevata, sicuri di quello che si fa, con qualcuno di cui ci si fida seduto accanto. Parliamo di dettagli. Di maniglie a scomparsa, di schermi Tft, di click che non ci sono più. Non solo perché l’ergonomia conta, ma perché il dio di ognuno di noi sta anche nelle piccole cose fatte bene. E le auto, come le persone e le case, si riconoscono dal modo in cui ti fanno sentire quando non succede niente di niente. Parliamo anche di velocità, sì. Con affetto, non con fretta. Perché chi ama la velocità non è uno che scappa: è uno che va incontro alle sfide con consapevolezza, preparazione, buonsenso e competenza. Parliamo di frenate. Di quelle che ti spingono verso il volante e ti ricordano che, a volte, sapere quando e come fermarsi è molto più importante che credere di sapere dove andare. Parliamo di auto anche quando non guidiamo. Quando l’auto è parcheggiata sotto casa, con le ruote girate all’infuori, e ci guarda come per dire: “Non è importante dove andiamo, basta che andiamo”. L’auto ci ospita e ci ispira. Ci porta gioia e ci addolora. Ci riunisce in famiglia o ci consegna solitudine. Parlare di auto e di moto è una scusa. Ma è molto onesta. Per dire che ci manca qualcosa o che ci manca qualcuno. O che invece non ci manca proprio niente - e dovremmo ricordarcelo più spesso». Ancora l’auto, qui come ambiente vissuto, quotidiano, mai solo funzionale. Ogni componente, dal sedile al proiettore, dalla frenata alla trazione è una scusa per parlare di fiducia, conforto, precisione, cura. L’attenzione al dettaglio tecnico si intreccia con bisogni umani fondamentali: sentirsi protetti, accompagnati, capiti. La velocità non è più slancio cieco, ma gesto ponderato. La frenata, addirittura, viene rivalutata come momento di lucidità. È una visione matura dell’auto come presenza costante e silenziosa, in grado di accogliere tutto ciò che ci portiamo dentro. Ecco cosa vuol dire parlare d’auto. L’autologia come una nuova antropologia. Perchè, parafrasando Kant, l'auto non è soltanto un mezzo, ma un fine in sè.