«Volevano che fossi il loro condottiero. A vita. Il padre, il fratello, il criminale. Potrei scrivere un romanzo su quello che è successo in quarantotto ore».
Aurelio Picca è appena tornato da un incontro al carcere. Quando lo chiamo sta riposando a letto: «Non mi scoccia, fa caldissimo, e poi è pieno di turisti, non sopporto i turisti». Quando gli chiedo perché la risposta è lucidissima: «Sono i nuovi fagottari globali, no? Hanno preso il posto dei vecchi fagottari antichi. Anche dei veri pellegrini che andavano nei santuari. E poi...» E poi cosa? «Come fanno a divertirsi e vivere mentre fanno la fila ai ristoranti? Vanno col trolley in giro di corsa, mangiano male, si svegliano presto. Ma dico, come cazzo defecano la mattina? E poi li vedi in coda che ridono. Ma che cazzo ridi? Avvelenati. Vai a letto, ti fai una bella dose di veleno e muori. Ma non è meglio?». E con il tono di chi, tra i pochi in Italia, ha saputo fare anche grande letteratura civile: «Possibile che l’Italia debba essere un nosocomio di camerieri? Siamo il nosocomio dei camerieri del mondo». L’intervista ancora deve iniziare ma avremmo potuto fermarci qui, al modo in cui in Italia incameriamo tutta questa follia banale, instagrammabile. Mentre lo dice mi passano in testa già tre o quattro titoli per questo articolo. Poi aggiunge: «A Napoli se ne stanno accorgendo, per fortuna. E se cade Napoli cade il mondo». Quinto titolo. Poi, appena prima di iniziare con le domande, mi chiede: «Facciamo una cosa radicale? Perché vedo sempre meno cose radicali. Va bene?». Ok.

Tu sei nato come poeta.
Una volta da ragazzo scrissi «È un leggero spostamento del capo a suggerirmi la furia dell’azzurro». La poesia è la furia dell'azzurro, capito? Una visione, uno scatto, è uno sguardo imprendibile sulle cose. Ho amato tanto la poesia, ero in uno stato di concentrazione estrema contro il mondo, ero quasi invisibile, lo guardavo dall’alto. Per me è una questione quasi sacra, intoccabile. Adesso invece si fa uso del termine “poesia” un po’ per tutto. È la secolarizzazione della poesia, ecco. La caduta del sacro.
Oggi esistono ancora i poeti?
Io leggo Claudio Damiani, è un combattente invisibile che continua ancora ad amare la lingua e anche lui è d'accordo con me nel pensare che la lingua sia una patria, la nostra patria.
E dei giovani poeti che diventano famosi sui social cosa pensi?
Io non metterei mai una poesia su un social. Perché la poesia, in quanto sangue dolce di cardellino, va incisa sulla carta. Mi ricordo sempre il ritratto del Bronzino di Giovanni de’ Medici. Io penso sempre a degli uccellini che hanno il sangue dolce, capito? Se tu scrivi senza sangue non è poesia. Basta, è inutile aggiungere altro.
No, dimmi.
Come fai, quando scrivi, a dimenticarti il segno della croce? Io sono un cristiano delle origini, capito? Antropologicamente sono nato tra paganesimo e inizio del Cristianesimo. Quando c'è il passaggio tra Iside e la Madonna. E poi credo anche nell’antropologia dei luoghi. Io sono nato nei boschi sacri, sui Colli Albani. Quindi il mio è un cristianesimo non laicizzato, ma proprio delle origini, dei tempi del martirio. Della ferocia. E la poesia deve avere questo stesso martirio. Sto rileggendo Yukio Mishima. L’amore estremo è nella morte.
«Perché forte come la morte è l’amore», il Cantico dei Cantici.
Esatto, ma Forte come la morte è anche il titolo di un romanzo di Guy de Maupassant, il mio grande autore. E visto che abbiamo parlato del sangue degli uccelli, dell’inchiostro della poesia. Tutti dovrebbero leggere i Racconti della beccaccia di Guy de Maupassant. Sono degli scritti altissimi.
Come siamo passati dalla poesia al racconto, alla prosa?
Perché i racconti sono molto vicini alla poesia, per la velocità, devi raccontare tutto in poco tempo e l'espressione deve raccogliere immediatamente la totalità della realtà. Non c'è quasi niente di comunicativo. È veramente un colpo, una fucinata nella notte.

In un’intervista di Gianmarco Aimi su Rolling Stone, Aldo Nove ha criticato Franco Arminio, colpevole di aver istituito un «canone dove basta andare a capo» e aggiunge: «Questa non è poesia, è una cagata». Che ne pensi?
Ma io non mi interesso di loro, non sono miei pari.
A proposito della sacralità della poesia, che pensi del Premio Strega Poesia.
Io non commento né il premio della poesia, né il premio stesso.
Perché?
La poesia, anche più della letteratura in generale, è stata sempre un elemento aristocratico. Diciamo la verità, perché i lettori veri nel mondo, cioè coloro che sono dentro le cose, in Italia non sono più di tremila. Poi ci sono i lettori acculturati, che aumentano, cioè quelli che vengono dai libri, da quella cultura ideologica e post-ideologica. E infine i lettori del libro immiserito dal marketing, cioè quando viene reso oggetto di consumo, a prescindere se lo si legge davvero o no; loro sono i più numerosi. Nell’epoca globale, la nostra, dove tutto è diventato comunicazione, la poesia deve entrare nel circuito comunicativo perché deve essere venduta. E allora aumentano i premi. La questione gerarchica, la questione dalla quale noi siamo partiti, è dimenticata, è azzerata, non ha senso. Resta qualcosa che riguarda il mondo antico.
In passato la poesia e la musica, c’è chi dice anche nella canzone d’autore, andavano a braccetto. Perché poi è avvenuto uno scollamento?
Che i cantautori siano dei poeti è falso. La poesia è quella che si scrive, ma sul carro di Carnevale dell'attualismo anche i cantautori ormai vengono chiamati poeti. Ma non è vero. La poesia è la forma più reazionaria che esiste, capisci? O è incisa, come ho detto, o non è. È eversiva.
In che senso eversiva?
Tutto ciò che è fortemente reazionario, nel senso di essere legato a quel sacro, è eversivo, cioè il massimo della rivoluzione. Non è un oggetto in vendita, cosa c’è di più eversivo oggi? Non si possono fare sconti.
Dalle auto ai gioielli e una volta sette fidanzate contemporaneamente. Se ti dicessero che sei un trapper della cultura
Ma no, io sono un signorino, un principino. Io amo i gioielli, soprattutto femminili. D’altronde mi chiamo Aurelio, che viene da oro. Io ho ereditato due cose, i gioielli di mia madre e la rivoltella di mio padre, non è una posa. Mi darei la morte pur di non travestirmi da saltimbanco dell'attualità.
Ma un principe, oggi, che musica ascolta?
Ascolta la musica melodica napoletana, la musica leggera italiana degli anni Sessanta e Settanta. Qualcosa di David Bowie. Poi sai, ho scoperto che sono nella mia nuova giovinezza, questo concetto di cui ho letto soprattutto in alcuni autori degli anni Trenta, secondo cui l’infanzia uno se la porta dietro, si rinnova. E in questa nuova giovinezza ho capito che in fondo i Beatles sono stati superiori ai Rolling Stones. E Luigi Tenco a Fabrizio De André. E poi c’è un ragazzo, formidabile sia a suonare che a cantare. Lucio Battisti, che è ancora imbattibile.
Tenco superiore a De André?
Largamente. Ti faccio un altro nome. Rino Gaetano. L’ho conosciuto e non lo apprezzavo per niente. Però Mio fratello è figlio unico vale tutto De André. Non ho mai apprezzato neanche Mina, troppa tecnica. Una linguista della musica.
Dove ascolti la musica?
In auto, ma ora l’ho dovuta cambiare e il nuovo modello non mi permette più di mettere i cd. Quindi la sento mentre mi faccio la barba. Posso farti altri due nomi?
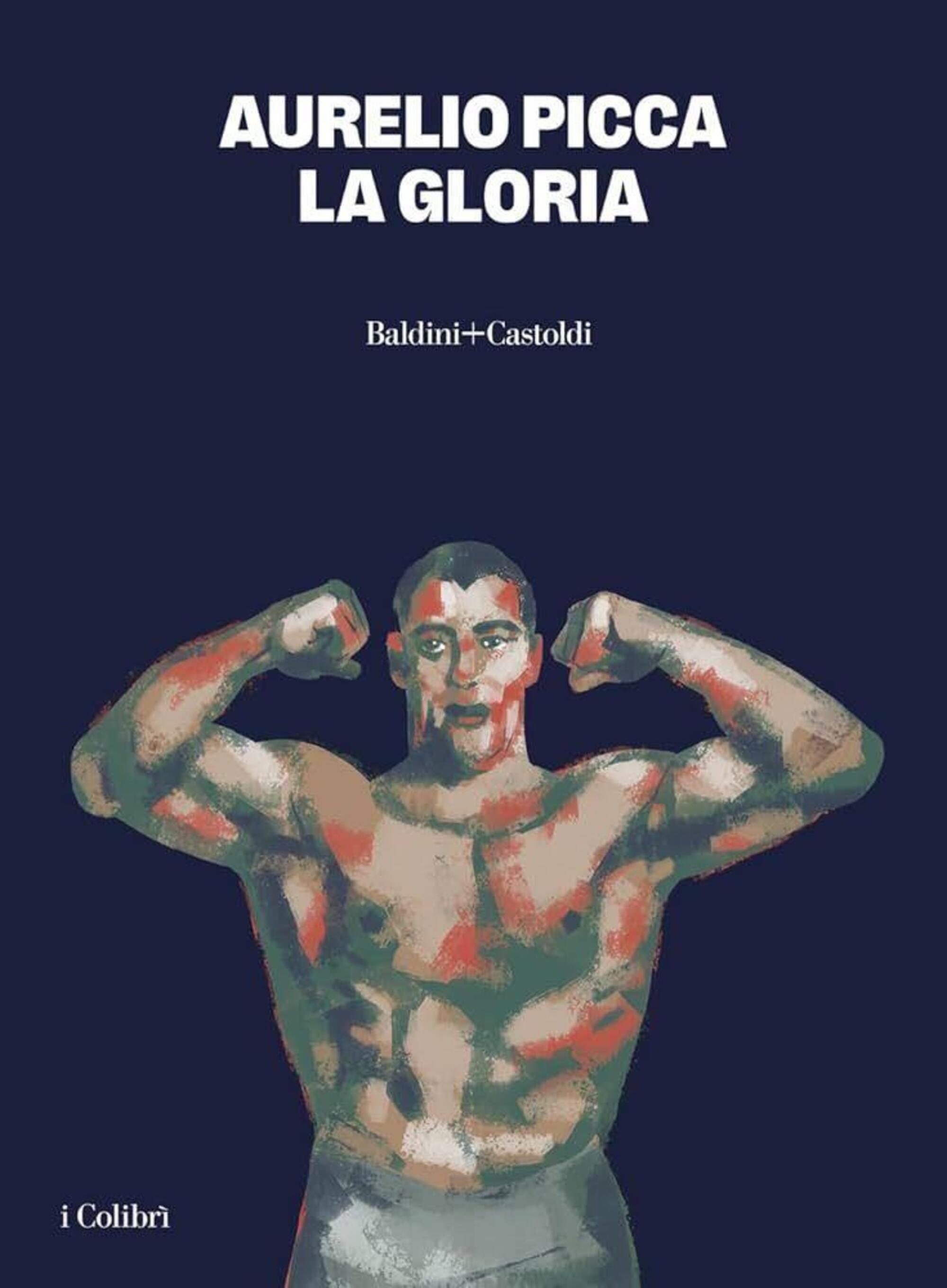
Hai detto che sui racconti brevi sei micidiale. Ma i racconti brevi, almeno in Italia, quasi non si leggono (e scrivono) più. Sei il migliore a scrivere un genere che la gente non legge più?
No, ma io sono migliore in tutto, non è vero.
Anche nei romanzi?
I miei libri, anche quelli che sono arrivati a quasi trecento pagine, sono tutti verticali. Quindi hanno un cuore, una pompa, una velocità del sangue che è quella della poesia e del racconto. Il mio grande sogno è quello di scrivere un romanzo lunghissimo fatto tutto in verticale, dove ci sono solo principali, nessuna subordinata. Anzi, ho già iniziato.
Sembra difficile.
È la mia velocità gestuale, la mia velocità interiore. Come quando guido l’auto. Ho comprato una macchinina nuova solo per farci ogni tanto dei testacoda.
Del tuo ultimo libro, La gloria, Andrea Caterini sul Giornale scrive: “I pugili vivono la follia della realtà”. Vale anche per gli scrittori?
No, non capisco cosa sia la follia della realtà.
Secondo te non c'è nessun rapporto tra la follia e la realtà? O meglio, la realtà non ha una sua parte di follia e non è questa che, alla fine, gli scrittori cercano?
La realtà in questo momento è folle perché è dozzinale. È feccia, è edificazione. La vita, che è un'altra cosa, è la follia. Gli scrittori si devono misurare con la vita. È quell'amore-morte di cui abbiamo parlato. È quella sessualità che c’è nella castità. È nella purezza. È tornare a essere come i samurai di Mishima. Quella è la vita, capisci? Che non cambia mai.
Cos’è questa follia della realtà, la purezza e la violenza insieme?
È l'orgasmo più puro, cioè il momento della fecondazione. Un uomo e una donna raggiungono l'orgasmo assoluto quando fecondano. Questo sì che è incendiario.
C’è un passaggio, nel suo libro, in cui scrive, a proposito di una cavalcata insieme alla sua ragazza di allora (e aggiunge: «Ora morta»): «Con lei ci amammo nell’erba. Sapete, era quel fare l’amore teso e morbido in gesti privi di pensiero. Irrompeva. Un amore fresco, perfetto. Un entrarci dentro per non uscire mai.” In questi ricordi tu ritrovi la “gloria»?
Assolutamente sì. La gloria è quando l’uomo combatte. Anche nello sport quello che cerco è il duello.
Quali sport segui ora?
Ma ora lo sport non è più il duello, manca lo strappo divino. Guardo solo la Formula 1.
Chi ti piace?
Max Verstappen ovviamente. È un criminale al volante. Uno degli ultimi antichi criminali. Se non avesse scelto di correre in Formula 1 avrebbe potuto fare le rapine.
E MotoGp?
Prima, soprattutto.
Ti piaceva Valentino Rossi?
È chiaro. Lo sfregio di Marquez, che gli ha impedito di vincere il decimo titolo, credo sia stato il più grande crimine di questo sport.
E invece il calcio, lo sport nazionale?
Giocano tutti allo stesso modo, giocano in riga, non ci sono più duelli. L’unica cosa divertente che trovo nel calcio moderno è il portiere, che è diventato il primo regista della squadra, che non era mai accaduto nel mondo del calcio. Prima del calcio attuale i portieri non sapevano proprio usare i piedi. Adesso invece impostano l’azione.
Nel tuo libro parli anche del sollevamento pesi come di uno «sport interiore», un «culto del ferro», «una continua preghiera tra loro e il metallo». Anche la punta della penna è di metallo. Ti pesa mai?
Mai. Io scrivo sempre a penna, ho una ventina di Parker.
E il computer?
Dopo, ma quando scelgo di scrivere cerco le mie penne, voglio ancora sentire, metterci le mani. Che la parola mi esca dal corpo. Che non ci siano filtri con la pagina.
Quando scrivi come fai a costruire i personaggi?
Faccio la loro vita. Per diventare meglio Alfredo Braschi, [il protagonista de Il più grande criminale di Roma è stato amico mio, Bompiani 2020, ndr] sono andato a vivere in albergo e mi stavo quasi per comprare una Ferrari 412. Per fortuna non ci siamo messi d'accordo per diecimila euro, altrimenti l’avrei comprata.
In Contro Pinocchio, né solo un romanzo né solo un saggio, parli di infanzia. Oggi credi esista ancora quel tipo di letteratura lì, che a un Aurelio Picca del futuro farà scrivere un Contro Pinocchio della nostra epoca?
No, assolutamente. Io mi sento ancora Ernő Nemecsek, che ha per patria solo quel campo il calcio e muore per quel campo da calcio. Quando scrivo di Pinocchio parlo del primo grande romanzo di Collodi, che è il Pinocchio gotico in cui Pinocchio rimane burattino. Le altre versioni fanno ridere. Ma non stavo scrivendo un saggio, era un romanzo autobiografico in un certo senso.
Per questo non esisterà un altro Contro Pinocchio in futuro?
Mai, solo io sono arrivato a quell’assoluto. Nessuno mi è uguale, lo scrisse anche Raffaele La Capria. «Aurelio Picca è uno scrittore irregolare, diverso dagli altri in modo decisivo. Uno scrittore estremo». Anche perché parlare oggi di infanzia è come parlare del duello di un tempo, capito? L'infanzia oggi è un'infanzia che non tenta più di farsi male tra la strada e l’azzurro del cielo. Oggi l’infanzia è cercare di scendere dal Suv oppure giocare alla PlayStation.
C’è stato un complimento che ti hanno fatto che hai apprezzato particolarmente? Questo di La Capria magari.
Tutti. Io ho messo d’accordo la critica della tradizione, come Geno Pampaloni qui a Firenze, Enrico Ghidetti, Rosanna Bettarini, Luigi Baldacci; e la neoavanguardia. Mi hanno elogiato Angelo Guglielmo, Alfredo Giuliani, che forse è stato il più grande saggista della Neoavanguardia. Ma poi anche Enzo Siciliano e uno degli ultimi maestri del Novecento, Domenico Rea. Ma potrei dirti anche Natalia Ginzburg, Ruggero Guarini. Io ho scritto i miei libri con vent’anni di anticipo, infatti ora mi leggono i trentenni. Quando gli altri andavano verso la comunicazione già nei primi Novanta, io restavo asserragliato nell'espressione.
E invece una stroncatura che ti ha fatto male.
Non credo di averne avuto. Forse una volta, con Via volta della morte, il libro che mi ha reso il terzo conquistatore di Urbino dopo Federico da Montefeltro e Paolo Volponi. In quel libro ho letto Federico da Montefeltro attraverso Palazzo Ducale, che è la sua faccia esoterica, e i dipinti di Piero della Francesca. Ma con questo libro, stranamente, qualcuno ha abbassato un po’ i toni, ma non c’è stata mai una vera stroncatura.
Sei stato in anticipo con I mulatti, per esempio. Ma anche con L’Italia è morta, io sono l’Italia (Bompiani, 2007).
Da quanti anni non si scriveva un poema civile sull'Italia?
Ci sono stati Dei Sepolcri di Foscolo e Le ceneri di Gramsci di Pasolini.
Appunto. Forse qualcosa di D’Annunzio, ma non erano veri poemi.
È stato anche un ritorno alla poesia.
Io la poesia non l’ho mai abbondonata, ho solo smesso di pubblicarla, tranne in qualche catalogo. Ho tante opere che potrei pubblicare, anche uno scritto inedito di quando avevo vent’anni. Ma la scrittura si muove costantemente dentro di me. Se in questo momento sto scrivendo un romanzo è perché dentro di me l’ho iniziato dieci anni fa. Ne scrivo sempre tre o quattro insieme nella mia testa. E non so mai su quale mettermi a lavorare. Se a quello più feroce o a quello più tenero.

Abbiamo accennato a Foscolo, che è uno dei poeti che ami di più. È anche obbligatorio a scuola. Come viene insegnata la poesia?
Io ho insegnato. A quelle canaglie analfabete facevo imparare a memoria dei Canti interi dell’Inferno di Dante. Li costringevo e poi facevo mettere a loro i dieci sul registro intoccabile del professore. Attraverso la poesia davo loro dignità, un’energia bestiale. Dovrebbe essere sempre così.
Un corpo a corpo con la poesia.
Bisogna farci l'amore.
Valditara ha varato una riforma per la scuola. La Bibbia viene messa con i miti, la Storia è una disciplina solo occidentale. Si torna anche a promuovere il latino dalle medie. Stiamo tornando indietro?
Onestamente non ho ben capito cosa voglia fare.
Ti piace la storia?
La amo. È una vita che mi interrogo sul perché Annibale dal Trasimeno non prende Roma.
Ti sei dato una risposta?
Per me Annibale non voleva conquistare, voleva diventare un figlio di Roma. Come dice Dostoevskij, la patria è la grande visione dell'Impero. Lui, che da cartaginese non aveva davvero una patria, era la patria che cercava.
La patria pare diventata un concetto di destra. Ma Aurelio Picca è di destra o di sinistra?
Io sono un mazziniano rivoluzionario. Ho vissuto in una famiglia che credeva in Dio e in Garibaldi. Io sono cresciuto con i ritratti di Mazzini. Io amo il popolo, che non esiste più.
E cosa siamo ora?
Cosa sono. Sono una massa terribile.
È la massa terribile che ha votato Giorgia Meloni?
Credo che molti l’abbiano votata un po' perché hanno memoria del popolo, è quella parte di cittadini che si è sentita vinta nell’ultima epoca.
E la sinistra di oggi come la vedi, Elly Schlein?
La sinistra è scomparsa perché non c’è più la classe operaia. I comunisti che ho conosciuto erano operai, non erano intellettuali o i dirigenti di partito. Erano i poveracci che si svegliavano alle 4:00. Oggi non esiste la sinistra, esistono i progressisti.
E non va bene?
Io credo solo nell'evoluzione, non credo nel progresso. Il progresso si è unito alle comodità, alla borghesia, ai privilegiati. Non si interessa più degli ultimi. E su questo fallimento Giorgia Meloni è riuscita a raccogliere voti.
Come giudichi la premier?
Le nazioni, i governi, compiono molto poco, questo è il fulcro della grande trama del globale. Ci sono dei poteri che mettono le mani dappertutto. Lei cerca di mantenere una rotta, di credere ancora che l’Italia possa avere un ruolo a livello mondiale, ma è un’illusione. Il gioco è molto più grande.
Credi che Alessandro Giuli sia un buon ministro della Cultura?
Giuli non lo conosco, ma so che è un mio lettore. Credo sia una brava persona.
Oggi si parla costantemente di fascismo e antifascismo.
Quando è caduto il fascismo i quadri intermedi dello Stato sono passati tutti con la Democrazia Cristiana. Gli intellettuali di rango fascista sono passati tutti col Partito Comunista, capito? C’è stata una spartizione dei ruoli. Spesso i più critici, i più assertivi nel parlare di fascismo, sono quelli che hanno avuto padri fascisti. Io, che non sono nato da una cultura fascista, come Pasolini credo che il fascismo sia stata una tragedia. Una tragedia che va studiata. E va studiato per quello che è stato, quindi anche quelle storie dei fascisti che il giorno dopo la liberazione buttavano i loro compagni della notte prima nel Tevere.
Se potessi diventare premier, cosa proporresti nei primi cento giorni del tuo governo?
Chiederei agli italiani di essere più casti, di guardare dentro se stessi, dentro le loro storie personali, dentro le loro storie familiari. Riagganciarsi, insomma. Di non scimmiottare la cultura performativa. Gli chiederei di trovare l’antica fedeltà per questa nazione, questo arcangelo che è stato mutilato.













