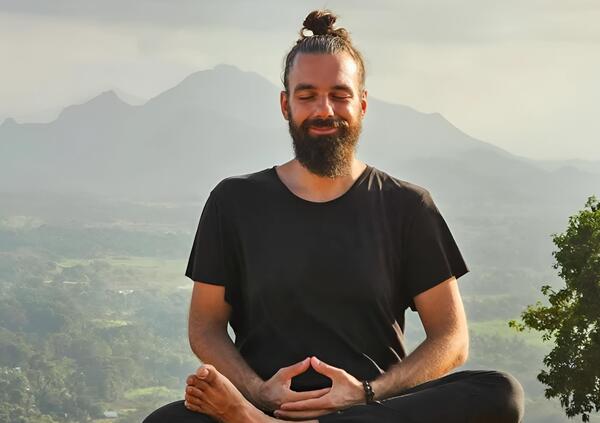Ci sono libri che proprio ti aspetti che siano in un certo modo, prevedibili fin dal titolo. E li chiamo libri, molto genericamente. Cioè leggendo il libro di Concita De Gregorio, appena uscito per Feltrinelli, “Di madre in figlia”, già sai, prevedibilmente, nel solco di esperienze narrative simili, molto facili da incontrare quale frutto spumoso di salotti radical chic, non letterari, una specie di sottotono autocelebrativo, femminista e quindi politico. Vecchie casacche, usate, logore, sempre le stesse. Che sia una storia di donne? Naturalmente. Ma è un attimo e la storia di donne e di filiazioni e imparentamenti vari diventa un collettivo, prevedibile appunto, in discendenza genealogica, dove magari l’albero sarebbe opportuno e più woke chiamarlo “albera”. Non riesco a definirlo un romanzo, ma lo è. Sono siparietti, e invece no, sono capitoli. Tutto dialoghi e lettere o monologhi, da nonna a nipote e a risalire dalla nipote, alla madre, alla nonna.
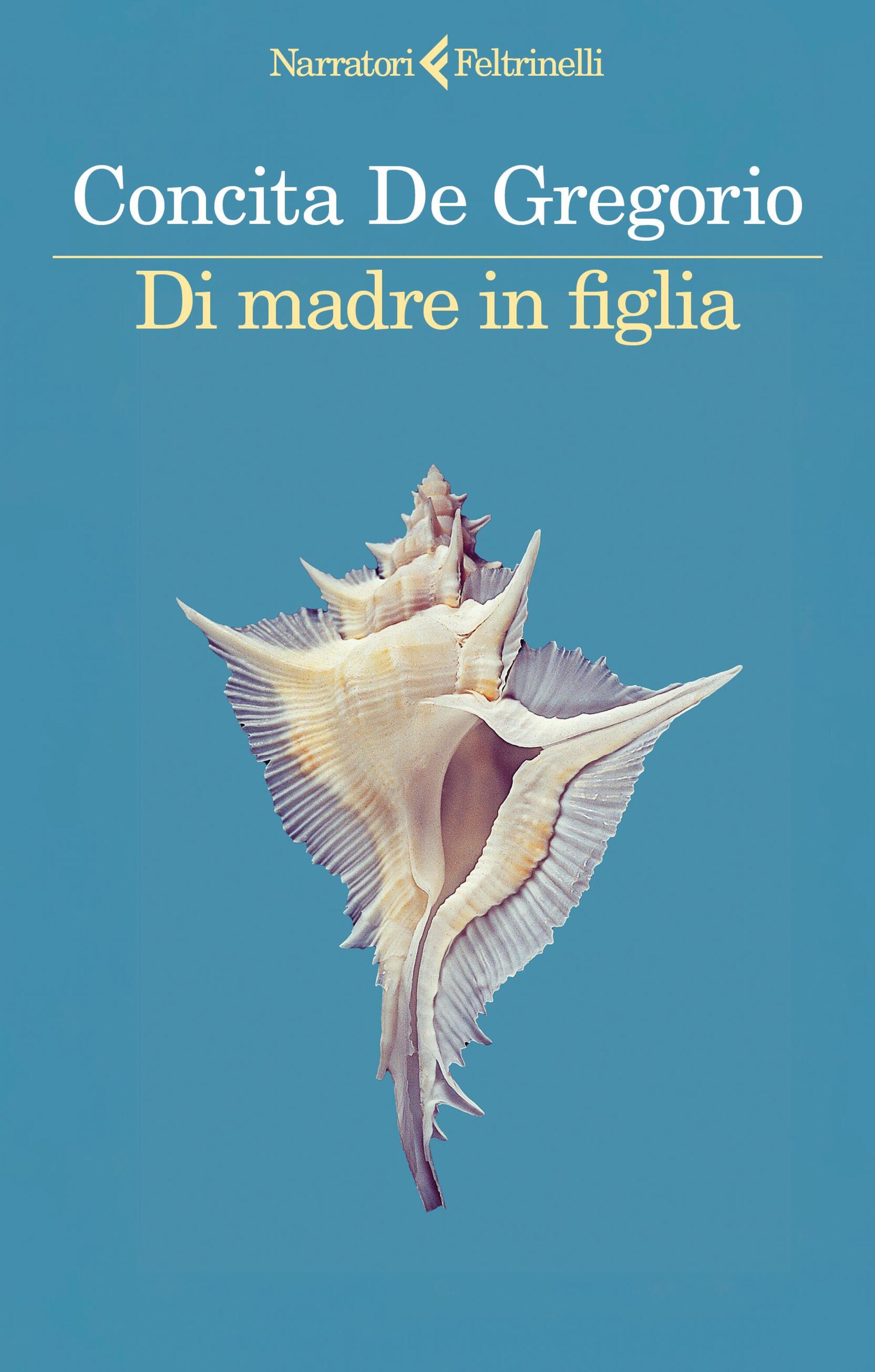
Tutto un passato prossimo, o la coniugazione al presente, un fastidioso passato prossimo/presente, minimale, “dice, ha detto”, eccetera, a tambur battente, alla fine del qual tambur battente si è abbastanza infastiditi. Insomma un po’ te lo aspetti dalla De Gregorio un libro così, una di quelle operazioni a metà tra editoriale proto qualcosa e sottotesto politicizzato sullo sfondo, ovvio oltremodo. Capitoli nati pronti per un copione, dialoghetti teatrali, neanche da sistemare. Sorprende il tentativo di indurre il riso o il sorriso, un mood caustico, irritante perlopiù, poiché non ingenera una risposta, un reagente utile perlomeno. Non mi fai ridere, verrebbe da rispondere così brutalmente. Non mi fai nemmeno sorridere o riflettere, mi verrebbe da aggiungere. So già, è un che di già sentito che accompagna stridulo il tambur battente degli ossessivi “ha detto, ha detto”. C’è una nonna, una madre, una figlia. Un testo corale. Ma è difficile distinguere il linguaggio dell’una o dell’altra, uniformato, non dovrebbe però. Nel mio immaginario si deve stagliare il personaggio distinto. Si fa fatica, difficile intercettare una qualche credibilità. Personaggi che non empatizzano. Anche perché non riconosciamo un luogo, un paesaggio, un moto dello spirito, una riflessione che esca dal continuum “dice, dice , ha detto, ha detto”, eccetera.

Prima di chiudere l’ultima pagina, la domanda retorica non sarà sconfessata: vuoi vedere che nel solito rimestare di rancori e esperienze, errori, nell’albera woke, da nonna a nipote passando trasversalmente per zie e madri (penso a Va’ dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro), sarà anche qui la nipote a unire tutti i puntini? Vuoi vedere? È il libro di una che ha mestiere, il mestiere della comunicazione, sapete quella abilità ruffiana, “paracula”, da talk su La7, buona per una poltronata da Floris al più. Sarebbe meglio la riflessione: è anche il libro di una mestierante. Purtroppo toglierei la congiunzione “anche”. Finisce lì. Non è letteratura. Cos’è? Oltre l’introspezione modaiola, da terrazze romane, cosa c’è? Ma chi sono io d’altronde per chiedermelo.