Per sua stessa ammissione, Abel Quentin sostiene di aver scelto di scrivere il libro dopo lo shock provato quando scoprì del Rapporto Meadows, uno studio degli Anni Settanta sulla crisi climatica, divenuto nel tempo quasi una ricerca-profezia, un amuleto della discussione intorno all’ambiente. Uscito nel ’72 grazie al lavoro di alcuni ricercatori del Mit e su richiesta del Club di Roma, il Rapporto profetizzava una sorta di crollo della civiltà dovuto al raggiungimento del limite massimo di sviluppo del nostro modello di produzione e vita su questo pianeta. Insomma, avremmo consumato troppo, e troppo rapidamente, ciò che avevamo pattuito con madre Natura. Pensa allora quanto potrebbe restare schioccato leggendo The Ultimate Resource dell’economista Julian Simon, per esempio, che dimostrò come le tesi del Rapporto Meadows fossero a dir poco catastrofiste. O che dire dell’ultimo libro di Hannah Ritchie, ricercatrice di Oxford e Capo dipartimento di Our World In Data, che in Non è la fine del mondo (Aboca), pur riconoscendo la crisi climatica, ridimensione notevolmente il nostro discorso apocalittico. O che dire di Bjiorn Lomborg, che fa lo stesso in Falso allarme! (Fazi). In fondo anche l’ultimo report dell’Ipcc, spesso citato a favore dei discorsi più millenaristi, crede che lo scenario più probabile non sia il più tragico, e cioè l’Rpc 8.5, ma uno scenario intermedio, l’Rpc 6.0.
Sta di fatto che, tra tutti, è il primo rapporto a essere di certo il più suggestivo agli occhi di uno scrittore, a meno che tu non sia Pierre Boulle e non voglia scrivere Il buon leviatano (Liberilibri). I quattro che predissero la fine del mondo (Edizioni E/O) è un lavoro di narrativa giornalista più che di narrativa storica, non solo perché tratta di temi attualissimi facendo riferimento a una storia recente, ma perché la costruzione del libro, come ci ha abituato Quentin, segue con linearità una storia su cui non si calca mai la mano, su cui non si favoleggia. Questo minimalismo è una qualità di Quentin, la stessa de Il Veggente di Étampes (Edizioni E/O, 2024), ma stavolta la storia non è un caso limite a metà tra integrazione, limiti della convivenza e contraddizioni politico-religiosa. Qui si parla di quattro scienziati, di cui due sposati, che scoprono una verità, secondo loro, nera e ineluttabile. C’è solo una possibilità su nove di potersi salvare. È in questa misura – quella del collasso – che Quentin ci chiede di aprire gli occhi: “Dobbiamo cambiare il nostro sguardo sulle cose, Paul. Guardare ogni porzione della Terra come la parte di un tutto esauribile e finito. Avere la percezione della superficie limitata di ogni elemento. Mentalmente. E allo stesso tempo, avere la percezione dell’impatto umano sul mondo. Il crescente impatto.
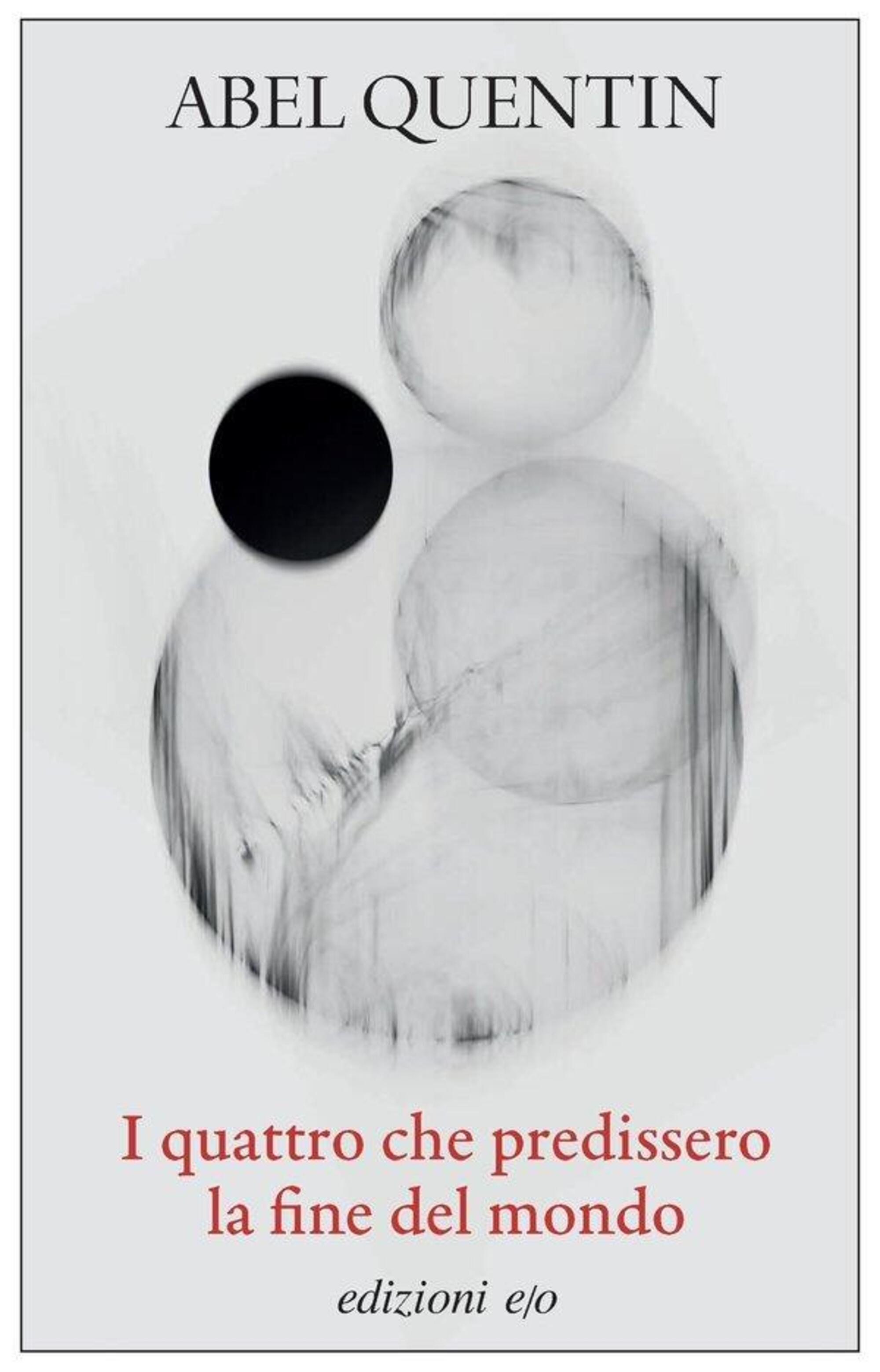
Non è l’unico ad averne parlato di recente. Forse lo scrittore più popolare di tutti ad averlo fatto è Jonathan Safran Foer con il suo Possiamo salvare il clima, prima di cena (Guanda). Ma ben più di recente a far parlare di sé è stato il secondo romando di Stephen Markley, Diluvio (Einaudi). Una storia che scorre per un migliaio di pagine e che dovrebbe darci l’idea della fine imminente del nostro mondo, della nostra idea di esistenza. Un grande diluvio appunto, un reset biblico. La direzione che prende Quentin è molto simile, ma più discreta. Mentre Markley si concentra talvolta eccessivamente su particolari scientifici, Quentin sfrutta il rapporto e la storia dei personaggi come stimolo intellettuale per una riflessione a un tempo più ampia e meno approfondita, spingendo sul senso comune e la possibilità di trasformarlo. Quentin ha cioè misurato con attenzione il grado di complessità a cui può sottoporre il lettore, quasi che l’intento del romanzo fosse, oltre che letterario, pedagogico.
Ci sono dei limiti? Probabilmente sì: tra questi il rischio di perdere la caleidoscopica veracità del dibattito, così lontano dall’immagine polverose del dibattito d’accademia (basti pensare che il già citato Simon, per difendere le sue tesi e smentire l’ecologista Paul R. Ehrlich, fece una scommessa da 1000 dollari che sarebbe durata dieci anni; e che avrebbe, infine, vinto). Il rigore e il minimalismo di Quentin, apprezzati non a caso da Emmanuele Carrere, rischiano insomma di inaridire un po’ la storia. Bisogna fare attenzione a non dare la precedenza al messaggio sul racconto. Ma è un rischio che Quentin tiene in considerazione e chiude un altro romanzo interessante e soprattutto intelligente.












