Cosa voglia dire per uno scrittore confrontarsi con la scrittura è questione meno pleonastica di quanto si creda. Il fatto della scrittura, non lo scrivere, e cioè la scrittura come presenza, come presente della tua attività di scrittore, è qualcosa che sfugge alle regole eppure è alla continua ricerca di un catalogo minimo di attrezzi utili. A uso delle nuove generazioni, come le sommosse e l’anarchia, ci ricorda un pedagogo belga. Martin Amis, d’altronde, ha reso bene questo esercizio, raffinato e intellettuale, in due volumi: Esperienza e La storia da dentro. Davide Bregola, che è scrittore ctonio ed evita le mode (e le località modaiole), ricapitola la sua vita di scrittore e il suo rapporto con la scrittura in un breve saggio romanzato, Lezioni dalle rovine (Avagliano, 2025), un’autobiografia non autorizzata dello scrittore, poiché egli di sé parla senza sapersi vedere come puro oggetto di indagine. È un’inchiesta personale, che incrocia amici, contati e un volume di studio che lo scrittore non sa esattamente quantificare finché non si ferma a pensarci. Perché non sono solo libri, ma scontri atomici con personalità spesso ingestibili. Una di queste è Vitalino Trevisan, che, per sua stessa ammissione fatta a Bregola, andava a puttane per non tradire la moglie. Un uomo che odiava, a quanto pare, la disattenzione altrui, perché così concentrato, così attento, e allo stesso tempo così eccentrico e straripante, da non reggere le contraddizioni altrui, di chi dice di ascoltarti e non lo fa.
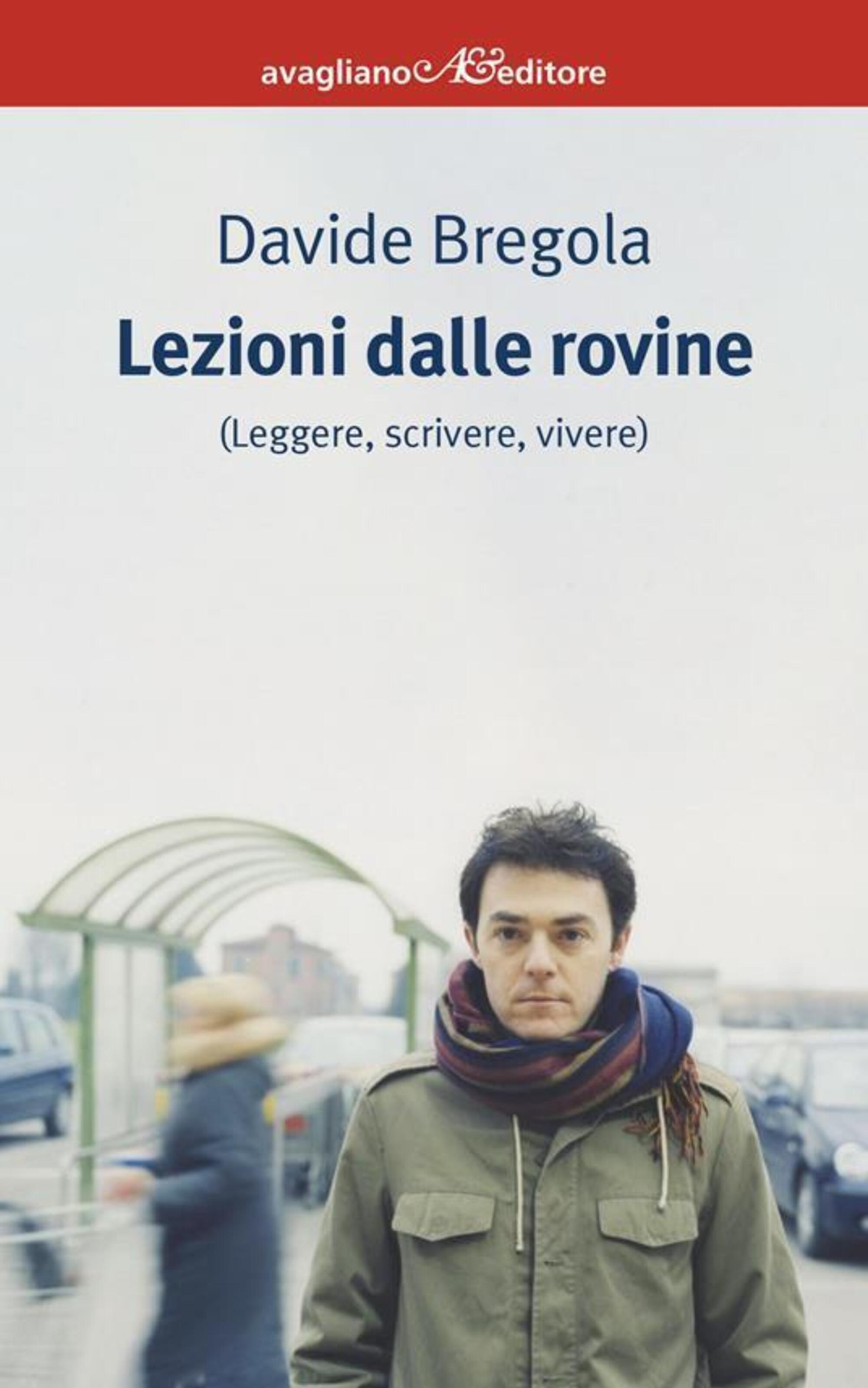
E poi quel sacerdote di Umberto Bellintani, che in qualche modo fa da marea inconspaevole di un Ulisse di fabbrica, che compra Le bucoliche di Virgilio per un professore di latino che poi vuole farglielo riportare indietro, poiché non apprezzava la traduzione di Agostino Richelmy (nome che impunemente la storia della letteratura ha per altro cancellato; ma di cui varrebbe ricordare la grandezza in poesia). L’amore giovanile in una libreria, secondo la logica adolescenziale e impacciata dei sentimenti che si mescolano agli ormoni e che annebbiano il cervello. La ricerca di Bregola è vitale, tanto che sentirà presto la necessità, curando una collana di libri per un piccolo editore, di riesumare scrittori nascosti o scomparsi, o entrambe le cose. Scrittori appartati, periferici, di confine. Scrittore alla fine dell’Impero, dove pulsava più forte l’autenticità e il vero fermento. Altro che città. Sì, Bregola, abbiamo detto, è uno scrittore che evita i luoghi – ma anche gli scrittori – modaioli. Così come evita di evitarne lo stile. È diretto, chiaro, ma non ammicca allo slang, al linguaggio dei social, alla lingua del suo tempo. Scrive come si deve (e cioè in italiano) e lo fa ricercando, per la sua scrittura, delle radici. Mentre la cultura d’accademia si muove in maniera rizomatica, come da copione postmodernista (più Guattari di Deleuze), lui va in direzione ostinata e contraria. Va all’osso degli alberi e della terra, dove c’è la frattura inconsolabile del nostro tempo, dove tutto pare fermo e invece è un continuo degradare, assottigliarsi, fino al punto che solo scrittori di grande sensibilità possono operarvi.














