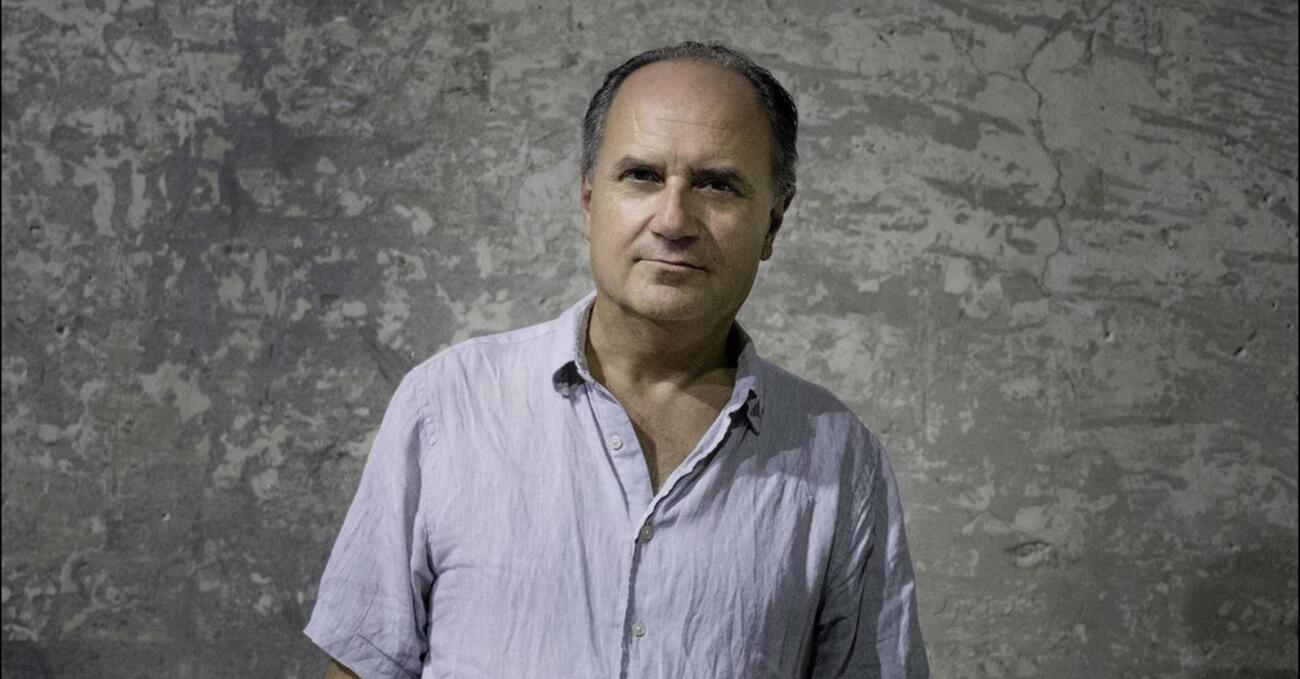Di Emmanuel Carrère si dice che abbia uno stile taoista, diretto, in cui la poesia non è data da – talvolta inutili – barocchismi e frasi auliche, ma da un approccio chiaro e trasparente rispetto alla vita. Claudio Damiani lo fa ma non nei romanzi, in poesia. Questo vuol dire almeno due cose. Uno: la poesia di Damiani è. Due: la poesia di Damiani è irrefutabile. Partiamo dal primo punto. Rinascita (Fazi, 2025), il suo ultimo libro, quasi un prosimetro, in cui però le parti in prosa seguono il ritmo dei versi, è un attestato di esistenza, la dimostrazione che il poeta vive, esiste, è presente al mondo (e il mondo gli è presente). E lo fa bilanciando il passato e il presente, rendendo la poesia lo strumento unico e più alto per attualizzare l’infanzia (quella nella città mineraria in cui il padre era direttore). È il ricordo di un pupazzo di neve, per esempio, che può essere una dichiarazione di poetica. “Dunque mio padre si chinò su uno dei lati piccoli e cominciò ad avvolgere il rettangolo come si avvolge un tappeto, e io, ricordo bene, rimasi di stucco, meravigliatissimo e mia sorella anche, e chi altro c’era là manifestò segni di stupore, non so se per far contenti noi piccoli o che altro. Quando mio padre ebbe avvolto tutto il rettangolo lo girò per l’altezza e lo piantò in terra, manifestando non so se a parole e non ricordo quali parole che il grosso del pupazzo era in questo modo fatto, e se ne andò. Poi facemmo probabilmente la testa, però non ricordo bene”.

È questo dimenticarsi della testa, puntare al cuore del ricordo e cioè al corpo e allo stupore, la poesia di Damiani. Una poesia che, tuttavia, con o senza testa, pensa. E lo fa al modo dei classici ma ancora di più di Petrarca, grande riferimento di Damiani, che considera il poeta agostiniano e umanista un campione di chiarezza e questo riprende, la musica che rischiara. Un pensiero luminoso, per immagini, talvolta con qualche piccola ripetizione (come non ricordare, allora, l’americano John Toland). Abbiamo detto Carrère non per pura associazione di idee. Lo scrittore francese, infatti, ha saputo fare del racconto uno strumento della meditazione. Allo stesso modo, il lungo racconto di Damiani, soprattutto a partire da Cieli celesti (e poi con Prima di nascere e quest’ultima opera), ha una risonanza intellettuale. “L’aria di quando ero bambino” sulle guance, di fronte a una casa “rotta”, è la pittura del poeta-bambino, cioè dell’uomo che guarda ai suoi primi anni di vita con empatia. Questo, nei poeti, è ancora più evidente che nei prosatori: ciò che è stato va vissuto con simpatia. In un certo senso Damiani comprende così profondamente la categoria di tempo da poterla sospendere a favore di un unico soliloquio dai caratteri poematica. La misura della poesia, come dell’amore, è l’eterno. E dunque in Rinascita conferma la sua vitalità antiaccademica e profondamente lirica, preferendo ribadire che la poesia deve tutto alla vita, persino i suoi lampi di genio; e che nessuna avanguardia, a fronte del dettato degli avi, può e potrà cambiare questa verità di fatto.
*
da Rinascita (Fazi, 20259
Non dire che la mia casa è triste,
non dire che la mia casa è sola.
Io l’ho lasciata, io non sono a lei più tornato
ed ecco lei è rimasta abbandonata.
Prima il tetto è caduto
poi anche i muri hanno incominciato a incrinarsi,
i mattoncini rossi del parapetto della scala
li hanno portati via,
hanno tolto le pietre ai gradini del patio.
Sono venuti i militari,
ne hanno fatto una piccola fortezza,
hanno messo del filo spinato, hanno sparato dei colpi,
tutto questo ha dovuto sopportare la mia casa.
Ma gli alberi intorno a lei sono cresciuti,
nel silenzio frusciavano le foglioline,
le ombre delle foglie accarezzavano i muri.
Ogni mattina l’alba, ogni sera il tramonto
sul patio la lonicèra profumava,
i fiori ancora fiorivano.
Il tetto lentamente cadeva, ma quante cose d’intorno,
quanta vita segreta che nessuno vedeva,
che nessuno sapeva,
facevano lieta la mia casa, riempivano la sua vita.