Umberto Eco è un raro cerbero della cultura italiana, erudito, simpatico, ironico, onnivoro. Un animale mitologico, che ha saputo resistere al fascino della specializzazione senza cedere alla truffa della tuttologia. Era quasi esperto di quasi tutto. Un autodidatta, un perdente, come si sarebbe definito, che tanto ha sbagliato e tante volte ci ha preso. Aveva letto bene Pierce e ha reinventato la semiotica. Aveva letto bene Aristotele e ha scritto un capolavoro come Il nome della rosa. Ha anche vissuto, raccontano gli amici, bene, e ha scritto della bellezza, della verità, della televisione e, pure, del dolore. Ora questo brevissimo intervento, Riflessioni sul dolore, viene ripubblicato da La Nave di Teseo, che sta costellando di piccole gemme gli scaffali della saggistica. È una controstoria del dolore, dall’antichità a oggi, quasi parallela a una storia della teodicea che attraversa elegantemente la cinquantina di pagine effetti del testo di Eco.
Una controstoria, si diceva, poiché come tutte le controstorie mira a raggiungere un obiettivo che non sia di puro godimento accademico: deve essere un saggetto sintetico ma utile, amabile, esistenzialista quasi. La tesi di fondo è che la storia dell’uomo sia una storia di emancipazione dal dolore, nonostante qualche alto e basso. Mentre nell’antichità il dolore, soprattutto quello fisico, era in qualche modo lasciato ai medici, con l’obiettivo di eliminarlo, il Cristianesimo ha poi fatto di un Dio-uomo, sofferente e brutto, il centro di una nuova antropologia, quella dell’imitatio Christi e cioè di una “compassione”, di un soffrire insieme; e attraverso il dolore, che va accettato, ci si avvicina a Dio.
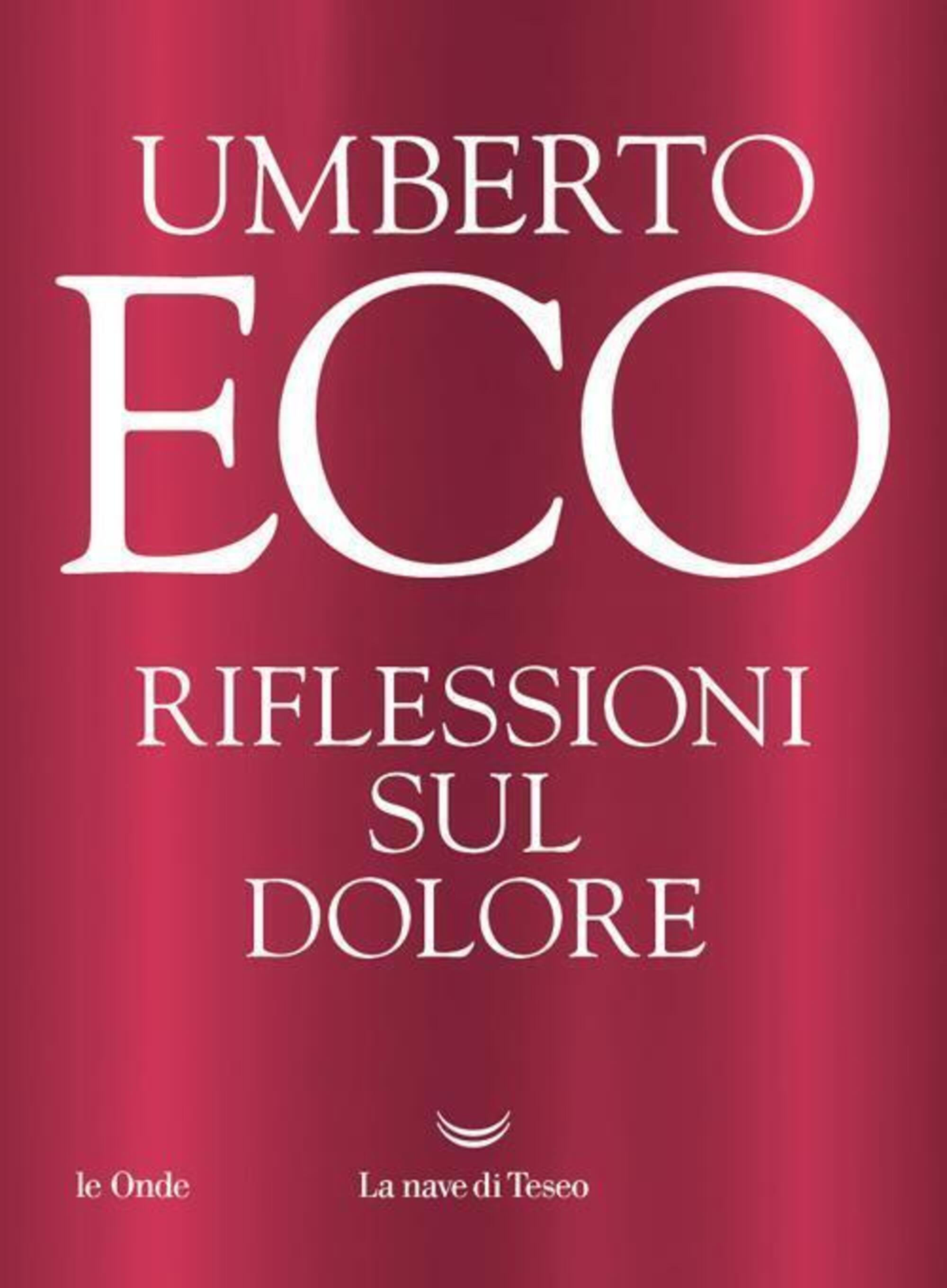
Il Romanticismo, poi, ha tenuto insieme le due anime, quella “pagana” di un dolore che va eliminato e quella “cristiana” di un dolore connaturato alla potenza stessa della vita. E poiché per i Romantici era tutto uno Sturm und Drang, allora dalla potenza avrebbe sempre ricavato quel dolore e di questo dolore si sarebbero doluti. Cosa spezza questo circolo vizioso? In breve, la scienza. Una conquista dei moderni è proprio questa: non tutto il dolore è necessario. Il parto doloroso come da dettame biblico? Inutile. L’amputazione? Non più un pezzo di legno in bocca ma l’anestesia. Ma questa anestesia, vale la pena di sottolinearlo, non è una fuga dalla realtà del dolore o alienazione. L’anestesia è la traccia fisica della conoscenza che abbiamo del dolore. “È cambiato il nostro atteggiamento rispetto alla sofferenza, non perché se ne neghi l’esistenza o perché si pensi di poterla eliminare quando diventa moralmente insostenibile, ma piuttosto perché si è deciso che è eliminabile quella eccedente, che potrebbe non esserci” (pp. 56-57).
È dunque l’anestesia o la conoscenza ad alleviare il dolore? La risposta di Eco è: entrambe. L’anestesia è efficace fin dove arriva, la conoscenza è efficace sempre. Anche quando siamo costretti a subire dolore, conoscerne il motivo è, secondo Eco, un modo per alleviarlo. Per questo, conclude, dovremmo sostenere (sovvenzionare?) una “educazione al dolore”, se vogliamo anche una educazione civica al dolore, che faccia sì, cioè, che si sia cittadini consapevoli nella comune patria delle emozioni. Questo, aggiunge, fino al prossimo mal di denti.












