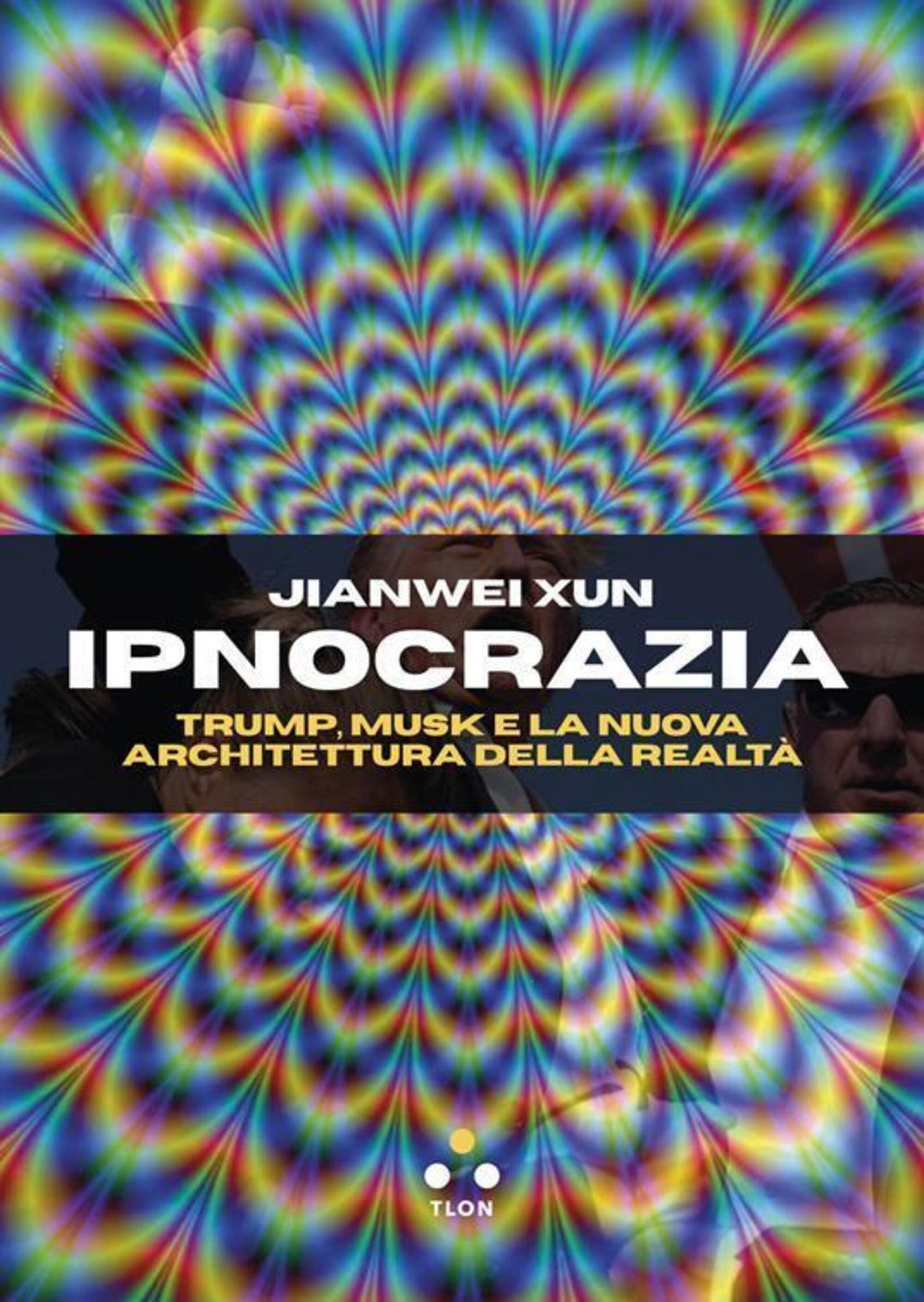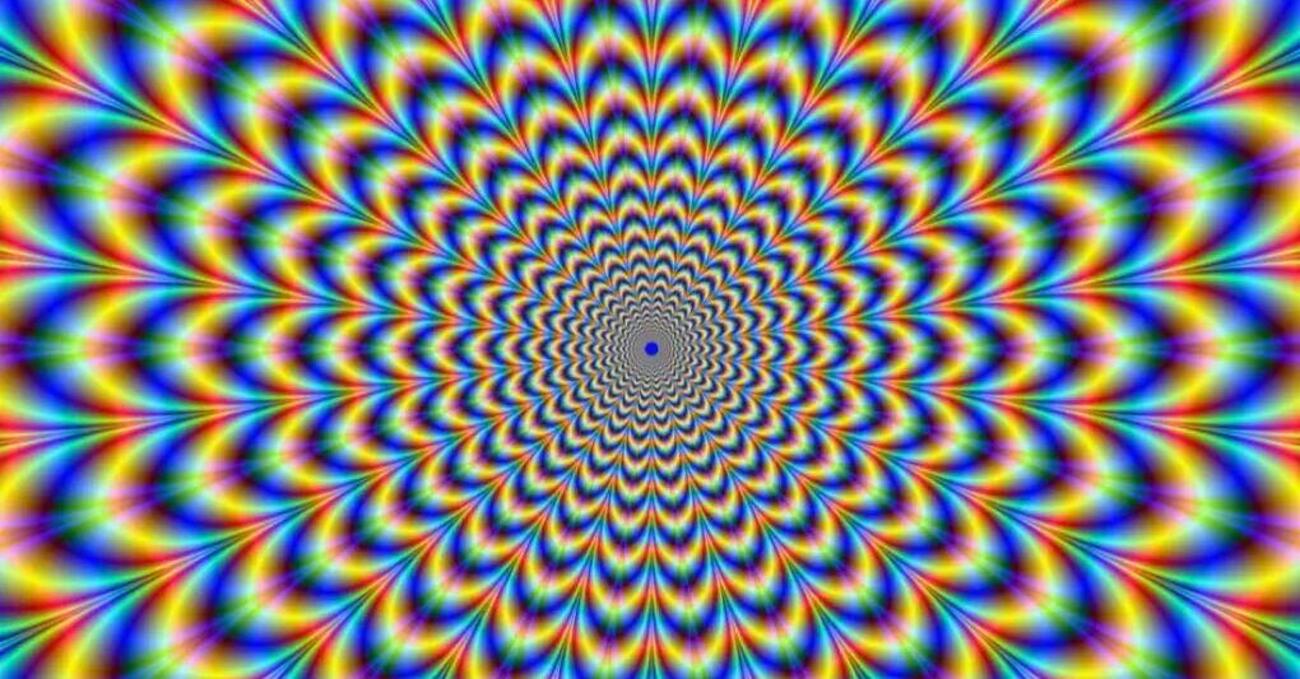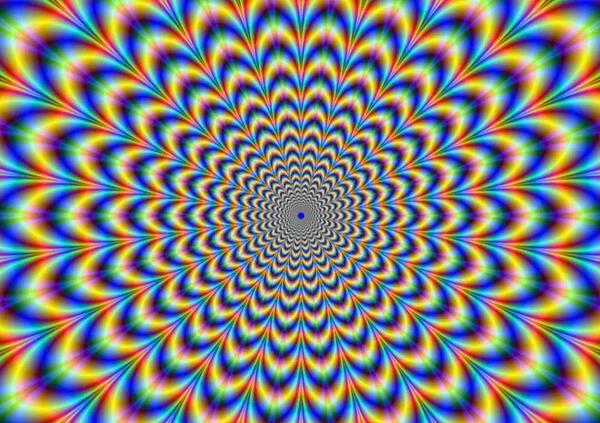Quando si parla di Ipnocrazia (Tlon, 2025) si parla evidentemente di qualcosa che o non si è compreso o si vuole necessariamente fraintendere. È vero Janwei Xun non esiste, l’autore di Hong Kong è un’invenzione di Andrea Colamedici e di chi lo ha assistito in questo progetto. Ma non è vero che Ipnocrazia sia stato scritto, come si legge sinteticamente sui giornali, dall’Ia. Colamedici ha scritto un pamphlet e l’ia, che di mestiere, da essere connivente e senza coscienza quale è (per ora), non ha fatto altro che aiutare Colamedici a scrivere il suo libro. L’editore di Tlon parla di “maieutica”, ma è stato piuttosto una sorta di dialogo allo specchio, dove il riflesso però dato dall’ia-specchio è leggermente deformato, più vasto ed enciclopedico probabilmente. In altre parole, il libro lo ha scritto Andrea Colamedici, lo ha aggiustato con l’ia, lo ha proposto agli editori (a conoscenza del piano) e ha rivelato al mondo, dopo qualche mese, la verità. Scoppia il caso, ne discutono tutti, per alcuni è una mossa di marketing (e con questo vorrebbero dire che è sbagliato; anche se – ragionevolmente – non c’è proprio niente di sbagliato in questo). Le idee in Ipnocrazia sono idee tloniste da tempo, perfettamente condivisibili da chiunque abbia letto e seguito la casa editrice negli anni; condivisibili anche da chi ha letto Byung-Chun Han, basti pensare a La crisi della narrazione (Neripozza, 2024). In realtà, in Ipnocrazia, l’elemento della novità, oltre all’espediente dell’ia, non è altro che lo stile pamphletistico, molto meno approfondito, più accattivante, più diretto, militante, che fa sì che certe idee ben note si siano ore prese un posto nel dibattito popfilosofico italiano e pare europeo. E si dica pure: pamphlet equivale, in questo senso, a esperimento, a stress test per la società letteraria.

La tesi principale di Ipnocrazia, in fondo, è che le varietà delle realtà siano incommensurabili, che le narrazioni (termine postmoderno) siano plastiche (vedi Catherine Malabou) e che, in un certo senso, la scrittura (il fare) queste narrazioni sia plasmare la realtà, crearne di nuove e dotarle di senso (e qui si veda la grammatologia di Derrida). Così si spiegano, secondo gli autori, l’autore, o l’autore e l’ia, le fake news e la manipolazione di chi è al potere: si creano realtà che acquisiscono un valore tale da permettere a certa gente, persuasa da quella realtà propagata, di votare materialmente un presidente come Donald Trump. Qual è la soluzione? Non è ritirarsi in un monismo dogmatico, tradizionale, ormai schiacciato dalla “pluralità dei mondi” della propaganda, del web eccetera eccetera. Ma affrontare, attraversare e, infine, far parte, di questa lavatrice di narrazioni differenti, essere prometeici e decostruiti, in un certo senso fluidi, e cioè avere la capacità di progettare la propria realtà, la propria storia, possibilmente di matrice sociale, comunitaria, e che quindi abbia un impatto sul reale. È la rivoluzione gaia di Mario Mieli, l’idea che il comunismo (gaio) debba non avanzare ma danzare verso il potere costituito, decostruendolo e ponendo, di contro, una nuova idea della realtà. In un mondo in cui esistono solo interpretazioni, non fatti, Ipnocrazia è il regime in cui le menti vengono gestite attraverso la gestione della capacità creatrice. Insomma, per ora, solo i potenti costruiscono narrazioni e realtà. Come ribellarsi? Riappropriandosi di questa possibilità e costruire al posto dei potenti.

Tutto questo prescinde completamente dalla scelta di inventare un autore con l’ia. Certo, può avere valore dimostrativo, come sostenuto da Colamedici e altri. Ma in realtà anche questo rispecchia un metodo più continentale che analitico, che si basa sull’idea che l’autore conti pure qualcosa nel discorso, più delle sue tesi. E invece, come abbiamo visto, altri autori parlano e dicono allo stesso modo ciò che un finto autore (ma in realtà Colamedici, perché l’ia non può ancora pensare) ha espresso in un saggio diventato popolare. Davvero il fatto che quell’autore non esiste costituisce un argomento di critica. Forse il modo migliore per bypassare il dibattito è immaginare Janwei Xun come un collettivo, in stile Luther Blisset/Wu Ming. C’è di mezzo un’Ia, ma ci sono di mezzo anche altri autori che, a prescindere da essa, avrebbero sostenuto, creduto e teorizzato gli stessi concetti. Tra questi un autore di Tlon molto giovane e coinvolto nel progetto, Giorgiomaria Cornelio, che nel suo ultimo libro, Fossili di rivolta, definisca la poesia come “arte degli intrecci e dei disorientamenti proficui”. È in questo abitare il disorientamento, invece che cedere all’alienazione, che si deve cercare il messaggio di Ipnocrazia. Si potrebbe dire che è togliere la poesia ai potenti (ai Musk, ai Trump, a chi gestisce l’attuale narrazione del mondo). Come farlo? Questo è un problema di prassi su cui spesso la cultura postmoderna non ha saputo dare una risposta sensata. Per Julian Assange, però, un libertario di tutt’altro orientamento politico (diremmo di destra), la risposta era una (e paradossalmente marxista): la conoscenza delle leggi della fisica, la competenza tecnica. Oggi diremmo il prompting (su cui non a caso Tlon sta da tempo ragionando).