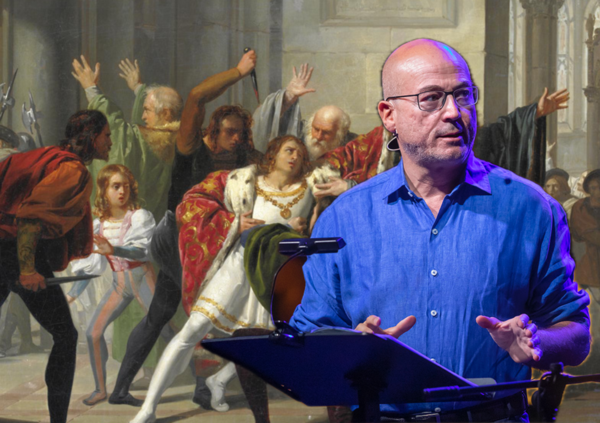Anne Appelbaum sul The Atlantic ha definito quel che sta avvenendo in America “regime change” e per spiegarsi scrive: «Le persone che lavorano per il governo federale americano stanno vivendo la stessa esperienza di persone che si trovano a vivere sotto occupazione straniera». Questa sensazione di straniamento dovuta a ciò che invece Donald Trump definisce “liberazione” (dalla sinistra woke, dagli eccessi dello statalismo ma, in definitiva, anche dal “moralismo” del servizio civile) aprirà una nuova stagione politica sia per gli Stati Uniti che per il resto del mondo, soprattutto se si cerca di rimanere lucidi sul tipo di relazione a distanza tra i due uomini più potenti del mondo, Trump ed Elon Musk, e le forze antidemocratiche nel mondo, dalla Cina alla Russia.
Il neoeletto presidente, da sempre imbambolato di fronte all’uomo forte del Kgb, ha davvero voglia di fare un favore al Cremlino imponendo un accordo di pace che sembra piuttosto un rimprovero per l’Ucraina: basta giocare con i nostri soldi, con le nostre armi e con il nostro know-how. Putin potrebbe anche essere disponibile a concedere al Paese invaso l’ingresso in Europa, che dovrebbe voler dire la fine di ogni futura guerra locale in quei territori (l’articolo 5 del Trattato Nord Atlantico prevede infatti che una guerra a un Paese europeo si trasformi in una guerra alla Nato stessa). Ovviamente Trump critica Zelensky che chiede un posto al tavolo delle trattative per il suo Paese: «Sei stato lì per tre anni. Avresti dovuto finirla in tre anni. Non avresti mai dovuto iniziare».


In un primo momento potrebbe sembrare un tentativo di concentrarsi sulla politica interna e una difesa della spesa pubblica americana, come fece nel 1987, da imprenditore milionario, comprando 100.000 dollari di spazio sui giornali per criticare la politica estera americana. Al tempo scrisse: «Perché queste nazioni non pagano gli Stati Uniti per le vite umane e i miliardi di dollari che stiamo perdendo per proteggere i loro interessi?», che è quello che pare pretendere dall’Ucraina quando parla di terre rare.
Ma questa spiegazione non rende conto delle nuove velleità neoimperialiste – sottolineate dal politologo Francis Fukuyama – di Trump verso Canada e Groenlandia, per esempio, o le sue dimostrazioni di forza nei confronti dei suoi vicini, a partire dalla sciocca volontà di rinominare il Golfo del Messico “Golfo d’America”. Allora serve un’altra teoria che vada più in profondità, oltre cioè la dinamica economica.
Una risposta che non si limiti ad analizzare un fenomeno a partire esclusivamente dagli interessi materiali potrebbe essere quella di Alexandre Koyré, che nel 1945 pubblicò un saggio di poche pagine intitolato La quinta colonna su Renaissance, una rivista gollista che alla fine della Guerra tentò di costruire un’alternativa culturale alla fiacchezza politica della Francia di Vichy, e cioè, per estensione, di tutta quella parte del mondo libero che accettò il nazismo o, peggio, contribuì a farlo crescere.
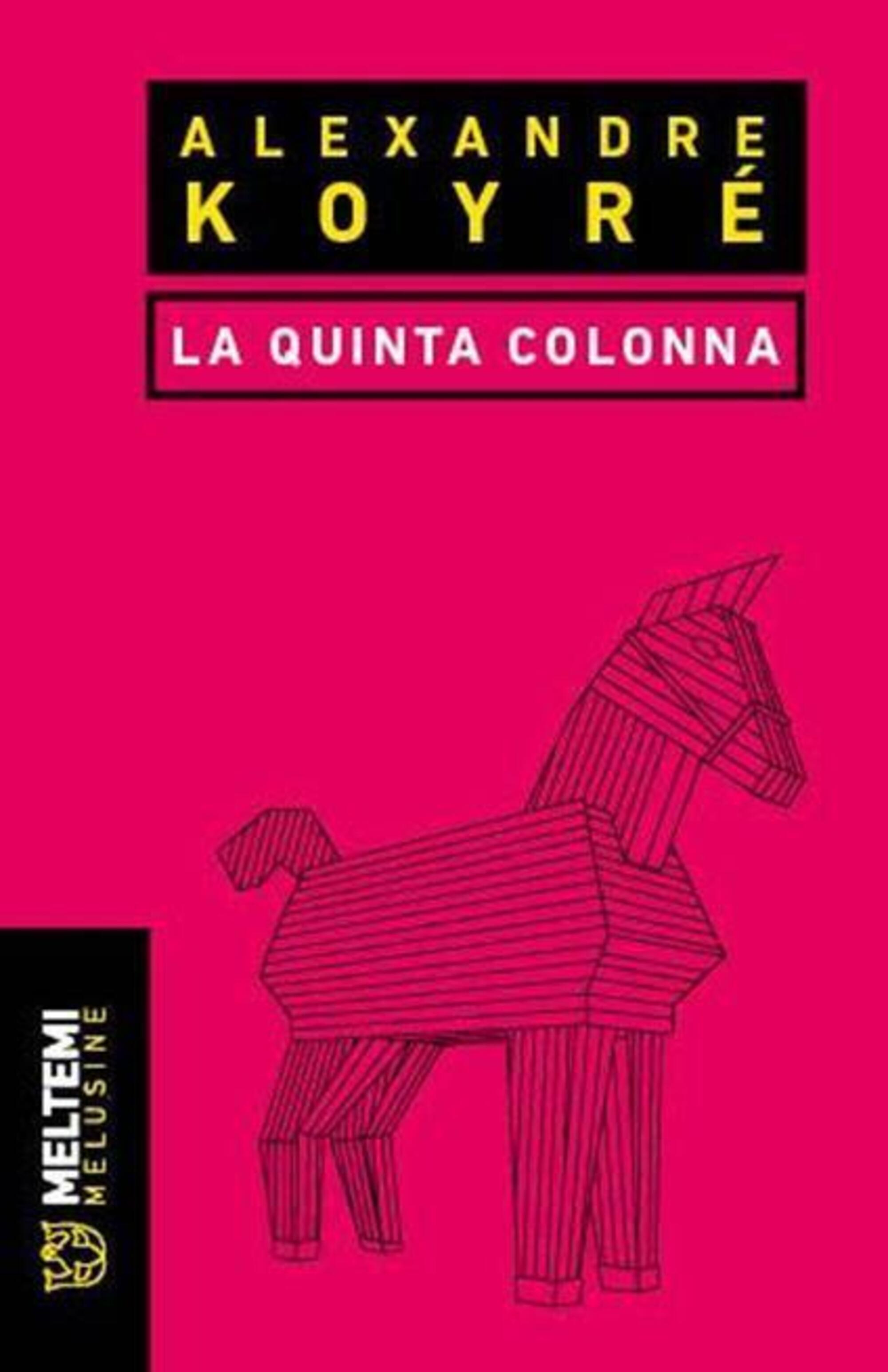
Ora il suo articolo è stato tradotto e pubblicato dalla casa editrice Meltemi. Nel libro si parla di “quinta colonna”, in riferimento alla presa del potere in Spagna da parte del generale Franco; si tratta di quella forza senza un vero capo, che colpiva la società civile dall’interno. Erano gli «amici del nemico» e cioè «nemici interni». Anche il nazionalismo (la liberazione dell’America di cui parla Trump), al contrario del patriottismo, diventa il carattere specifico di quella che Koyré definisce un fenomeno controrivoluzionario. Ma in che modo la “quinta colonna” può diventare il simbolo della frattura interna nelle società liberali e aperte?
La democrazia perde di appeal agli occhi delle oligarchie: «La cosa si può comprendere, d’altronde, pensando che il possesso è il valore supremo della società oligarchica (borghese), il patrimonio è il suo ultimo valore sacro, e uno Stato che non solo non li protegge, ma li distrugge o li mette in pericolo con le sue imposizioni fiscali (e di altro tipo) non è, dal punto di vista di questa società, uno Stato legittimo. È questa l’origine del fenomeno curioso e, a prima vista paradossale, della crescente disaffezione delle classi proprietarie – sostegno e fondamento della democrazia borghese – nei confronti della democrazia e della loro crescente ammirazione per le forme autoritarie dello Stato (per dirla con Platone: per lo Stato tirannico) alle quali, normalmente, dovrebbero essere ostili».
Vale la pena di continuare a citare lo stesso passo: «L’oligarca accetta di condividere il potere, e il cittadino cede il passo al possessore, rinunciando ai suoi diritti politici per ottenere protezione per i suoi beni materiali». Le analogie tra quanto descritto da Koyré e il crescente consenso, oltre che potere, di Elon Musk, sono evidenti. Il Doge stesso sembra un prodotto di quella mentalità che ha portato alla «crescente disaffezione delle classi proprietarie [di cui anche Trump, che non va confuso con un politico di professione, ndr] nei confronti della democrazia». Efficienza diventa così sinonimo di “regime change” per come lo ha inteso Appelbaum.

Tuttavia, per avere successo, questa “controrivoluzione preventiva” portata avanti da una quinta colonna di oligarchi, di disaffezionati alla democrazia («È anche, e altrettanto essenzialmente, un fenomeno di tradimento»), deve cercare alleati, possibilmente non democratici. E non li trova all’interno, spiega Koyré, li cercherà all’esterno: «Per sostenere una potenziale controrivoluzione, occorre una controrivoluzione in atto, in altre parole, un potere controrivoluzionario già affermato». E così comprendiamo anche le simpatie trumpiane e muskiane per oligarchie e dittature non americane. Abbiamo accennato agli accordi e agli atteggiamenti amichevoli di Trump nei confronti di Putin, ma possiamo pensare anche allo smantellamento, attraverso il Doge di Musk, di quelle realtà che nel corso degli anni si sono occupate di denunciare le ingerenze in America di Russia, Cina e Iran.
Capiamo, grazie a Koyré, anche perché Donald Trump stia spingendo per la pace ovunque: «Non certo per un sincero amore per la pace, ma semplicemente per l’incapacità di fare la guerra, a causa della paura che questi Stati provano alla prospettiva di rovinarsi». Mentre Koyré descriveva in questo libro l’ascesa al potere del franchismo in Spagna e del fascismo in Italia, allo stesso modo un italiano, Luigi Fabbri, parlava di “controrivoluzione preventiva” proprio a proposito del fenomeno fascista, e lo faceva in un saggio del 1922 che venne presto bruciato dal governo mussoliniano. Si deve a lui, probabilmente, l’invenzione di questo concetto, che presto si diffuse in tutta Europa. E vale la pena di recuperare, allora, anche le sue parole, che esprimono bene l’odio, e non l’orgoglio, che alimenta questi cambi di regime: «In realtà all'interno d'ogni Paese v'era per ciascuno qualche cosa, odiata più profondamente del nemico esterno».