Umberto Piersanti è tante cose e, quando si è così lapidari e diretti come siamo stati nel titolo e come faremo in questo articolo, è inevitabile che chi legge vada a ricercare i possibili “conflitti di interesse” di chi scrive e si spende con elogi così estremi. Per cui è bene partire da questo: Umberto Piersanti è uno dei miei maestri, uno dei miei primi lettori, uno dei primi poeti contemporanei che io ho letto. È anche un poeta che è stato tanto severo quanto onesto con me, in passato e sempre. Non mi ha fatto sconti, come si dice ora, con questa formula impoetica, da mercadante. Anche perché io non gliene ho mai chiesti. Ha scritto uno dei romanzi storici italiani più belli di questi ultimi decenni, commentato da Mario Luzi, il senatore e poeta tra i più grandi del Novecento italiano, così: “Grazie ad esso ci si addentra, questa è la parola giusta, nel mutamento epocale che si svolge sulle piccole cose”. Nelle estati marchigiane ci sedevamo al bar, bevevamo succo di melograno (di inverno era te e biscotti di pasta frolla), lui mi dettava articoli, poesie, brevi racconti, comunicati. Annie, la sua dolcissima compagna, mi prendeva e mi portava in auto alla stazione. Se dovessi tenere in conto tutto questo finirei, credetemi, per dare un giudizio completamente diverso di Piersanti. Perché l’umanità non cancella la poesia, è vero, ma la controbilancia a tal punto che più un poeta lo senti vicino, più potresti non accorgerti di quanto è grande. Quando amiamo il diverso, ciò che si tiene distanti, ciò che non conosciamo, che ci sembra altero, al di là di una teca. È l’effetto vip, che porta spesso ad avere con certi autori un atteggiamento reverenziale. E il solo fatto di averli conosciuti, per una foto o una stretta di mano, ci fa diventare megalomani. Se invece lo si conosce, un poeta, un poeta vero, se gli si vuole bene, allora si può imparare – anche se non sempre accade, per cui stavolta dovrete fidarvi – a separare l’uomo dal poeta. Tanto avrei da dire di entrambi che non avrebbe senso confonderli. Per questo, qui, parliamo di Umberto Piersanti poeta. Fine della lunga premessa.
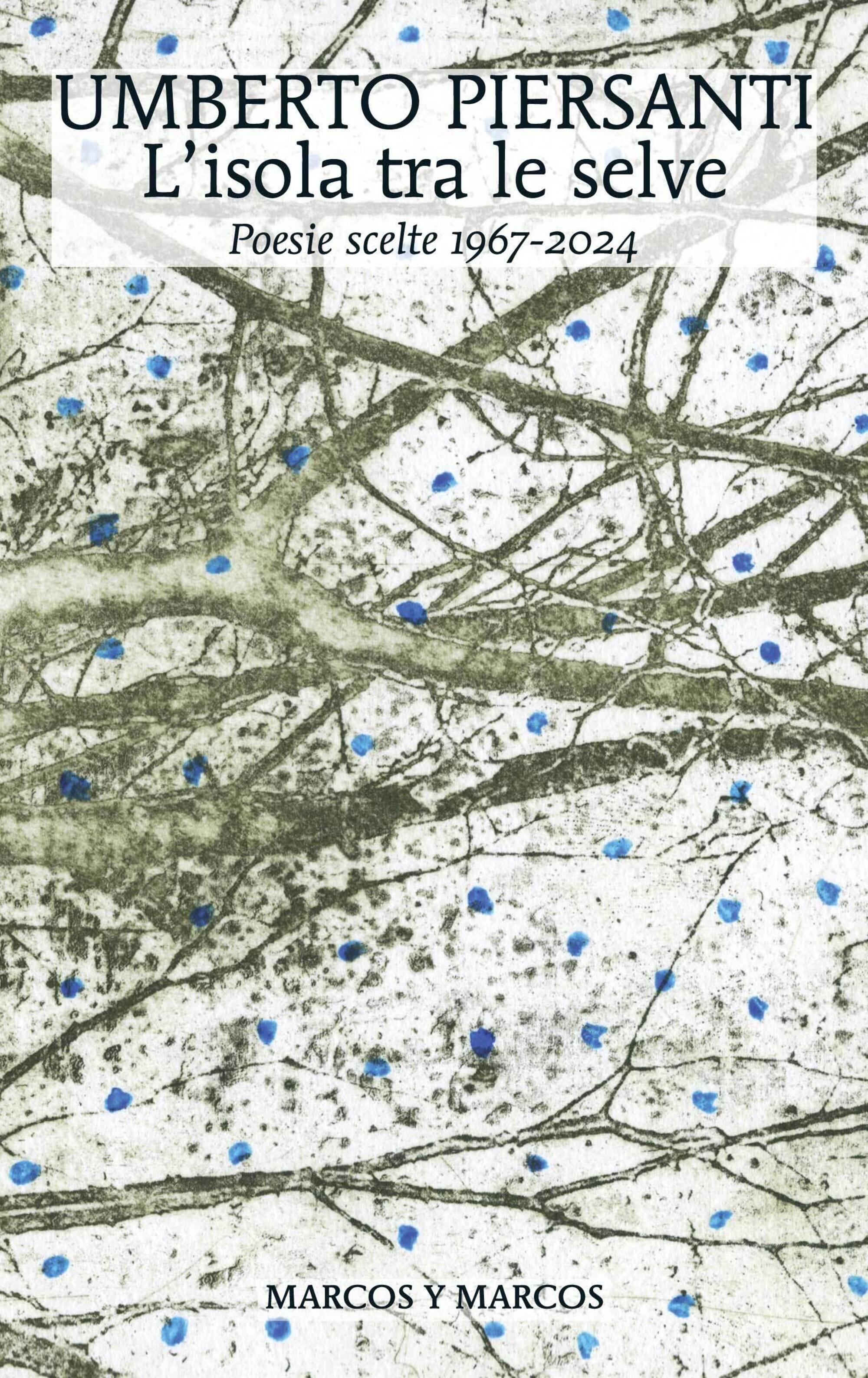
L’isola tra le selve (Marcos Y Marcos, 2025) è la sua antologia, che raccoglie cinquant’anni di poesia Piersanti ha conosciuto Giorgio Caproni, Maria Luisa Spaziani e altri grandi del Novecento. Ma, pur avendo scavalcato (e, se lo conosceste, sapreste con quale agilità) il secolo, è in un certo senso parte di quel gruppo di poeti che oggi consideriamo antimoderni, inattuali, figli di un’altra epoca. Eppure, mentre le avanguardie degli anni Sessanta puntavano al parricidio, a distruggere le radici, in un esercizio di amnesia che si è rivelato essere poco più di un gioco intellettuale buono, oggi, per entrare con un dottorato di ricerca in Lettere all’università, Piersanti di questa sua felice appartenenza non si è mai vergognato. Anzi, l’ha rivendicata, così come ha rivendicato la potenza di una tradizione orale, familiare, contadina, in cui la ragione era anche creatrice, in cui il mito serviva a fare ordine nel mondo, tra le Cesane urbinati, fino al punto da spingere un poeta ad accettare, con spirito democratico (lo stesso che Piersanti ha sempre difeso sul piano politico), questo dialogo onesto tra leggende, poesia e intelligenza storica: la ragione del cuore di Foscolo e la ragione leopardiana. La sua però è anche una storia naturale degli affetti, delle relazioni, quella con chi ha amato e ama, quella con il figlio, quella con un mondo che non c’è più e che rievoca passeggiando tra i boschi. È il favagello, questo fiore giallo e “clandestino”, che a suo modo resiste alle temperatura, una ginestra minore, che solo Piersanti ha evocato nei suoi versi. In quel fiore è racchiusa una dialettica tra presente e futuro, tra fioritura e memoria dell’autunno, dei rami secchi, dell’inverno (e della guerra, per esempio), che ha permesso a Piersanti di consegnare agli editori, ora a Marcos Y Marcos (prima a Einaudi), un’opera compatta, sostanziale, mai barocca, mai sperimentale, mai in trend. Oggi in Italia si fa altro genere di poesia: si guarda all’estero o si guarda a un Novecento plastificato, spesso legato alla poesia d’amore francese (grande poesia, oggi fraintesa anche perché appiccicata ovunque sui social). Piersanti, che ancora scrive e ancora, soprattutto, cerca il canto, è così il più grande, appartato e a suo modo eretico tra i poeti italiani viventi. Non accetta nessun compromesso con la modernità, se questo vuol dire piegarsi all’ideologia, alla “poesia-manifesto”. E perché dovrebbe, d’altronde, se è riuscito, con la sua poesia, a tenere accesa la brace di un tempo di cui ora è rimasto l’unico, antico, custode.

L’isola
Ricordi il mirto, fitto tra le boscaglie,
bianchissimo e odoroso, scendere per i dirupi
sopra quel mare? e le capre
tenaci brucare il timo, l’enigma
dello sguardo che si posa
dovunque e sempre assente?
più non so il luogo dell’imbarco
come salimmo nel battello
quali erano le carte per il viaggio.
Scendevi alta per lo stradino polveroso
antica come le ragazze
che portarono i panni alle fontane
la tua carne era bruna come la loro.
Férmati nella radura dove il vento
ha disseccato e sparso i rosmarini
qui potremmo vederle se aspettiamo
immobili alle euforbie quando imbruna
vanno alla bella fonte degli aneti
giocano lì nell’acqua e tra le erbe
e mai s’è udito un pianto
sono felici.
Tu eri come loro, solo una volta
quando uscivi dal mare, ti sei seduta
nei gradini del tempio, un’ombra appena
trascorse di dolore nella faccia.
Seppi così che il tempo era finito
che tra gli dei si vive
un giorno solo.
E riprendemmo il mare
normali rotte.
Qualcun altro s’imbarca, attende il turno
né l’isola sprofonda
come vorrei.
Gennaio 1990
Da “I luoghi persi”
*
Viola d’inverno
no, non tra le acque limpide,
le fredde erbe dei fossi,
ma qui, su questo greppo
scorticato da cancelli
e luci lattiginose
di lampioni nella strada sotto,
Natale se n’è andato
da un giorno solo,
un altro, intero anno
ormai trascorso,
la nebbia che si dirada
a tratti per un chiarore
tremulo e celeste,
scopre una viola
pallida e stupita
così fuori stagione,
d’ogni senso,
tra muschio lucente
e malva spenta
no, non metterla
nel presepio,
tra le brecce
bianche, i frutti rossi
di pungitopo, gli stecchi
secchi del dicembre
che bruciano nei forni
o sopra i monti,
non turbare l’inverno
che quella grotta tiepida
di fiati e paglia
illumina e riscalda
in questo stesso greppo
stento e scorticato,
un cespo di ciclamini,
il più tenace,
riluceva nel gelo
fino a dicembre
questa terra squallida
e contorta, profanata
dagli uomini e dai cani,
due fiori l’hanno scelta,
così segreti
ed appartati,
caso o necessità
non c’è risposta
in un tempo remoto
che la memoria cede
sempre al sogno,
fino qui scendeva
della prima casa
– Villa Gloria di vetri
colorati, di balconi –
quell’orto solo
e immenso,
col padre tra le canne
dei fagioli, le rose
e l’insalata
attorno al pozzo,
lo cerchia dell’infanzia
il vasto cielo
ma tra l’erbe inzuppate
d’acqua nera
più non scorgi la viola
il giorno dopo
e nella casa antica
sotto il fosso
quei morti appena nati
color seppia,
dal limbo che minaccia
li protegge
i cuori e gli altri segni
alle pareti
che senso ha la vita
per chi nella vita dimora
un solo istante?
la fatica del nascere
a che serve?
nata fuori stagione,
subito spenta,
questa viola d’inverno
mi rallegra,
la primavera cova
sotto il gelo
per quelli nati
e morti alle pareti
nessun annuncio c’è
di primavera,
ma il dono della nascita
permane
Dicembre 2009
Da “Nel folto dei sentieri”











