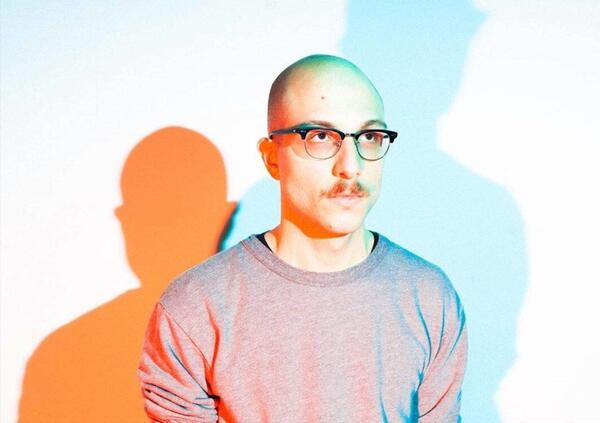Quando entro nella stanza dove faremo l’intervista, Anastasio sta rispondendo ai messaggi ricevuti su Instagram per l'uscita del suo nuovo album, Le macchine non possono pregare. Non dovrebbe sembrarmi strano – lo facciamo tutti – ma vedere un artista che si prende ancora del tempo per scrivere a chi lo ascolta non è banale né scontato. Apro il quaderno dove ho scritto le domande e lui mi fa i complimenti per la mia scrittura. Io invece vorrei fargli i complimenti per il suo nuovo album perché è uno di quei progetti che vanno ascoltati più di una volta per essere davvero capiti. E comunque, anche dopo diversi ascolti, ci sono delle sfumature che mi sfuggono e mi incuriosiscono. Ne parleremo durante la nostra intervista, tra tecnologia, pubblico medio – ma non per questo mediocre – e tanto altro. Le macchine non possono pregare non è “solo” un album, ma anche una graphic novel. “Questa storia, in 12 capitoli, chiedeva di essere raccontata anche con altri mezzi, e spero un giorno abbia anche una destinazione teatrale. Il fumetto è sinergico al disco, e insieme raccontano la stessa storia, ma con strumenti diversi. Questo album è un piccolo universo, e come tutti gli universi è espandibile: lo puoi raccontare in tanti modi, e non perde mai di senso”. Quando l'intervista finisce mi chiede "spero che il disco ti sia davvero piaciuto". A volte, lo confesso, mi è capitato di dire di sì anche se non ero realmente entusiasta, ma questa volta rispondo "sì" con convizione.

Nei tre anni passati dall’uscita di Mielemedicina a Le macchine non possono pregare sono successe diverse cose: ti sei laureato, hai viaggiato, hai scritto…
Ho anche oziato.
Sì, che è sicuramente importante. Non sottovalutiamo l’ozio. Come sono andati questi anni?
Ho lavorato all’album. Mielemedicina è uscito nel 2022, ma già da maggio 2020 preparavo questo nuovo progetto. Era già la mia ossessione, e lo è stato per quattro anni, finché non l’ho chiuso a metà 2024. È stata un’attesa snervante, perché ci tenevo davvero tanto, sapevo che aveva tanto da dire. L’ho avuto nel cassetto per così tanto tempo che ora che è uscito quasi non mi capacito. Poi ho fatto un sacco di altre cose: come hai detto mi sono laureato, in Scienze agrarie, forestali e ambientali, sono stato in India, un’esperienza che devo ripetere.
In Cyber-ciclope dici: “Se ci rifletti gli oggetti hanno la smania di essere vivi mentre i vivi si trasformano in oggetti”. Cosa intendi? Sulla prima parte non ho dubbi, la seconda vorrei che me la spiegassi.
La macchina ti automatizza, e finisce che finché sei utile hai un valore e poi, così come un vecchio tubo catodico obsoleto, puoi finire nella spazzatura. Finisci per essere tu l’appendice della macchina, invece che il contrario. Il lavoro fa questo. Da quando l’uomo è passato dal raccogliere le bacche nella foresta al coltivare, c’è stato una specie di piano inclinato che ha portato gli uomini a essere schiavi del loro stesso sistema.
Il ciclope ritorna spesso nell'album, perché?
È una figura omerica che viene descritta come un enorme mostro fortissimo ma dall’animo ingiusto, e stupido. Figlio di Poseidone, non riconosce né gli dei, né il sacro, né l’ospitalità. Quando arriva Odisseo, Polifemo se li vuole solo mangiare: capisce solo la pancia piena e quella vuota. Questo non è nient’altro che l’algoritmo, il grande agglomerato di dati che è potentissimo ma cieco, non capisce la vita. Non può capirla, perché le macchine non possono pregare.
Ti spaventa la tecnologia?
No. Di per sé no, mi entusiasma come mezzo. Sono un patito delle scienze, mi piacciono gli oggetti e l’ingegno umano. Chiaramente però questo entusiasmo non deve essere ingenuo, bisogna prendergli le misure. Il tema non è tanto se mi spaventa la tecnologia, ma se mi spaventa che, a un certo punto, l’umano possa perdere rilevanza, possa rattrappirsi.
Gli artisti all’estero stanno dibattendo sull’intelligenza artificiale e chiedono più tutele. In Italia potrebbe succedere una cosa simile?
Il tema dell’IA è gigantesco e ha tantissimi sbocchi: da quello filosofico a quello legale, anche etico e morale. Leggo di posizioni controverse, che da una parte mi affascinano, e di posizioni più prudenti, ma non mi sono ancora fatto un’IA (*ride*). So che non mi spaventa l’utilizzo dell’IA nell’arte, è uno strumento come un altro, formidabile. Siamo di fronte a una grandissima rivoluzione ed è normale che lasci grandi incertezze.

In Allora vattene invece dici: “Inchinati alle cattedre, impara a compiacerle e a non ribattere mai”. Questo discorso ci accompagna da quando siamo bambini, a scuola e in famiglia, fino a quando diventiamo adulti, con le istituzioni ad esempio. Per te forse vale anche per l’industria discografica?
Parlavo a tutti, perché è questo che ti dice il potere: se vuoi andare vattene, non ti tratteniamo, tanto andrai a sbattere comunque. Certo, fai le riverenze, lecca i cu*i giusti, inchinati alla cattedra e non ribattere sono le leggi per sopravvivere in questo mondo. Ovviamente è tutto ironico, perché l’invito è a fare tutto il contrario.
Il tuo è un disco complesso, emerge anche da quello che ci stiamo dicendo. In questo momento potrebbe essere un album “difficile” per l’ascoltatore medio. Cosa ti auguri per questo progetto?
Che sia complicato per l’ascoltatore medio (ride, ndr). Mi auguro che qualcuno possa essere affascinato da quello che non capisce di questo disco, perché chi l’ha detto che bisogna sempre capire tutto? Soprattutto: chi l’ha detto che l’ascoltatore medio è scemo? Secondo me non esiste l’ascoltatore medio. E basta pensare che il pubblico è stupido, e quindi bisogna dargli da mangiare cibo per stupidi per paura che non lo digerisca. Secondo me è un insulto al pubblico e all’arte in generale, farla per venire incontro a qualcuno per paura che non sia capita.
In 1848 (aboliamo il tempo) torna un discorso che abbiamo già affrontato: “Meglio in carcere che ammaestrati, meglio morti che morti di noia”. Torniamo al discorso sull’ozio, anche se è diverso dalla noia.
L’ozio è proprio il contrario della noia. “Meglio in gabbia che ammaestrati” è una frase orgogliosa del rivoluzionario, che dice: piuttosto che sfilare per il potere, preferisco stare dietro le sbarre. La noia è uno dei temi principali di Baudelaire. La rivoluzione del 1848 fu vista da lui come estremamente vitale. Una rivoluzione spirituale, in cui l’uomo reclamava il diritto di essere uomo, di non essere una macchina per la prima volta.
Con il brano che chiude il disco, La pioggia, mi hai ricordato vagamente i primi brani de Le luci della centrale elettrica. Qui dici: “Fu bello quando si spensero le luci perché il mondo non esisteva più”.
Si parla della fine di un mondo. C’è il grande tracollo alla fine del disco, dove si spengono le luci in un mondo che prima era iper-illuminato e dipendeva da questo dio elettrico. Poi collassa, si spengono le luci e sembra che sia finito il mondo. È come se domani ci fosse un blackout che spegne internet: a qualcuno sembrerebbe che non esista più il mondo. In effetti, un mondo non esisterebbe più.