In Guerra e natura umana (Il Mulino, 2025), Gianluca Sadun Bordoni si confronta, e smentisce, una delle tante massime di Denis Diderot, quella secondo cui la potenza è la somma delle forze: non è così, a meno che tra le forze non si inserisce una variabile incalcolabile, ma non per questo meno naturale e intima, che fa scoppiare le guerre al pari della volontà degli Stati o dei gruppi organizzati. Per Yuval Noah Harari al cuore della capacità dell’Homo sapiens di associarsi c’è il gossip, la capacità dir raccontare storie praticamente inutili ma fondamentali per la coesione. Eppure, in un libro più agevole, altrettanto chiaro, e per certi versi simili, il professor Bordoni, dell’università di Teramo, evidenzia un altro aspetto, per quanto non esclusivo della nostra specie, centrale: la capacità di aggredire, che è poi anche capacità di difendersi. Il libro pare dar ragione, con passione scientifiche e con ben pochi entusiasmi ideologici, a quel che è ormai la sentenza non scardinabile alla base della concezione “realistica” della guerra: si vis pacem para bellum. È interessante notare come due recensioni, che paiono tutto sommato delle stroncature, su Il Manifesto e L’Espresso, sfruttino abilmente le parole di Papa Francesco, il pontefice pacifista. Nessuno che citi, per esempio, le parole di Benedetto XVI, che nel suo Gesù di Nazareth mise in guardia da una pace pilatesca, una pace populista: “La pace fu in questo caso per lui più importante della giustizia. Doveva passare in seconda linea non soltanto la grande ed inaccessibile verità, ma anche quella concreta del caso: credette di adempiere in questo modo il vero senso del diritto - la sua funzione pacificatrice. Così forse calmò la sua coscienza. Per il momento tutto sembrò andar bene. Gerusalemme rimase tranquilla. Il fatto, però, che la pace, in ultima analisi, non può essere stabilita contro la verità, doveva manifestarsi più tardi”.
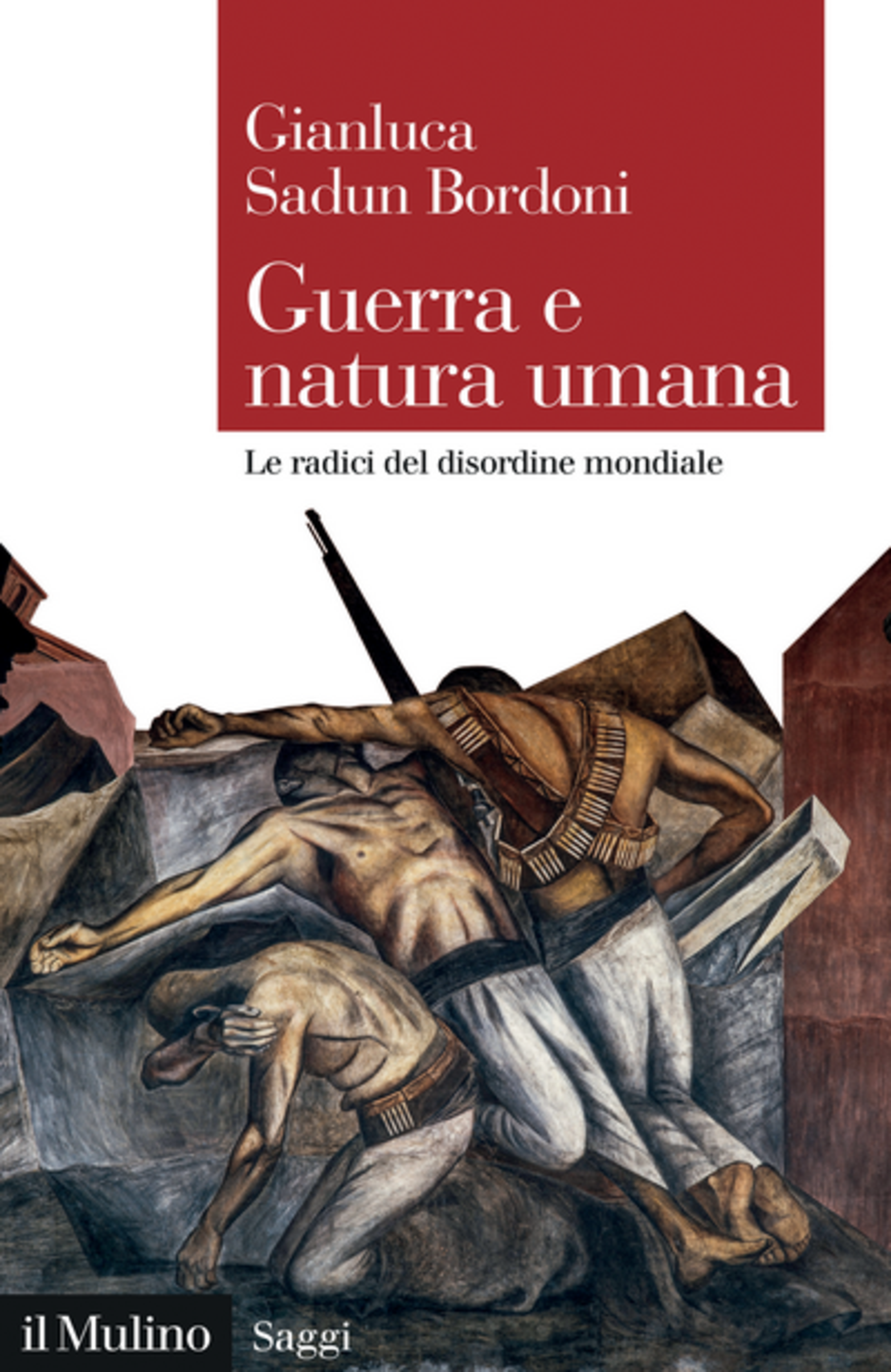
Non per dire che Bordoni sostenga nel suo libro voglia una guerra a tutti i costi per una pace giusta. In realtà fa il contrario, auspicando che l’Occidente non umili una seconda volta la Russia di Putin, una nazione fallita ma ancora una potenza nucleare. Lo dice anche, se vogliamo, concordando con chi, pur criticando l’impianto generale di Trump (penso a Niall Ferguson), vede nell’operazione di avvicinamento russo-americano una sorta di strategia nixoniana che mirerebbe in realtà a dividere Russia e Cina (come si vede ai tempi, cercando un’alleanza cinese in funziona antirussa). Su questo tenderei a non corcordare, perché se è vera la tesi generale di questo libro, e cioè che la guerra è inemendabile nel rapporto tra Stati e se è vero, come ancora si ripete, che la morte dello Stato-nazione è un mito degli anni successivi alla Guerra fredda, allora è necessario comprendere quale possa essere il ruolo attivo, non solo cautelativo, pilatesco appunto, dell’Occidente. Quale sia, in altre parole, il modello occidentale per i giorni futuri. Si fa difficoltà a tirar fuori questa terminologia, che sembra ispirata, e lo è per chi scrive, dai testi di André Gide e di Thomas Mann, invaghiti e persuasi che si dovesse cercare un concerto delle nazioni in grado di risuonare sulla maglia metallica dei rapporti internazionali. Perché Guerra e natura umana è un testo analitico. Eppure è forse questa l’unica cosa che manca in un testo che dovremmo dire hobbesiano e che per questo avrebbe dovuto, logicamente, far conseguire naturalmente dall’indagine scientifica una concretissima pars construens. Bordoni, invece, si limita (ma lo si dica con tutta la stima che si può immaginare: il suo è un “limite” da ricercatore profondo, serio, che non vuole darsi alla politica; semmai è chi lo critica – io – che alla politica, piuttosto che alla ricerca, deve necessariamente pensare e per questo criticare) a svelare le due grandi illusioni che ci siamo portati dietro, quella di un’età dell’oro (non esiste, siamo sempre stati violenti, fin dalla Preistoria) e quella di un futuro pacifico (non è vero, la guerra tende a diventare guerra assoluta, le capacità e lo sviluppo tecnologico rafforzano i gruppi che si sono evoluti, come spiega Darwin, per essere più abili nel conflitto). Accanto a esse la pia speranza di derivazione tolstojana che ci permetterebbe di distinguere tra un mondo della guerra e un mondo della vita, dell’uomo (che è quel che ancora ripete Bergoglio; da qui le citazioni in giornali che non vogliono più la guerra con la Russia o nessuna guerra in generale). Cosa resta allora? Per Bordoni la pietà, la capacità di intimorirci di fronte a futuri caotici (Rousseau). Ma noi ci sentiamo di aggiungere: la capacità di immaginare che la forza dei nostri Stati-nazione, per ora alleati militarmente, sia tale da poter difendere anche qualche illusione, come quella liberale, contro nemici che di questa visione – dei diritti, delle libertà, del pensiero – non condividono niente. Perché anche questa illusione, come la guerra, fa parte della natura umana.













