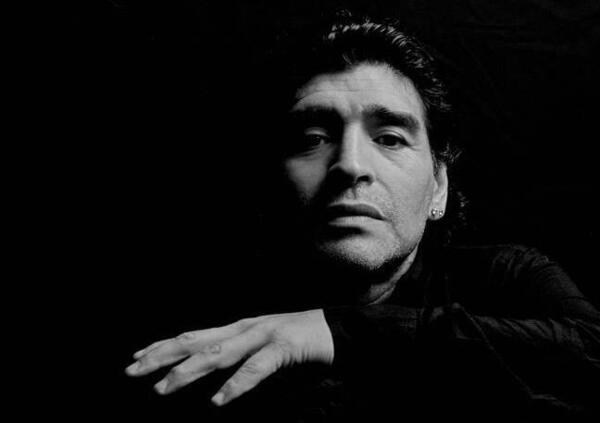Il dialetto napoletano nasce più o meno quando il Vesuvio era ancora un vulcano simpatico e Roma non aveva deciso di conquistare mezzo mondo. È figlio illegittimo del latino, ma ha flirtato pesantemente con il greco, lo spagnolo, il francese e pure con l’arabo, perché Napoli, si sa, è una città dal cuore grande e dal medesimo fascino e la lingua lo riflette. Nel Medioevo era già un bel miscuglio, e sotto gli Angioini ha iniziato a dire “oje” invece di “ehi”, con una certa classe. I Borboni l’hanno coccolato, tanto che a un certo punto era più importante del curriculum vitae. Poi è arrivata l’Unità d’Italia e il napoletano è stato messo un po’ in castigo, ma lui, testardo com’è, ha continuato a cantare, recitare e mandare tutti a quel paese con eleganza. Oggi, nel 2025, vive su TikTok, fa freestyle con i rapper e corregge l’italiano dei politici. È ancora poeticamente scurrile, irresistibilmente musicale e più vivo di uno spritz alle 19:00. La canzone napoletana nasce ufficialmente nel 1835 con “Te voglio bene assaje”, ma la verità è che a Napoli si cantava anche quando si costruivano le catacombe, la contraddizione nella contraddizione della Napoli velata. È il pilastro della musica italiana perché, diciamolo, prima che ci fossero le etichette discografiche, c’erano già i mandolini e le serenate sotto i balconi. Ha dato dignità poetica al cuore infranto, ha reso il dolore un’opera d’arte e trasformato il dialetto in lingua dell’anima. Da “’O Sole Mio” a “Funiculì Funiculà”, ha esportato il romanticismo con la stessa leggerezza con cui si frigge una pizza e ha trasformato in motivi canticchiabili l'attualità e la quotidianità della vita stessa della città con canzoni autoreferenziali.
Nel ‘900, artisti, poeti e compositori si sono dati appuntamento sotto il Vesuvio per creare un patrimonio musicale che fa ancora scuola. È altisonante perché ha toccato tutti: tenori, cantanti pop, persino crooner americani che non sapevano dove fosse Napoli ma ci hanno messo il cuore.
La canzone napoletana non è un genere: è un monumento sonoro, una dichiarazione d’amore all’umanità, con un pizzico di malinconia e una spruzzata di vino rosso come i lapilli. E quindi il dialetto napoletano nella musica di oggi come ci è arrivato?
Negli ultimi anni il dialetto napoletano ha fatto il botto, tipo fuochi di San Gennaro ma global, irrompendo ovunque. Da lingua del popolo a trend virale, è passato dal vicolo alla vetta di Spotify senza perdere l’accento. Merito di serie tv cult, canzoni che sembrano coltellate al cuore e artisti che ci sanno fare con le rime, ma anche della sua anima teatrale e tragicamente comica. È esploso perché è autentico, viscerale, pieno di immagini forti, con espressioni che sembrano scritte da un poeta ubriaco d’amore e caffè, il mondo si è accorto che dentro quelle parole c’è Napoli intera: caos, passione, malinconia, esoterismo e risate nello stesso minuto.
Musicalmente è un’arma segreta: la melodia naturale del dialetto abbraccia i generi, dal neomelodico al rap, passando per l’indie e il trap. Suona sempre come una canzone, anche quando stai solo dicendo che hai finito l’acqua. La sua cadenza canta anche nel silenzio, e la musicalità gli permette di aggirare la barriera linguistica: magari non capisci tutto, ma lo senti. E quello basta.
Proprio per questo motivo esistono moltissimi cantanti davvero giovani che scelgono il napoletano per lanciarsi sul mercato e in generale per raccogliere consensi, e questo in parte è un bene perché tendenzialmente se si canta in napoletano non si può contemporaneamente cantare in “corsivo” che è solo un mood, non una lingua. Pare invece che questo specifico dialetto stia sostituendo il senso che aveva prima cantare in inglese, forse perché è più melodioso ma allo stesso tempo non tutti lo capiscono, sta bene con tutto e tutti lo cantano ma ti senti più libero di dire quello che vuoi senza il peso del significato diretto delle parole. Una scelta molto furba e anche molto complessa per chi non è partenopeo, eppure ben riuscita.

Possiamo dire che il napoletano è diventato uno scudo per le canzoni? O addirittura che le canzoni in napoletano siano diventate l'oppio dei popoli per tendenza?
Credo entrambe le cose, e lo dico da napoletana molto stupita di quanto prima invece si prendesse in giro il medesimo accento o dialetto in ambienti più mainstream e meno folkloristici. Se le tendenze e la musica possono evolversi contro le aspettative stesse dei trend allora c'è speranza anche per la discografia italiana, o almeno, mi piace sperare e pensarla così.