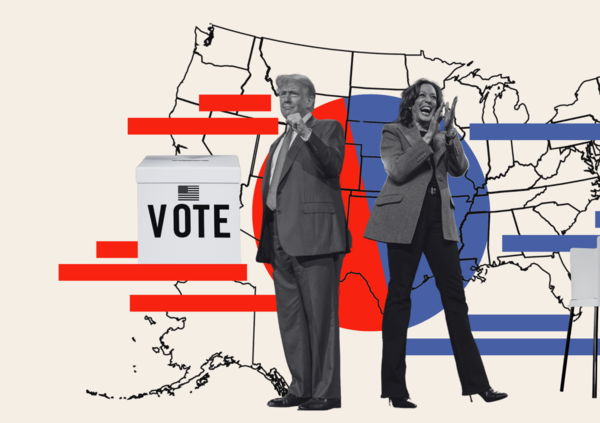E se il giornalismo lo salvassero i filosofi? Bello, ma difficile. Stavolta, però, sì. Questo particolare è importante per almeno due motivi. Uno degli autori del libro fondamentale uscito in Italia per capire Usa, elezioni, Kamala Harris, Donald Trump e la cosiddetta “America profonda” si è laureato in filosofia con Giulio Giorello e Salvatore Veca, forse il più importante filosofo della scienza e il più importante filosofo politico italiano (quello, per intenderci, che ha introdotto in Italia il pensiero di John Rawls). Quindi, il 50% del merito per un libro-reportage come quello di cui stiamo per parlare è di una filosofa (l’autore è, in realtà, un’autrice, mi si perdonerà il maschile neutro poco sopra) di formazione che ha potuto lavorare alla sua tesi insieme a due dei maggiori intellettuali liberali italiani (pure, tra l’altro, molto diversi tra loro); Maria Teresa Cometto. L’altro 50% è suo marito, Glauco Maggi, un hayekiano, un liberale davvero molto americano (mi sembra una categoria valida quando si parla di liberalismo: “davvero molto americano”, diverso da quello “davvero molto inglese” e ancora diverso da quello “davvero molto italiano”, che è una via di mezzo tra i primi due, meno scettico nei confronti del fenomeno del “consenso” rispetto a quello inglese – si veda J. S. Mill – e decisamente meno orientato al libero mercato rispetto a quello americano – si veda Rothbard o David Friedman, il figlio di un altro riferimento di Maggi, il Nobel per l’economia Milton Friedman). Il secondo motivo è questo: cosa serve per raccontare un grande Paese come l’America?


Qui non è Nuova York: 100 giorni nell’America profonda (Neri Pozza, 2024) è il libro che smonta la narrazione apocalittica intorno a un’America sull’orlo della guerra civile. Negli ultimi mesi si è confusa polarizzazione e uno strappo tra due parti del Paese. I sostenitori di Trump lo hanno fatto puntando sulla distanza tra i Democratici e gli “hillbilly” di J. D. Vance, gli americani fuori da New York, quelli che Cometto e Maggi hanno incontrato. I sostenitori di Kamala Harris, invece, hanno allarmato il mondo gridando all’allarme non solo per le libertà, ma anche per la salute dell’ambiente e dei cittadini. Eccola, la polarizzazione, una frattura su cui si è ricamato sopra al punto da lasciarci pensare che davvero, dopo queste elezioni, una guerra civile potrebbe aver luogo. Ce la immaginiamo come nel recentissimo Civil war, magari a partire da una seconda Capitol Hill. O ci immaginiamo qualcosa à la The boys, con un supereroe biondo (in questo caso un miliardario color arancio) stanco del pluralismo e della democrazia. Ma questa è, al massimo, buona letteratura (e, ipotizziamo, non una previsione). Cos’è, invece, certamente reale? Questo racconto in due puntate, una dedicata al Nord nel 2021 e una dedicata al Sud nel 2023, che ci ricorda perché l’America è ancora il Paese grandioso che continuiamo a fraintendere. Due storie, una per reportage, come esempi. Il primo parla della Portland democratica, delle grandi contraddizioni americane: “Da un anno il sindaco democratico di Portland, Ted Wheeler, sta cercando di riportare l’ordine in città. Nell’estate 2020, quella delle proteste per l’assassinio di George Floyd, Wheeler era d’accordo con il movimento ‘Defund the police’ (tagliare i fondi alla polizia) e con la decisione dello stato dell’Oregon di depenalizzare le droghe pesanti come l’eroina. Ora, dopo la fuga dalla città di negozianti e imprenditori, il record di omicidi e di morti per overdose, vuole vietare gli accampamenti dei senza tetto, impiegare più poliziotti, e concorda con la marcia indietro dello stato che ha ristabilito il reato di possesso di droga. Il che fa venire in mente la battuta del giornalista americano neocon Irving Kristol: ‘Un conservatore è un progressista che è stato aggredito dalla realtà’”.

Il secondo esempio ci parla del cosiddetto 1619 Project, la strategia di sensibilizzazione dei Dem, cavalcata da Kamala Harris tanto quanto dal New York Times, sul cosiddetto “razzismo sistemico” o endemico. In altre parole, la discriminazione come valore fondativo della democrazia americana: 16 agosto – Jamestown, culla della democrazia Usa o del razzismo? La narrazione sull’arrivo dell’Europa dei migranti che fuggivano dalle persecuzioni religiose ha reso molto più famoso e celebrato lo sbarco dei pellegrini del Mayflower nel 1620 a Plymouth in Massachusetts. Ma è Jamestown, fondata nel 1607, il vero luogo di nascita dell’America. È stato infatti il primo insediamento degli inglesi sul nuovo continente che sia davvero riuscito. Meno nobili i motivi dell’avventura transoceanica di questi coloni: speravo di trovare l’oro. Ma l’ottanta per cento di loro morì di fame, malaria e altre malattie. Questa terra, sulla sponda del fiume James, non era abitata dai nativi americani, che la consideravano inospitale, iena di zanzare, senza acqua potabile e inadatta all’agricoltura. I coloni arrivarono nel mezzo di una siccità che non si vedeva da settecento anni! Poi si ripresero scoprendo di poterci coltivare il tabacco, profittevole come l’oro. E nella stessa chiesa in cui si sposò Pocahontas, nel luglio 1619, si svolse la prima assemblea dei coloni per dotarsi di un governo: ‘la fondazione della democrazia americana’ spiegano i ranger del National Park Service. Invece, per gli evangelisti della critical race theory (la tesi sul razzismo sistemico degli Stati Uniti), le radici dell’America risalgono sì al 1619, ma per l’arrivo del primo carico di schiavi sulla costa vicina a Jamestown, portato da un mercante inglese che batteva bandiera olandese. Noi stiamo con i ranger”.
Post scriptum. Il libro, commissionato dal Direttore dell’istituto Italiano di Cultura di New York Fabio Finotti, evidenzia un aspetto curioso, come sottolineato sin dall’introduzione dagli autori: “Tutti amano l’Italia e sognano di venire nel nostro Paese!” E non solo pizza, mandolino, opere d’arte e grandi intellettuali. Anche i Måneskin.