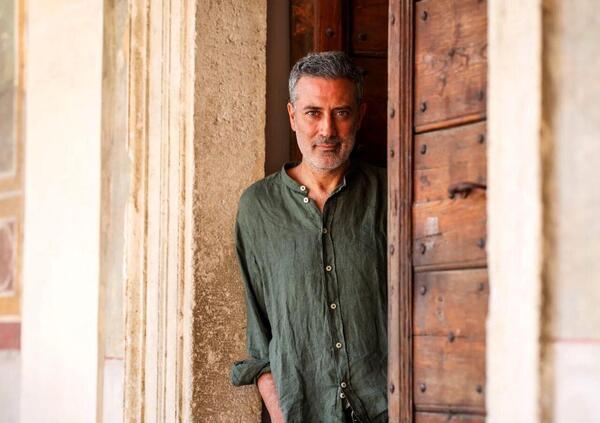Durante il suo recente concerto a Napoli, Willie Peyote ha fatto qualcosa che sempre meno artisti sembrano avere il coraggio di fare: puntare il dito contro un sistema che li sostiene (più o meno). Il rapper torinese ha sparato dritto sul CEO di Spotify, Daniel Ek, accusandolo pubblicamente per gli investimenti in tecnologie militari tramite la sua società di venture capital Prima Materia (ha investito 690 milioni di dollari per finanziare Helsing, una startup tedesca che produce droni militari) e per aver finanziato, con 150mila dollari, la festa d’insediamento di Donald Trump, come riportato dal quotidiano svedese Dagens Nyheter. Davanti a un pubblico che ascolta probabilmente la sua musica proprio su quella piattaforma. “Tutti gli artisti si schierano per dire Free Palestine, e tutti noi siamo su Spotify, ma poi nessuno parla di questa cosa. A me sembra un controsenso”, ha detto Willie. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una vera e propria ondata di attivismo da palco. Bandiere palestinesi sventolate ovunque. Ma a chi di loro interessa davvero? Non è che, in fondo, sia diventato solo un riflesso condizionato, una posa ideologica per sentirsi “dalla parte giusta della storia”? Un modo per mostrare sensibilità sociale e impegno politico, senza mai sfidare davvero il sistema che li sostiene? Certo, va detto: non è da tutti esporsi pubblicamente. E ogni gesto ha un valore, anche solo simbolico. Ma quando poi si scivola nell’omertà su temi come quello sollevato da Willie Peyote – ovvero il fatto che Spotify, piattaforma centrale dell’industria musicale, finanzi indirettamente la produzione di armi – allora il rischio è che l’attivismo diventi solo una facciata. E che il silenzio, dietro quella facciata, urli più forte delle parole. Ma qualcuno, in realtà, ha parlato. Il cantautore indipendente Auroro Borealo, ad esempio, ha scelto una strada radicale: ha rimosso tutta la sua musica da Spotify. Una mossa silenziosa, forse passata sotto traccia, proprio perché Auroro non è un nome da copertina patinata. Ma il suo gesto è reale. Gli costa visibilità, gli costa soldi. E per questo merita rispetto. Anche Piero Pelù si è espresso, definendo “inaccettabile” che un uomo così centrale nell’industria musicale investa nella guerra.
E noi? Gli utenti, gli ascoltatori, i milioni di abbonati che ogni mese pagano Spotify per avere musica illimitata, senza pubblicità, senza nemmeno farci troppe domande. Siamo parte di questo ingranaggio? Quante persone cancellerebbero davvero l’abbonamento per una questione etica? E soprattutto: quanti sono davvero informati su dove vanno a finire i loro soldi? Perché Spotify non è l’unica azienda sotto accusa. Coca-Cola, Nestlé, Carrefour, Disney, Lego, Starbucks: la lista dei brand che, in un modo o nell’altro, hanno legami con industrie belliche o operano in contesti controversi è lunga. E allora la vera domanda diventa: quanto siamo disposti a rinunciare per coerenza? La verità è che il sistema è costruito per renderci complici. Consapevoli ma pigri. Informati ma rassegnati. E in fondo, tanto vale continuare a scrollare, a premere play, a indignarsi un po’, ma solo fino alla prossima canzone. E infine, la domanda più scomoda: perché Willie Peyote è ancora su Spotify? Le parole sono importanti, certo. Ma non bastano. Se davvero si crede in quello che si dice, allora viene da chiedersi: qual è il prossimo passo? Perché la coerenza, quando si parla di etica e giustizia, non può finire sul palco o nei post virali. Forse è utopico pensare che un artista possa, da solo, sfidare un colosso come Spotify. Ma se non cominciano loro, chi dovrebbe farlo? Se non cominciamo noi, quando? Willie ha acceso una miccia. Ora tocca vedere se qualcuno – artista o ascoltatore – avrà il coraggio di far esplodere davvero il dibattito. Oppure se tutto resterà confinato in uno sfogo sul palco, con buona pace della Palestina, della coerenza e della musica.