E se la letteratura fosse quella cosa che sta tra il salotto degli Amici della domenica e un bar di paese? Non proprio. A dire il vero la bilancia pende più verso il secondo. Almeno è così per Paolo Nori, finalista del Premio Strega 2025 con Chiudo la porta e urlo. Lo ha scritto lo stesso autore sul Fatto Quotidiano: “La letteratura, e anche i discorsi, sulla letteratura, non vengono bene dai palchi, vengono bene dai bar, per esempio”. Tra coloro che hanno ispirato questa idea c’è “Raffaello Baldini, il poeta sul quale ho scritto il romanzo che ha partecipato allo Strega”, lui che “era figlio di uno che aveva un bar, il Caffè Trieste, e tre frequentatori di quel bar, Raffaello Baldini, Nino Pedretti e Tonino Guerra, son poi diventati tre tra i più importanti poeti del Novecento, chissà cosa gli davano da bere, al Caffè Trieste, per provocare quei discorsi così potenti”. Giorgio Manganelli, dice Nori, ha poi trovato la sintesi: “Bisogna arrivare a parlare di cultura come si parla di figa”. Sempre sul Fatto l’autore svolge la sua riflessione sullo Strega a partire da un incontro con un suo lettore: “Mi ha detto ‘Grazie per i suoi libri nei quali ripete sempre le stesse cose’. Che io, gli ho stretto la mano gli ho detto ‘Ah, ma pensa. Prego’. Ero un po' spiazzato perché è vero, che nei miei libri ripeto sempre le stesse cose, e lo dico anch'io, ma se lo dico io è un conto, sentirlo dire da un lettore non sai se è un complimento o un insulto, forse è un ‘complinsulto’, neologismo che credo sia stato creato da un partecipante a X-Factor, qualche anno fa”. E sono proprio i talent il punto centrale della questione. Perché lo Strega, “in un certo senso, è un talent”.
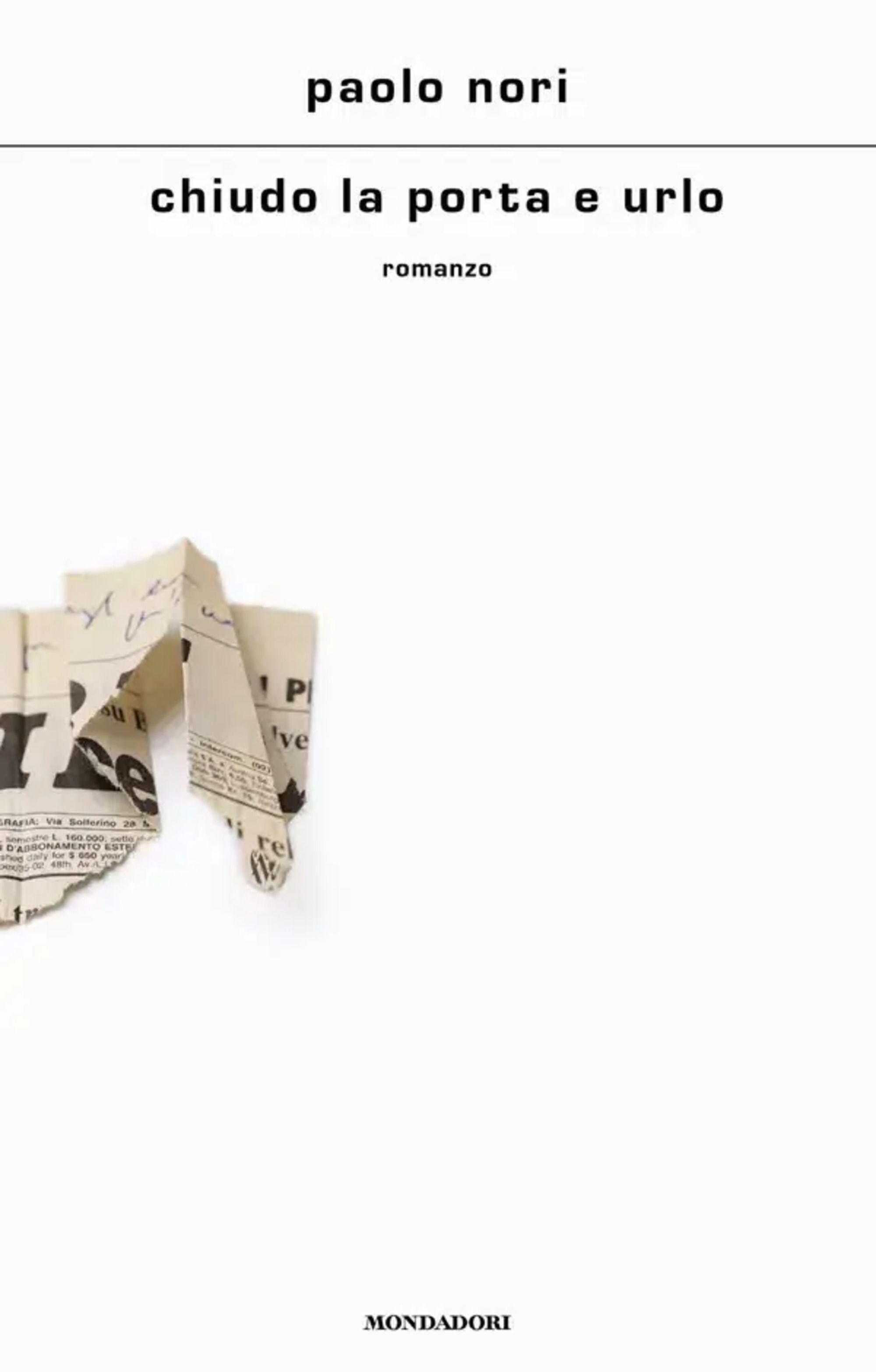
“Cioè, in letteratura, secondo me, non ci sono punti, anzi, ci sono, ma non sono quelli più in alto, le cose non le vedi bene dai palchi delle autorità, o del premio Strega”; e infatti la letteratura si trova più volentieri “nella spazzatura, nei cassonetti, negli ospedali, sui filobus, nelle sale d'attesa degli ambulatori veterinari, nei bagni dei cinema, nei sottopassaggi abbandonati, sotto i cavalcavia, nei prati dopo che avevan smontato i tendoni dei circhi, nelle tabaccherie, nelle collezioni di francobolli, negli espositori delle cartoline, nei pavimenti dei bar quando eran cosparsi di segatura, nelle file alle casse dei supermercati, sui marciapiedi delle stazioni, in tutti gli uffici di oggetti smarriti, nella paura di chi faceva una cosa per la prima volta, un farmacista, o un medico di guardia, o uno scrutatore, o una bambina delle medie, nel passo di quelli che davano le dimissioni, nel respiro che si prendeva prima di aprire l'esito li una lastra ai polmoni, nel toccare i muri quando era saltata la luce”. Il tutto, possibilmente, senza “sbriciolare”: “Questi giorni, allo Strega, ho passato il tempo a sentirmi dire come son bravo, come son belli i miei libri, come sono intelligente e sensibile, poi, ieri notte, sono tornato a Bologna, la prima cosa che mi ha detto la mamma di mia figlia, che chiameremo Togliatti, è stata ‘Non sbriciolare’”.













