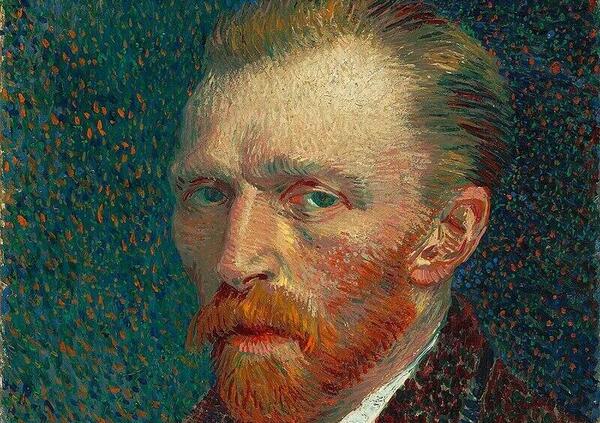La provincia italiana è da sempre luogo di ispirazione per il cinema e la letteratura: come dimenticare il film “Ossessione” di Luchino Visconti, ambientato nella Valle del Po, o l'Alberto Moravia de “La Ciociara”? La provincia italiana, insomma, non è poi così male se uno la sa raccontare, ovvero se sa cogliere, nella semplicità delle sue storie, gli elementi universali in grado di rendere i personaggi capaci di suscitare empatia e immedesimazione a tutte le latitudini. Il problema è che nei romanzi di Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del Premio Strega 2024, la provincia resta l’orizzonte unico del racconto, la matrice locale non diventa mai eco di domande più generali, e così dalla provincia si scade nel “provincialismo”, uno dei grandi mali che affligge la nostra attuale industria culturale. “L’età fragile” non fa eccezione: la rappresentazione che l’autrice fa della natia provincia abruzzese è fatta di opaco rispecchiamento, di campanilismo moraleggiante, che traspare nella volontà di preservare un “piccolo mondo antico” contrapposto alle insidie di una scialba modernità (il campeggio del Dente di Lupo contro l’edilizia spietata) e dalla presenza di un’antica violenza oscura contrapposta alla purezza del Bene, in una dialettica manichea talmente semplicistica da giustificare pienamente la definizione di “prof. di sostegno morale” affibbiata all’autrice dal marchese Fulvio Abbate. Per capirci: nel 2014 Nic Pizzolato, ispirandosi a una vicenda di pedofilia nella provincia della Louisiana, ha dato vita alla serie “True Detective”. Ma la Louisiana di Pizzolato non era solo lo sfondo di un racconto nero della provincia a stelle e strisce, fatta di paludi e alligatori, di strade deserte e tossicodipendenti senza futuro, ma la metafora di una riflessione esistenzialista sull’eterno ritorno del male, sul nichilismo che assedia la cultura occidentale, sulla liceità dell’esistenza stessa della razza umana sul pianeta, visto quello di cui è capace.
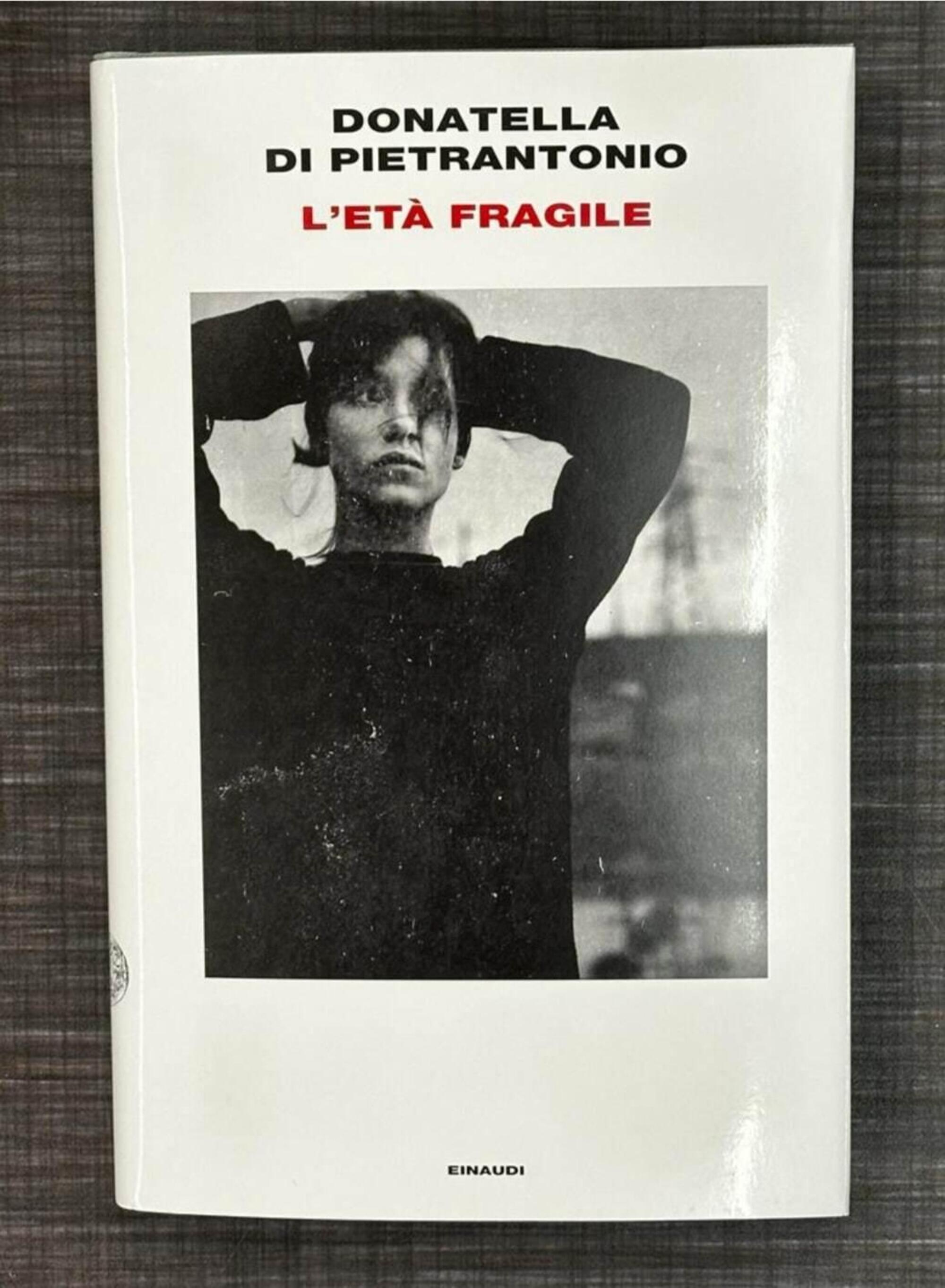

La matrice del male della Di Pietrantonio invece non viene né problematizzata né messa in dialogo con l’ordinarietà del male presente. Il racconto non va oltre l’odore del tinello dei sottani, il pettegolezzo del paese, i nomignoli degli anziani, secondo uno spartito di superficialità dove leggendo una pagina si indovina già quanto accadrà nella successiva. Si guardi alla struttura del romanzo: una linea orizzontale che racconta di una nuova ‘arminuta’, Amanda, scappata da Milano causa Covid nel 2020 per tornare a vivere dalla madre Lucia in Abruzzo. La vita di Amanda è il pretesto per una backstory che occupa oltre metà del romanzo e ripercorre la cronaca di un efferato doppio femminicidio avvenuto sulle montagne dell’Abruzzo negli anni ’90. Siamo, insomma, nella cucina del marketing editoriale, alla prese con una ricetta che è un grande classico contemporaneo: il genere true crime che spopola nei podcast e nelle serie TV, la strizzata d’occhio al tema della maternità, il riferimento all’attualità recente, con il covid e le sue ricadute sugli adolescenti, ovvero uno degli aspetti post-pandemici più censiti, secondo qualsiasi psicologo scolastico. E si che il dramma, in questo caso, era servito sul classico piatto d’argento: il tema morale archetipico del senso di colpa del sopravvissuto, rappresentato da una domanda di fondo alla base di ogni survival story: fino a che punto è legittimo spingersi per la propria sopravvivenza? Peccato che invece di svilupparlo alzandone progressivamente la posta in vista di un climax risolutivo, il tema sia diluito in una nebulosa di dichiarazioni di intenti pedagogici e che, in termini drammaturgici, non si spieghi la variazione macroscopica operata dall’autrice rispetto ai fatti reali, una modifica sostanziale delle geometrie delle vittime che depotenzia la ferocia drammatica del fatto reale.

Di Pietrantonio si è ispirata al delitto del Morrone, un femminicidio avvenuto il 20 agosto del 1997: ad essere brutalmente uccise da un pastore macedone nel bosco di Mandra Castrata furono due amiche, Tamara Gobbo (la Doralice del romanzo) e Diana Olivetti. L’unica a salvarsi, diventando testimone chiave per la risoluzione del caso, fu Silvia, sorella di Diana, che si era finta morta dopo che un colpo di pistola l’aveva colpita, restando immobile nello sterpame mentre udiva le urla della sorella. Ci piacerebbe chiedere a Di Pietrantonio: secondo quale logica ha deciso che a salvarsi fosse Doralice, ovvero Tamara ovvero l’amica, e non la sorella di una delle vittime? Se il tema deve essere il senso di colpa, è evidente a chiunque che il senso di colpa di un consanguineo sarebbe stato superiore rispetto a quello di un’amica. Solitamente, quando si utilizza un fatto reale per scrivere un’opera di finzione, si utilizza il procedimento inverso, ovvero si modifica liberamente il fatto per alzare la posta drammatica e morale. L’autrice-dentista invece sceglie, deliberatamente, di depotenziarlo: perché? Stupisce che nelle centinaia e centinaia di interviste a cui sono sottoposti i candidati al premio Strega, che passano un paio di mesi a girare per l’Italia come la compagnia di un circo, nessun giornalista/blogger/booktoker eccetera abbia chiesto conto di questa scelta spericolata; ma del resto è già difficile trovare qualcuno che legga i libri da cima a fondo, pretendere che facciano anche ricerche è effettivamente troppo, visto come funziona oggi la critica letteraria in Italia. Resta, comunque, la domanda cruciale: perché, a differenza di quanto accadeva ai tempi di Visconti e Moravia, la cultura italiana – salvo un paio di eccezioni – non riesce a uscire dai propri confini? Perché una storia nera così profondamente radicata in un territorio provinciale e suggestivo, come il Dente di Lupo, non riesce a trasformarsi in racconto universale del male, come invece riescono a fare gli americani, con le loro serie Tv. Probabilmente, a furia di guardarci l’ombelico, siamo diventati incapaci di guardare in alto.