Sono morti tre sbirri e altri ne sono rimasti feriti a Verona durante un servizio di sgombero in cui una famiglia - già nota da tempo e dichiarata pericolosa - ha messo in piedi una roba degna di una organizzazione terroristica. Altri sbirri, ma vestiti di un altro blu, si sono scontrati con i manifestanti per la pace in tempo di pace che hanno approfittato di una partita di pallone per fare la guerra. Sì, è tutto dannatamente assurdo, ma chi scrive ha una certezza: siete fermi alla parola “sbirri” e tutto il resto è quasi passato in secondo piano. Da una parte quelli che all’uso di quella parola provano un piacere quasi erotico-ideologico e dall’altra quelli che, invece, ne rimangono accecati ogni volta. E in mezzo? Probabilmente tutti quelli che non li chiamerebbero “sbirri”, o “poliziotti”, o “carabinieri”, ma semplicemente “uomini”, “padri”, “lavoratori”. Solo che in Italia funziona così: è tutto una partita di pallone dove ormai esistono solo le curve, con i loro ultras. E in tribuna non c’è più nessuno. O, se c’è, è ignorato. Anche se ha pagato di più, anche se è più autentico. Anche se è più numeroso. Spezzi una lancia in favore dei valori? Sei fascista! Ti emozioni quando vedi la bandiera? Sei fascistissimo! Consideri l’Arma qualcosa di sacro perché ci identifichi quei carabinieri in provincia che t’hanno insegnato tanto sulle regole (quasi facendoti da padre) anche se contestualmente ti sequestravano il motorino truccato e le cannette? Allora sei veramente più nero della pece perché oggi gli dici “grazie” invece di odiarli. E idem l’esatto contrario: pensi che debba essere riconosciuto lo stato di Palestina? Sei un comunista! Non ti piacciono le divise? Sei un comunistaccio! Consideri i diritti civili qualcosa per cui vale la pena lottare? Allora sei veramente più rosso del sole dell’avvenire.
Un paese diviso – ma comunque incapace di rivolte parricide piuttosto che fratricide – lo siamo da sempre, ma oggi la deriva evidente è, sia perdonata la banalità passatista, che le posizioni estreme, le devianze e la marginalità sembrano diventate la normalità. E non ci fa quasi più effetto niente. O, se ce lo fa, meglio star zitti e magari aspettare di capire da che parte stare mentre le curve si vanno a comporre, quasi sempre partendo dai soliti capi ultras. Il paradosso? La misura la dettano quasi sempre i fuorimisura e in questo, probabilmente, c’è la chiave anche del preoccupante astensionismo che ha caratterizzato tutte le ultime tornate elettorali. Mentre loro, i fuorimisura, dicono di voler caratterizzare il voto dei moderati, senza rendersi conto che a non votare non sono i moderati, ma i misurati.
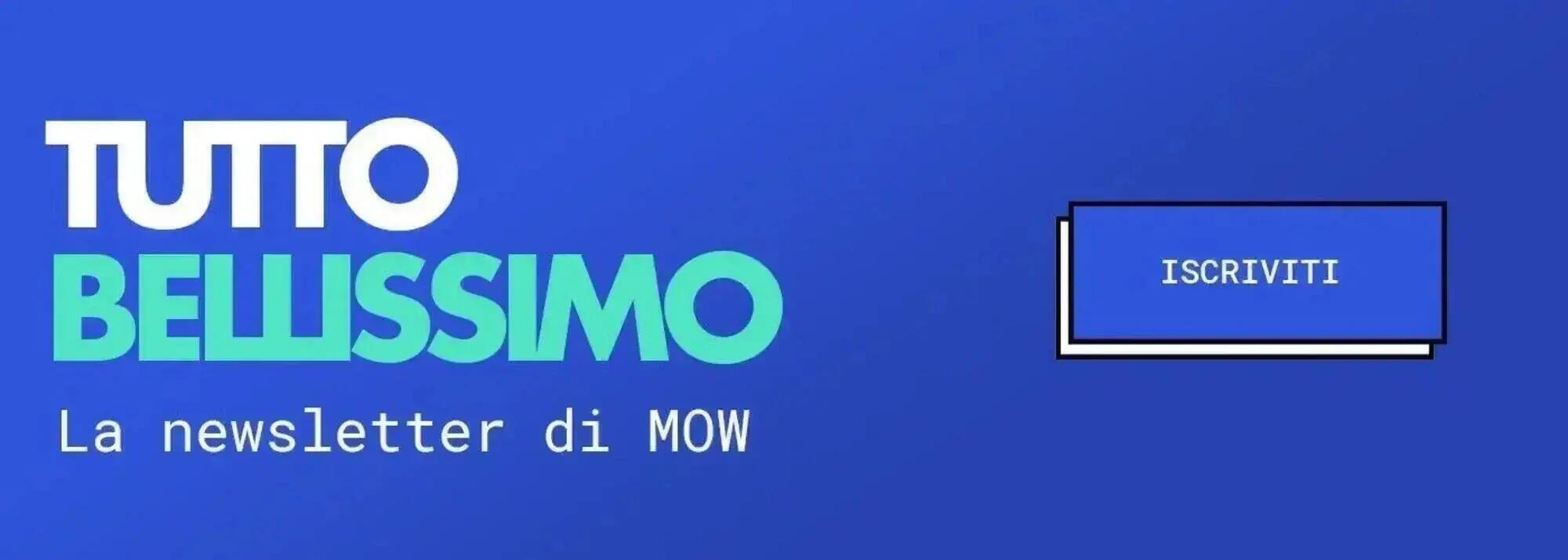
Non occorre scorrere il giornale, uscendo dalle nostre maledette bolle social che ci vanno a nozze con la nuova deriva, per avvertire che qualcosa è mutato nell’anima del nostro Paese: la misura, quel sapore antico di equilibrio e discernimento, sembra accantonata, quasi ridicolizzata. Eppure la radicalità, insegnava un certo Marco Pannella, sta nell’equilibrio: ci vuole misura anche nell’essere oltre. Anzi, ce ne vuole di più. Ciò che un tempo era considerato devianza o marginalità — estremismi, scelte di vita al limite, annunci provocatori o storie di famiglie come quelle di Verona o ancora “prepararsi ai tafferugli” prima di una partita di pallone — oggi si presenta come normalità sotto i nostri occhi. Quasi come cifra di modernità. E’ innocua? No, è l’erosione silenziosa di un humus culturale su cui si fondava la convivenza civile. Quella di quando si andava in piazza per un motivo, non per un malessere.
L’Italia, da qualche anno a questa parte - e in questo ha tante colpe davvero un certo Beppe Grillo - pare aver smarrito la centralità dell’essere umano misurato. Che non è colui che non ha opinioni forti, ma semmai è colui che non le urla, non le rende iperboliche - siano esse politiche, sociali o identitarie – pretendendo che occupino lo spazio pubblico con la pretesa di spalancare nuove strade. Fregandosene di capire se quelle strade interessano veramente o sono volute veramente. Con il risultato che non è quasi mai di apertura reale, ma di chiusura feroce e schiacciamento del confronto. Quanti restano in silenzio, nel timore che la ragionevolezza sembri debolezza? “Io me faccio li cazzi mia” è ormai quasi il motto dei misurati, ma nel momento in cui lo dicono non sono più “misurati”, ma “morti di passività”. E è pure il segnale che anche i misurati stanno perdendo la misura, deconcentrati dal dubbio se usare la parola “sbirri” o no e da qualsiasi altra cazzata così che è periferica nella realtà ma resa centrale dalle narrazioni delle solite minoranze chiassose (quelle che vanno a votare, ormai). Quanti rinunciano a pensare criticamente per timore di essere bollati come “misurati arretrati”, mentre il tifo esasperato delle posizioni aggressive è l’unica divisa in cui ci fanno credere di poterci riconoscere?

La tragedia è che la forza dell’estremo non nasce sempre da un’ideologia forte. Da un credo fermo. Da un pensiero inamovibile e netto. Ma spesso da un vuoto culturale dietro cui si insinua la rabbia. O, più pornograficamente (sul piano antropologico, sia inteso) il desiderio di esposizione. Schierarsi è più facile che aderire e fa pure più figo. Però dove manca un tessuto condiviso di valori, forte è la tentazione del facile colpo. Della provocazione. Dell’ostentazione. Del titolo senza l’articolo. E chi vorrebbe tornare al centro, al dialogo ragionato, viene spesso guardato con sospetto o, peggio, con paternalismo. Ok, l’ho scritto, ora datemi pure del fascista (in effetti la parola “sbirro” non la userei mai)! Il punto resta comunque un altro: la figura antica del “giusto mezzo” — fama della filosofia greca — non è utopia retorica, ma unico, ipotizzabile, momento di salvezza. Il termine sophrosýné (σωφροσύνη) indicava in greco l’equilibrio dell’animo. La misura nella parola. La misura nella passione. La misura negli atti. Quel gusto autenticamente umano di bilanciare il desiderio e la ragione, che non favorisce né l’eccesso né la rinuncia, ma sa essere comunque estremo. E che magari fa capire pure che “sbirro”, o “carabinieri” o “poliziotto” è solo esercizio della parola, ma “uomo”, “padre”, “lavoratore” è esercizio di reale umanità. Solo che bisognerebbe (sì, oltre che “fascista” mi beccherò anche dello snob ) che sui social, dove ormai ci si forma e ci si informa, si potesse scrollare un po’ dell’etica di Platone e Aristotele sull’evitare gli estremi per trovare un oltre: la via del “giusto mezzo”. Oppure, senza scomodare quei due, basterebbe quel buon senso di cui ormai ci si vergogna quasi.
Sì, il paradosso è che servirebbe che i misurati rivedessero per una volta la misura e ci scendessero loro, con la giusta misura trovata, in piazza. Dimostrerebbero, almeno, di essere tanti. E forse, tutti insieme, troverebbero pure la forza di farsi una domanda: sarà mica nostra la colpa se ormai estremi, devianza e marginalità sono la nuova normalità? I cattolici lo chiamerebbero esame di coscienza. Socrate, molto prima, almeno stando a quanto ha raccontato Platone, l’aveva proposto come domanda agli ateniesi arroccati in posizione di autorità (vi dice niente?): “la vita non indagata è degna dell’uomo?” Non è semplice esibizione filosofica, ma eterna, autentica, avanguardia: chi rinuncia al dissenso interiore, chi non sottopone le proprie certezze a scrutinio, abdica alla propria dignità. E quando un Paese smette di esigere da sé la critica, diventa facile preda dell’urlo. Del capriccio. Dei pensieri deboli puntellati con le posizioni forti. Di una cortina di slogan che si beano dell’esaltazione del rovesciamento sistematico mostrando disaffezione e stigma verso la vita moderata. Le piazze si riempiono di bandiere e grida, i social infiammano in un istante. Ormai anche le istituzioni, per non parlare dei politici, si adagiano su populismi da vomito riducendo il dissenso a battaglia mediatica. A quale scopo? Quello di non farla davvero, la battaglia.
Solo che a pagarne le spese è la tessitura fragile della responsabilità personali: la società civile che smette di esser soggetto e diventa spettatrice passiva del trionfo degli spettacolarizzatori di professione. O che trova normali le storie come quella della famiglia di Verona. O ancora il fatto che prima di una partita di calcio, fosse anche con Israele, c’è da mettersi giù a studiare i piani di guerra. A ogni “ma che glie fa”, a ogni “lascia stare”, a ogni “io me fo li cazzi mia”, si mette un altro piede dentro tutto questo schifo. Chi vuole ancora abitare quella antica tradizione di rispetto, sobrietà, misura — non come cliché nostalgico, ma come forza presente e futuribile — ha il dovere di rischiare la parola, custodire la possibilità che il pensiero misurato non sia un crimine di viltà, ma un baluardo di coraggio. Sì, ok, è scoraggiante visto che nemmeno la Chiesa è più misurata e abbiamo appena “salutato” persino un Papa estremista. Però riprendere e rischiare la parola, per i misurati, deve diventare valore morale. Non con timidezza, ma con fermezza e argomenti. Prima di tutto per riscoprire la bellezza del ragionamento. Del pensiero. Della resistenza al fascino del facile. Che non significa, sia inteso, rinunciare alla modernità o ai cambiamenti, ma, anzi, significa volontà di costruire in profondità. Quindi in maniera solida. Una società che rispetta se stessa non ha bisogno di urla e non si dividerebbe sulla parola “sbirro”, visto che in quella società quella parola non esisterebbe proprio, ma si confronterebbe, semmai, sull’unico terreno in cui vale la pena scontrarsi: quello del pensiero critico condiviso. Perché se la devianza, la marginalità e l’estremo continuano a diventare la norma, si finisce per stravolgere la natura stessa del rapporto civile. Se aspettiamo che il mondo ci assomigli, perdiamo la forza di educare e finiremo per scattarci i selfie con l’eclissi totale della misura.












