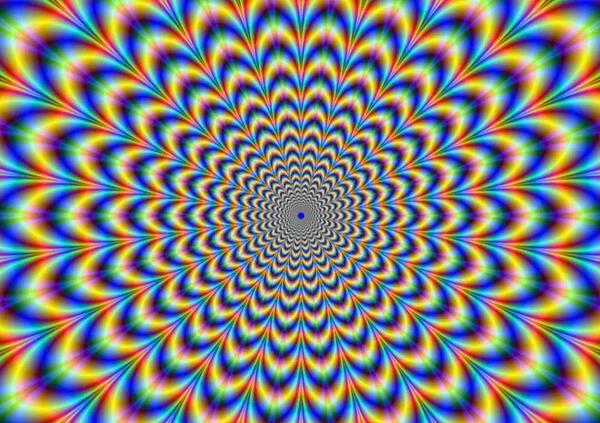«Quando nell’ottobre del 2020 sono state scoperte le croci con i nomi delle donne al cimitero Flaminio, a Roma, stavo rientrando in Italia dopo tanti anni all’estero, quindi ero alla ricerca di una storia da raccontare che potesse esprimere bene le contraddizioni di questo paese». Gabriele Barbati, giornalista per Euronews, è stato corrispondente di SkyTG24 e di Radio Popolare da Pechino. È autore, insieme a Flavia Cappellini, del podcast “20 settimane” di Emons Record che fa parte delle inchieste del quotidiano Domani. Il libro di Barbati, “Contro la mia volontà” (Paesi edizioni), si concentra su un aspetto dell’aborto mai considerato fin quando le dirette interessate, due donne romane, hanno ritrovato i loro nomi sulle croci di un cimitero, quello del Flaminio di Roma. Da Roma, poi, l’inchiesta prende una piega nazionale per tanti altri casi registrati dalla Lombardia alla Puglia. La legge n. 194 del 22 maggio 1978, “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”, regola da quarantasei anni l’accesso all’interruzione di gravidanza tutelando la privacy di tutte le donne. Ma, a quanto pare, se in un cimitero cittadino, due donne ritrovano i loro nomi sulle croci, non è che si può parlare di tutela della riservatezza. Anzi, è violazione della privacy.
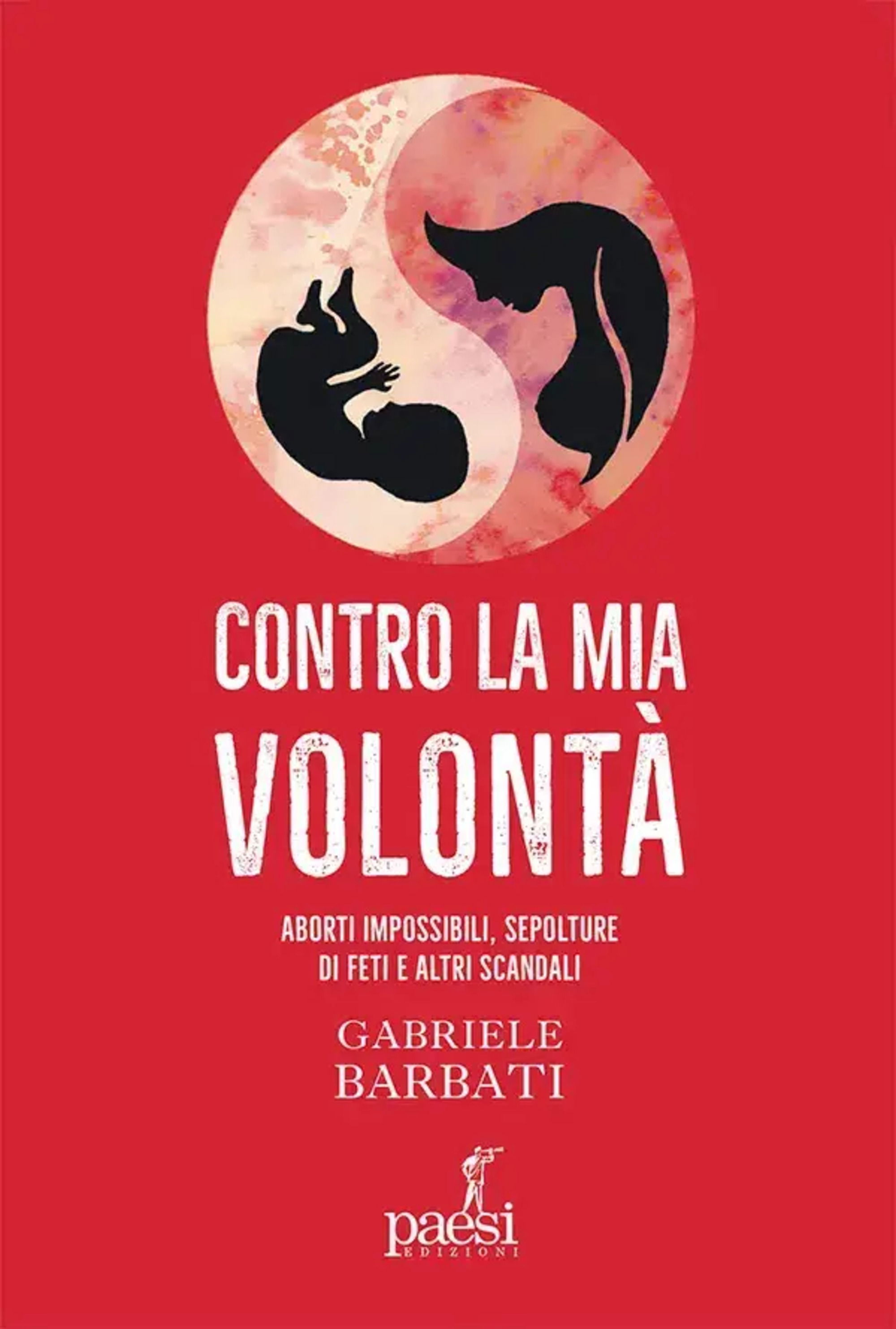
«Questo libro non vuole certamente aprire un dibattito sull’aborto ma parlare di una sua dimensione di cui nessuno sapeva niente, ossia cosa accade a un feto dopo che si abortisce. Quindi, cosa stabilisce la norma nazionale di polizia mortuaria o DPR n. 295 del 1990 che regola questa seconda parte, cioè la destinazione dei prodotti del concepimento o prodotti abortivi. Nessuno sapeva, non lo sapevano le donne che hanno partorito o la maggior parte di quelle che hanno vissuto questa esperienza a Roma - visti i numeri - al cimitero Flaminio, e non lo sapevano tante altre donne che ho incontrato in giro per l’Italia da nord a sud e, devo dire, che in certi casi non ne avevano contezza neanche le dottoresse e i dottori. Insomma, le ginecologhe e i ginecologi che specialmente a Roma hanno tenuto in piedi il sistema delle interruzioni di gravidanza nonostante tutte le difficoltà». Strano a dirsi che uno degli aspetti più pratici dell’iter abortivo è stato ignorato per così tanto tempo, e probabilmente lo è ancora. C’è un passaggio, terrificante, nel libro di Barbati che nonostante siano passati quasi cinquant’anni dalla legge 194 ci indica che siamo ancora lontani anni luce dall’essere una società che fa dei diritti civili la sua ragione di vita: «Questo ospedale - si riferisce al San Camillo - è il centro di riferimento per le interruzioni di gravidanza a Roma e, spesso, l’ultima possibilità per chi viene da fuori. Ogni mattina dal lunedì al venerdì la facciata colorata di graffiti della Uoc di ginecologia e ostetricia si affolla di sguardi decisi oppure vacui, calati sul telefono o in attesa sul bordo di un’aiuola. […] Quando lo visito per la prima volta, nel luglio del 2021, la sala d’attesa è vuota e l’ingresso è bloccato da un tavolo piazzato di traverso. Vi sono poggiati un registro, il gel disinfettante per le mani e una campanella di ceramica decorata. Due donne scendono gli scalini con un foglio in mano, quasi toccandosi, una suona la campanella e un’infermiera si affaccia sul tavolo. Può essere paradossale che la legge 194 garantisca espressamente l’anonimato per chi abortisce e che poi due persone debbano guardarsi negli occhi in coda davanti a un banchetto. Per qualcuno è significato tuttavia un conforto, uno sguardo d’intesa o una parola giusta con cui proteggersi a vicenda».

Scrive così Barbati in “Contro la mia volontà”, pubblicato qualche mese fa da Paesi edizioni. L’interruzione di gravidanza è un diritto non solo per chi decide di non volere un figlio ma anche per chi ha purtroppo ricevuto la terribile notizia di grave malformazione del feto e quindi decide di non continuare nonostante il dolore che possa comportare una tale scelta. Ma, a prescindere da quale sia la ragione, resta sacrosanta e tutelata da una legge storica che non si tocca. L’inchiesta di Gabriele Barbati vuole essere un’ottima luce da porre sull’iter dell’interruzione di gravidanza perché, essendo diversi i motivi, come già detto, c’è chi, costretto a farlo, avrebbe anche il diritto di conoscere cosa ne sarà di quei prodotti abortivi, e soprattutto avere la tutela dell’anonimato come è giusto e normale che sia. A Roma sono state almeno cinquemila le donne, se solo si contano le croci con sepolture d’ufficio del Flaminio dai primi anni Duemila a oggi, che non sapevano dell’utilizzo dei propri dati, e ce ne sono tante, ma tante altre in Italia che probabilmente ancora non sanno che il proprio nome è scritto su una croce di un cimitero.