Va fatta una premessa. Ci si avvia a stroncare uno dei libri peggiori letti in vita nostra. Si tratta di Mare avvelenato, scritto da Elena Magnani e pubblicato da Giunti. Che a sua volta, come casa editrice, è ormai diventata la nuova Newton Compton. E non è un complimento. La premessa riguarda l’effetto nefasto che deriva dall’invenzione dei filoni in narrativa. Filoni che magari vengono inaugurati da romanzi e autori di livello alto, ma che purtroppo danno vita a una scia di prodotti e manufatti editoriali perlomeno discutibili, oltre a portare sulla scena autori che molto meglio avrebbero fatto a rimanersene nell’ombra. È stato così nel caso de Il nome della rosa di Umberto Eco. Gran romanzo, che però purtroppo ha prodotto la scia del giallo filologico. Da lì in poi è partita la devastante ondata dei marcellisimoni e fauna analoga. Lo stesso è successo con Andrea Camilleri e con la sua trasformazione della sicilianità (e del parlato siculo) in una koiné artificiale, nel birignao globale. Roba buona per far abboccare il Resto del Mondo Non Siculo, facendogli credere che la Sicilia sia quella roba folkloristica dove Catarella dice “di pirsòna pirsonalmente” (frase che non verrebbe pronunciata nemmeno da uno scledense trapiantato a Sant’Angelo Muxaro, né da una avezzanese mandata a fare uno stage in raccolta dei fichi d’india a Chiaramonte Gulfi), e dove ogni due per tre si proferisce il termine cabbasìsì (che nel parlato siculo è in disuso, a occhio e croce, dagli anni Settanta). E certo, infine i libri di Camilleri sono anche dei buoni prodotti (ma non tutti). Il problema è che su quella scia si sono innestati autori e prodotti utili nemmeno per farci ecoballe, a cominciare da quelli delle catenefiorellegaleane che stanno riducendo la sicilianità a pessima macchietta, fatta di donne e arancini/e. Allo stesso modo dei due filoni menzionati, c’è il terzo che sta diventando più devastante dei precedenti: il filone delle saghe familiari. Inaugurato dalla Suprema Sacerdotessa, miss Stefania Auci, col suo polpettone in duplice teglia dedicato ai Florio. Da lì in poi è una pandemia di saghe, una persecuzione che minaccia d’incombere su di noi per il prossimo quarto di secolo. È in questo filone che s’inserisce il desolante libro di Elena Magnani. Che in copertina espone anche il seguente sottotitolo: “La saga della famiglia Mazzeo”. E qui parte il primo interrogativo: ma dove sarebbe la saga?
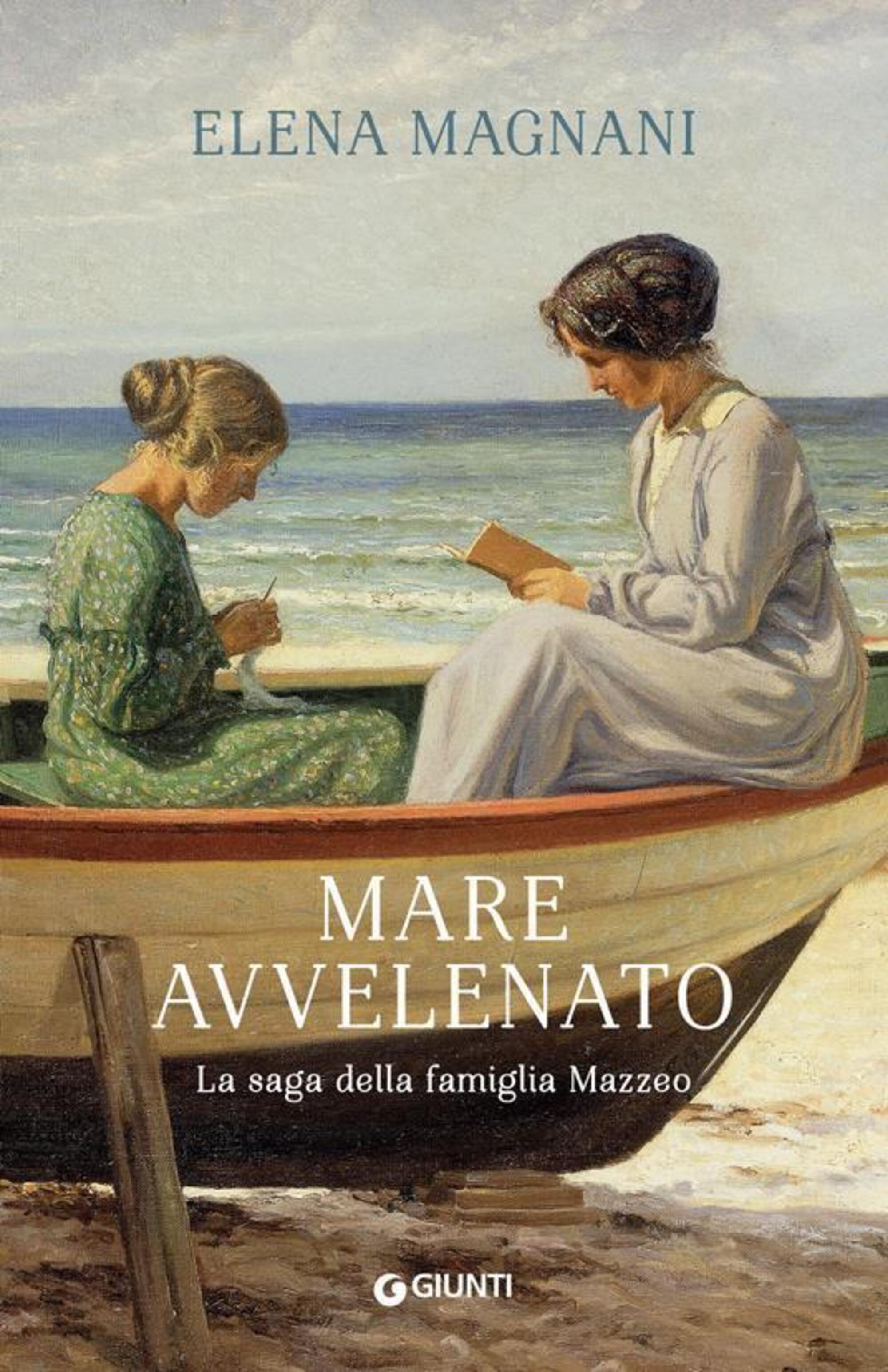
C’è storia e Storia
Semplicemente, nel caso di Mare avvelenato, la saga non c’è proprio. Né s’intravvede che possa esservi, o che si apra lo spiraglio per un sequel (per carità!). Dunque, poniamo un primo elemento per la riflessione, uno spunto che va oltre la valutazione del desolante prodotto editoriale di Magnani: sarà mica che siamo al punto in cui basta piazzare la parola “saga” nei sottotitoli per ottenere l’effettaccio? L’interrogativo rimane lì sospeso, buono per essere ripreso quando si ripresenterà l’occasione.
Ciò premesso, liquidiamo subito il passaggio sul giudizio di qualità da riservare al manufatto editoriale: se gli si dovesse dare un voto in decimi, come si fa alle scuole elementari, Mare avvelenato arrancherebbe verso il 3 in pagella. È una storia sciatta, piena di luoghi comuni e cliché, scontata dall’inizio alla fine, retta su un impianto e su trovate narrative che non avrebbero cittadinanza nei peggiori volumi di Harmony. Ma questo, appunto, è il giudizio di qualità. Che è giudizio soggettivo. Altri/e troveranno che invece il manufatto editoriale prodotto da Elena Magnani è cosa gradevole: giudizio altrettanto legittimo, che non ci interessa mettere in discussione.
Il discorso comincia però a farsi diverso se si guarda al piano che privilegiamo nel condurre il nostro esercizio di ecologia letteraria: l’aspetto di scrittura. Un aspetto al quale, nel caso specifico, va aggiunta la questione della pretesa di verità storica. Partiamo proprio da questo punto. Nel risvolto della seconda di copertina campeggia un’informazione netta: “Da una storia vera, il nuovo splendido romanzo di Elena Magnani”. Bene, prendiamo atto che si tratta di una storia vera. E prima di addentrarci in questo specifico aspetto precisiamo alcune grandi linee della trama. La vicenda si svolge a cavallo del terribile terremoto che distrusse Messina il 28 dicembre del 1908. Entro questo sfondo storico, che Magnani senza infamia e senza lode tratteggia, si svolge l’impossibile storia d’amore fra Tomaso (ma perché con una “m” sola?), che appartiene alla famiglia ex ricca dei Mazzeo caduta in bassa fortuna, e Petra, adottata dai marchesi Badastrello. Non aggiungiamo altro a proposito della trama, e non tanto perché non si voglia fare spoiler – cosa mai si dovrebbe spoilerare, di una storia così noiosa? –, ma perché s’è già dedicato troppo tempo a un intreccio del tutto inconsistente. Bisogna invece soffermarsi sul carattere di “storia vera”. In che senso lo è? I personaggi narrati sono reali? E le vicende in cui si ritrovano scaraventati, sono davvero accadute? È esistita una famiglia Mazzeo, sono esistiti i marchesi Badastrello? E tutti gli episodi criminali e avventurosi che vengono descritti in quelle pagine, hanno un minimo riscontro nella realtà dei fatti?
Lasciamo che a queste domande risponda la stessa Magnani, nella “Nota dell’autrice” pubblicata in coda al manufatto (pagina 350). Basta leggere il secondo capoverso e tutto quanto prende un senso:
Tutte le vicende riguardanti il periodo storico e il terremoto sono veramente accadute.
Ma che supercazzola è mai questa? Cosa vuol dire che “tutte le vicende riguardanti” un singolo “periodo storico” sono “veramente accadute”? E quali sarebbero “tutte” queste “vicende”? Di cosa sta parlando, a cosa si riferisce? Una vaghezza inammissibile. E lo stesso vale per il terremoto. Ci sta dicendo, Magnani, che il terremoto del 28 dicembre 1908 a Messina è veramente accaduto? Magari siamo noi quelli tardi di comprendonio, ma certo l’autrice avrebbe fatto meglio a spendere parecchie parole in più, a proposito del reale accadimento di “tutte le vicende riguardanti” questo e quell’altro. Ma andiamo avanti nell’illustrazione della “storia vera”.
Nel capoverso successivo viene riferito che:
Sofia fu una donna misericordiosa che dopo il terremoto si prese cura di tutti gli orfani di Messina e di tutti i bisognosi. Si faceva chiamare zia Sofia.
Giunti a questo passaggio ci tocca ammettere una pecca: la nostra lettura di Mare avvelenato risale a qualche mese fa. La stroncatura era in canna, ma è stata rinviata per motivi diversi. Fra le tante conseguenze di ciò vi è che non abbiamo il minimo ricordo di questo personaggio di nome Sofia. Mancanza nostra, soltanto in parte giustificata da una delle tante caratteristiche deleterie del manufatto editoriale prodotto da Elena Magnani che è stata notata da altri lettori. Come si legge infatti in molte recensioni che potrete trovare sui portali di vendite online, ricorre il motivo dell’eccessivo numero di personaggi, che porta il lettore a perdere l’orientamento e a smarrirne alcuni. A ogni modo se ne deduce che questa Elena, rappresentata come personaggio del romanzo, è esistita davvero. Un po’ pochino, per parlare di “storia vera”. Ma andiamo al capoverso successivo, rispetto al quale bisogna fare una premessa: Elena Magnani è genovese di nascita e vive in Garfagnana, ma discende da una famiglia messinese. In particolare, racconta che sua nonna ha vissuto il terremoto del 1908. Proprio a questo dettaglio è collegato il capoverso successivo della “Nota dell’autrice”:
La mia bisnonna fu ferita alla testa durante il terremoto e fu curata e ricucita dalla regina Elena, per questo motivo sono stata chiamata come lei.
Magnani riferisce questo aneddoto perché nel corso del manufatto editoriale si parla dei soccorsi che giunsero a Messina da tutta Italia. Nel contesto di quei soccorsi si distinse la regina Elena, moglie del sovrano Vittorio Emanuele III. Questo sarebbe, per l’autrice, un ulteriore elemento a supporto dello statuto di “storia vera” riguardo a ciò che viene narrato in quelle pagine. Il problema è che l’autrice fa una totale confusione fra “verità storica” e “storia vera”. La prima è il repertorio dei fatti che sono veramente accaduti, e risultano ampiamente documentati e verificabili (la dimensione di history, la Storia con la “S” maiuscola). La seconda è fatta delle “storie di vita”, delle vicende di vita quotidiana che, più o meno minime, appartengono per la quasi totalità al racconto orale e alle memorie condivise (la dimensione di story, la storia con la “s” minuscola). Magnani ci parla di “storia vera” dicendoci che sua nonna è stata curata dalla regina Elena. Ma questo non aggiunge nulla riguardo allo statuto di “storia vera” che Magnani ha preteso di appiccicare al suo prodotto editoriale. Non avevamo certo bisogno di Mare avvelenato per sapere che la regina Elena ha materialmente curato numerose persone rimaste ferite a causa del terremoto. Che la nonna di Magnani fosse fra queste è, tuttalpiù, un elemento aneddotico. Del tutto irrilevante nei termini di quella verità storica che l’autrice associa al testo. Ma l’apice si tocca col capoverso successivo:
Tra i racconti dei miei nonni, quello del capraio che vendeva il latte alla Palazzata, con le capre Cornetta e Bianchina che alzavano la zampa per farsi mungere, era il mio preferito e me lo sono sempre portata nel cuore.
Nota a beneficio di chi, con ottime ragioni, non leggerà mai Mare avvelenato. Nel romanzo la figura del capraio che porta le due caprette alla Palazzata e bla bla bla è associata a Tomaso, il protagonista. Dunque, secondo Magnani, questo sarebbe un altro connotato di “storia vera”: prendere un aneddoto del tutto irrilevante raccontato dai nonni, unitamente alla persona che stava al centro dell’aneddoto, e scaraventare il tutto dentro un manufatto editoriale. Questa roba qui viene presentata come “storia vera”. Fate voi.

La collezione degli aliti
Messo alle spalle il capitolo “storia vera”, possiamo dedicarci alla parte di maggiore importanza per il nostro lavoro di stroncatura: le gravi carenze formali. Su questo versante, Mare avvelenato non ci risparmia davvero nulla. Il campionario di sciatterie è ottimamente assortito, a partire da quel modo approssimativo di costruire il periodo. Per esempio, il passaggio che si legge a pagina 11:
Sfiorando l’ultima asola, la sua mente vagò nel passato.
Stando alla struttura del periodo, a sfiorare l’asola è “la sua mente”. Nella medesima pagina si legge una perla di analoga fattura. Il protagonista si lascia andare ai ricordi e a quel punto:
Riaffiorò l’orgoglio mentre da piccolo guardava suo padre che riceveva gli ossequi di uomini potenti e poi si voltava verso si lui e lo chiamava.
Preso alla lettera, è l’orgoglio che da piccolo guardava “a papà suo” mentre eccetera eccetera. Ma vi assicuriamo che quanto appena rimarcato è davvero il meno, una sciatteria minore. Ben altre, e ben più gravi, se ne trova in quelle pagine. A partire dai passaggi che si rivelano degli assoluti nonsense:
Con il sorriso spianato come una ferita e gli occhi invasi dall’opulenza. (p. 17)
Ripresero a muoversi, rasente i muri, come ombre senza carne (…) (p. 264)
Tomaso proseguì fin dove non potevano arrivare occhi indiscreti, se non chiamati a raggiungerli. (p. 317)
Tra ombre senza carne, sorrisi spianati come ferite, e occhi indiscreti che “non possono arrivare dove non sono chiamarti a raggiungerli” (sic!), si ricava un’allegra sensazione di parole scaraventate nel periodo con l’ausilio di Ruzzle. Ma poi succede pure che queste costruzioni, per così dire, modulari del periodo cedano spazio a una di quelle belle sciatterie sgangherate che ci riconciliano col mondo, e ci fanno capire che chiunque può farcela a pubblicare un libro:
Credevo si sarebbe ammalato ed era stanco dalla fatica. (p. 91)
E se davvero era così “stanco dalla fatica”, vorrà dire che si sarà fatto una gran “dormita di sonno”. Il problema è che Magnani scrive così, come viene. Ci mette ogni sforzo per descrivere le sensazioni provate dai protagonisti. Purtroppo, il risultato è tragico:
Da fuori il buio non portava alcun suono, eppure Tomaso riuscì a percepire un vento leggero che muoveva le foglie delle palme e il turbinio della terra intrappolata dai sassi della strada. L’ondeggiare delle piante dietro casa, dove l’orto riposava. La stalla ancora silenziosa, seppur odorosa di vita. Lo spingere della luce per riprendere possesso del giorno. E lo stridio dell’oscurità che tentava di non essere spazzata via. (p. 10-11).
Tomaso, immobile, permise al vento di infilarsi tra i capelli e giù per il colletto fino a scontrarsi con il calore che dallo stomaco gli era risalito al cuore. (p. 18)
La carrellata su queste sciatterie sarebbe troppo lunga da portare avanti. E sarebbe troppo lungo riportare tutti i passaggi agghiaccianti come i due che seguono:
I baffi gli stavano dritti come soldatini. (MA, p. 126)
Il mare non era più liscio e calmo, ma sobbolliva come una pentola prima di buttarci la pasta. (p. 191)
Ci sarebbe davvero troppo da riportare, in un solo articolo. Tanto più che ci si deve ancora dedicare alla parte in cui il manufatto di Elena Magnani tocca l’apice della desolazione: il massacro del parlato siculo. Dunque, numerose delle perle estratte da quelle pagine rimangono catalogate e conservate in un file, pronte a essere estratte per eventuali altri articoli sull’autrice. E però, non si può fare a meno di menzionare la Sagra degli Aliti. Eccola servita:
Alito n. 1: Tirò le coperte fino alle orecchie, godendosi l’alito tiepido che gli ritornava in faccia. (p. 9-10)
Alito n. 2: Neno giaceva nel letto, le labbra rosa su un volto che non voleva entrare nell’adolescenza. Ne ascoltò il respiro annusando l’alito dolce. (p. 10)
Alito n. 3: Si scambiarono tra loro dei cenni di saluto, in silenzio, per tenersi stretti gli aliti ancora caldi del tepore delle case (sic!). (p. 14)
Alito n. 4: Tomaso le si accostò in una vicinanza indecente. Per respirare il suo alito, la sua stessa aria. (p. 308)
Il siciliano, come lo parlano a Polpenazze del Garda
A questo punto dovrebbe esservi abbastanza chiaro che Mare avvelenato è un prodotto editoriale da macero immediato. Purtroppo non è ancora tutto, perché il peggio deve ancora venire. E il peggio sta nell’uso devastante che Elena Magnani ha fatto del parlato siciliano nelle pagine del suo manufatto editoriale. Si tratta di un aspetto che ci induce a dismettere il tono ironico mantenuto fin qui per esprimere vivo disappunto. Il motivo del disappunto è semplice: siamo siciliani e gradiremmo non veder massacrare, per di più con tanta leggerezza. Perché il siciliano usato da Magnani è parlato, forse, a Polpenazze del Garda. Non certo in Sicilia. In questo segmento più che in altri, si richiederebbe altro che una stroncatura dedicata: servirebbe un libro, per dare esaustiva rappresentazione dello scempio effettuato. E poiché da qualche punto si deve partire, eccolo servito:
Aumenteranno i salari e avirremu gli stissi diritti chi pi in tutta Italia. (p. 71)
Avete letto l’orrore assoluto, una spietata sevizia ai danni del parlare siculo. Per comprendere, il frammento va decostruito. Ma bisogna fare un passaggio preliminare. Questo passaggio riguarda la modalità d’uso delle lingue locali. Quell’uso va fatto per bene, con rigore. Ciò significa che si può anche fare un’alternanza fra lingua nazionale e lingua locale, ché se altrimenti si facesse uso radicale della lingua locale il prodotto scritto risulterebbe leggibile soltanto ai parlanti locali. Ne era ben consapevole Camilleri, che infatti usava singoli vocaboli, per di più sovente storpiati o riadattati. Invece, in Mare avvelenato, Elena Magnani fa altro: mescola un siciliano inesistente a forme di parlato italiano irrealisticamente ricercate. Il risultato è un Effetto Stanlio e Ollio che però non fa ridere proprio nessuno. È soltanto irritante. Ma veniamo alla decostruzione del frammento riportato sopra. In primo luogo, c’è quel “chi pi” di cui proprio non si capisce il senso. Sembra un refuso. Se invece non lo fosse, bisognerebbe che Magnani ne desse spiegazione. In secondo luogo: “gli stissi”. Se proprio voleva attenersi al siciliano, avrebbe dovuto scrivere “i stissi”. Il determinativo “gli”, in siciliano, non esiste. Ma il raccapriccio si ha con la lettura di “avirremu”. Che starebbe per “avremo”, futuro. E qui c’è l’elemento più imbarazzante dell’intera questione. Che introduciamo ponendo direttamente a Magnani un interrogativo: ha mai sentito pronunciare a un siciliano la parola “avirremu”? Ma soprattutto: ha mai udito un siciliano che declina un verbo al futuro? Non esiste, non è mai esistito al mondo. E sappiamo pure da dove scaturisce l’equivoco: il web pullula di siti che pretendono di costruire la declinazione delle forme verbali espresse in siciliano. Una declinazione che comprende anche il futuro, e che verrebbe attribuita al grande antropologo siciliano Giuseppe Pitrè. Su quest’ultimo aspetto confessiamo di non poter confermare né smentire. Non ci siamo documentati sul tema prima di effettuare la stesura di questo articolo. Lo faremo più avanti. Possiamo dire però che nei siti in cui questo esercizio viene riportato, trovate i verbi declinati al futuro in parlato siculo, e dunque anche l’obbrobriosa forma “avirremu”. Un esercizio di cicisbeismo intellettuale, come lo sarebbe stato pretendere di declinare in siciliano l’aoristo o l’ottativo. Nella realtà, il tempo futuro non è mai esistito nel parlato siculo. Sarebbe bastato starsene immersi non più di mezz’ora dentro un contesto di parlato siculo per prendere coscienza di questa verità. Magnani racconta di avere parenti siciliani. E allora, poteva chiedere a loro. O, in mancanza di questo, poteva dedicarsi a qualche lettura che allontanasse il rischio di prendere una così solenne cantonata. E non pretendiamo certo che l’autrice leggesse La Sicilia come metafora di Leonardo Sciascia: troppa fatica. Ma almeno un paio di pagine web sarebbero state comodamente a portata di mano. Per esempio, la pagina di Sikelio dove viene detto esplicitamente che nel parlato siculo il tempo futuro non c’è (https://sikeloi.net/u-sicilianu/lingua-siciliana/). Le stesse tesi sono contenute in altre pagine web, come quella del blog Cademia Siciliana dove Salvatore Baiamonte fa una dottissima spiegazione (https://cademiasiciliana.org/blog/futuro-in-siciliano/). E invece no: Magnani tira dritto e propone una carrellata di scempiaggini inascoltabili all’orecchio della mente. La lista è talmente lunga che ci si potrebbe fare un articolo lungo il doppio di quello che state leggendo. Riportiamo soltanto qualche esempio, per dare una minima misura delle assurdità che avete la fortuna di risparmiarvi non leggendo quelle pagine. Cominciamo proprio con un’altra declinazione al futuro del verbo “avere”:
‘N jornu avirrai quel che ti meriti. (p. 39)
E qui non è soltanto una questione di uso abusivo di tempo futuro, ma anche di aver piazzato un “quel” tronco che un siciliano (garantito) non userebbe mai. Ma è soprattutto questo alternare il parlato italiano col parlato siculo che genera effetti devastanti. E ancora:
Senti, Giolitti sta con il popolo, ha messo in regola il lavuru (…) (p. 71)
Il “lavuru”? Ma che roba è? In siciliano non esiste il “lavuru”; esiste “’u travàgghiu”.
Jè colpa mo. (…) Te l’ho rittu, jè colpa mo. (MA, p. 85)
Ora, a parte che ancora una volta il mix fra italiano e siciliano è agghiacciante. E a parte che “te l’ho rittu” non esiste proprio. Al limite sarà “t’u rissi”, o “ti l’hàiu rittu”. Ma soprattutto è quel “mo” a essere una totale invenzione. In siciliano “mio” si dice ”mè” (“è cùrpa mè”, Magnani prenda nota). Ci sono poi i passaggi in cui, più che siciliana, quella cadenza pare un dialetto centro-italiano che ricorda il Nino Manfredi emigrato in Svizzera di “Pane e cioccolata”:
Ti avia rittu chi nun dovevi dare un nome a li capre. Chi porta mali. (p. 153)
E già che ci siamo, facciamo un gesto di generosità verso Magnani segnalandole che, in siciliano, la capra si chiama “cràpa”, con la “r” dopo la “c” anziché dopo la “p”.
Ci sono anche verbi buttati lì ad minchiam:
Si Cono ci avissi creduto sarissi già cca e i nostre casi incendiate. (p. 173).
E lasciando pure perdere quel “i nostre casi incendiate” bisogna chiedere all’autrice: ma questo “sarissi”, a chi mai l’ha sentito pronunciare?
Ma l’apice si tocca con i passaggi in cui i parlanti del romanzo passano disinvoltamente dal parlato siculo alle forbitezze del congiuntivo italiano. Un passaggio da risate sgangherate è il seguente:
Davvero pensi che io sia unu babbu? (p. 32)
Non è ancora tutto. Il passaggio più esilarante è il seguente:
Sicché parti supra u serio. (p. 173).
E non è tanto per quel “supra u serio” che pretenderebbe di tradurre in siciliano la formula “sul serio” (un parlante siculo si sarebbe limitato a dire “veraménti”); è proprio il “sicché” a provocare spasmi d’ilarità. Un siciliano – per di più, un siciliano popolino dell’anno 1908 – che dice “sicché”? Ma allora anche “pòta”, o “ciò”, o “sòcc”, o “maremma ‘ane”. E guardando a questa sterminata serie di castronerie, si ricava un ultimo spunto di comicità involontaria nel capoverso finale dei ringraziamenti, dedicato a chi ha fatto l’editing in Giunti:
Ringrazio Nicoletta Verna per il lavoro sul testo e per aver trovato il titolo adatto. Un grazie di cuore a Giovanni Bartoli e Alessandra Biancalani per il lavoro di limatura, attento e puntuale.
E già, il problema stava tutto qui: hanno usato la lima, quando invece sarebbe servita la motozappa.

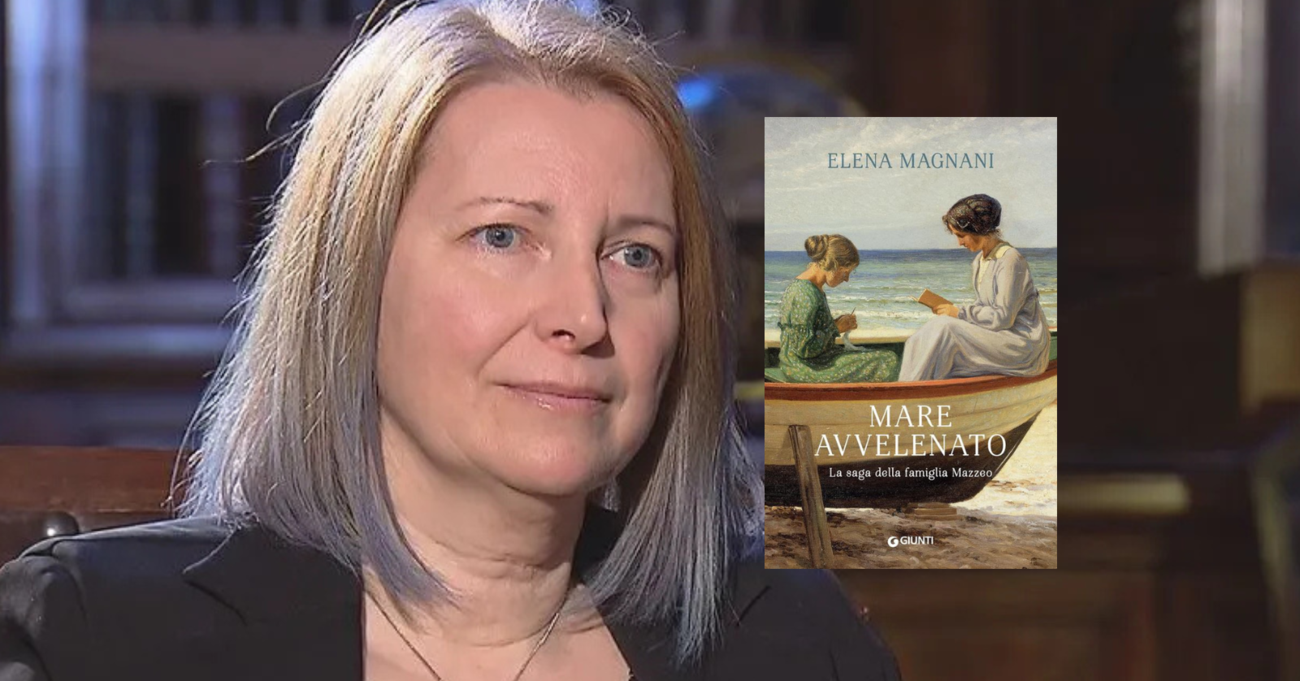



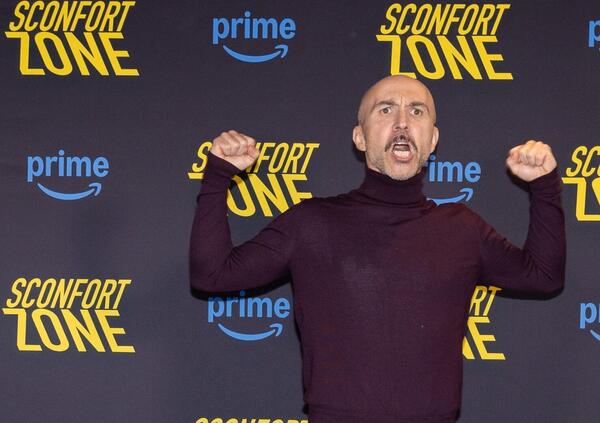

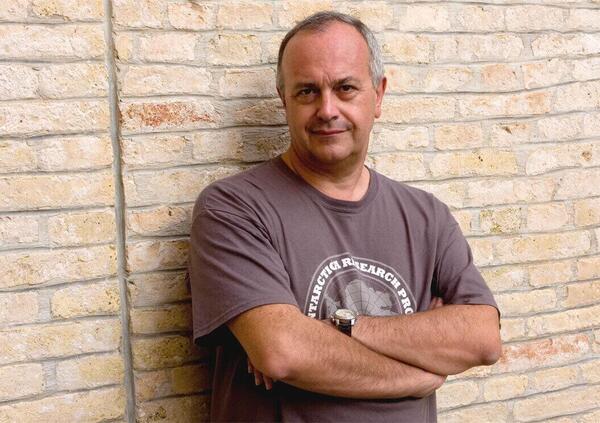






![[VIDEO] “Non dire niente a Ducati”, la frase di Marc Marquez sgretola i buonismi: il muro nel box c’è anche quando è todo rojo](https://crm-img.stcrm.it/images/43329947/HOR_STD/600x/marquez-rigamonti1-1.jpg)