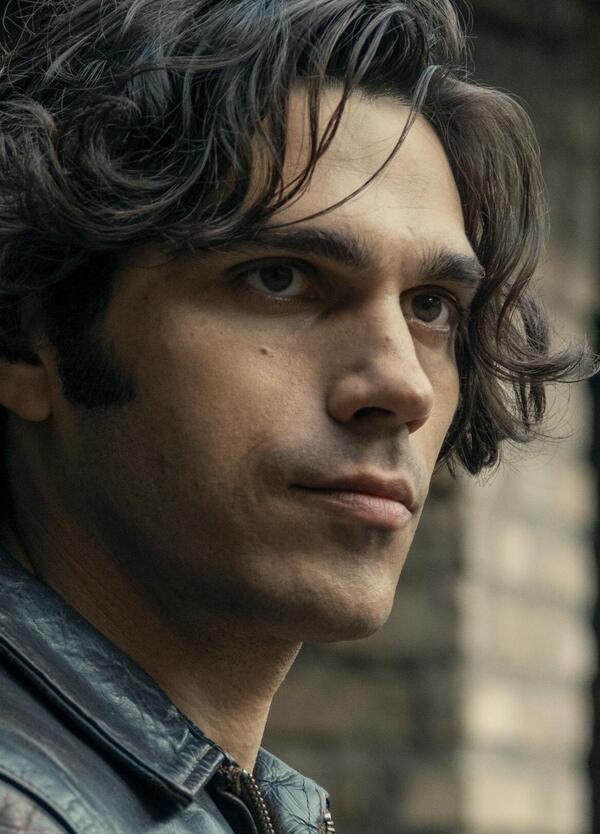
Culture
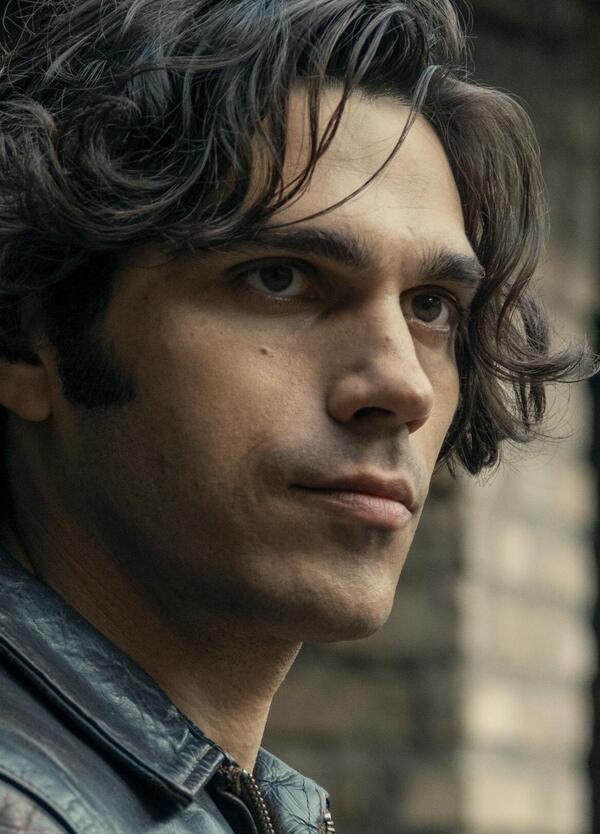
Parte una nuova inchiesta di MOW: vi sveliamo il racket delle masterclass in conservatorio. Per superare gli esami di settembre gli allievi vengono “invitati” a seguire i corsi estivi a pagamento dei docenti
Dal 2014 la legge vieta espressamente ai docenti di conservatorio di organizzare delle masterclass per gli allievi degli istituti in cui lavorano, ma chi...
Chris Rea se n’è andato su di un missile. Ecco chi era il bluesman che amava le Ferrari e divenne idolo Balearic
Inglese atipico, da Middlesbrough, era un mediterraneo mancato. Schivo (mai “celebrità”) conquistò il successo definitivo nel 1989 con l’album...
Dave Chappelle torna a sorpresa su Netflix con The Unstoppable ma sembra che da comico sia diventato un guru laico
La rilettura della vicenda di Puff Diddy, il monologo sul pugile Jake Johnson, il Mann Act, sembra che l’energia di Dave Chappelle sia cambiata, o forse...
La storia della Colombia di Escobar in “Narcoball” di David Arrowsmith. Plata, plomo e calcio: ecco come El Patron ha costruito un impero
David Arrowsmith in "Narcoball. Amore morte e calcio nella Colombia di Escobar" (66thand2nd) racconta l’intreccio tra fùtbol e ascesa del potere, da...
-
Le bombe di Cannavacciuolo al Basement: “Ecco come sono entrato a Cucine da incubo”. Gli ingredienti poveri? “Ho imparato a usarli in Francia”. E su Masterchef e la promessa di Maradona…
Antonino Cannavacciuolo passa dal Basement di Gianluca Gazzoli e si racconta tra la gavetta in cucina, l'esperienza televisiva e uno dei suoi ricordi più...
-
Questo libro non lo ha scritto Baricco ma avrebbe potuto
È il catalogo di una mostra che non esiste, un’archeologia che scava nella vita, nelle opere e nelle parole di Alessandro Baricco. Annalisa Ambrosio...
-
La gargantuesca bio su Woody Allen di McGilligan letta e recensita per voi: “Se sei chi penso che tu sia, ho sempre desiderato sco*arti a morte”
È questo il tipo di biglietto che Woody Allen riceveva per strada da una qualsiasi fan quando era all’apice del successo negli anni ’70. Questo e...
-
Giorgio Poi, Schegge Reworks è un’ottima scusa per portare il disco dell’anno nei club
Quattro tracce riviste dell’ultimo lavoro di Giorgio Poi sono un’ottima occasione per tornare ad ascoltare Schegge, uno dei dischi più riusciti del...
-
MasterChef è il Grande Fratello degli aspiranti cuochi: meno cucina fighetta e focus sui concorrenti. E il reality di Canale 5 dovrebbe prendere appunti
In due puntate a MasterChef è riuscito quello che non è riuscito al Grande Fratello in quasi tre mesi: caratterizzare i concorrenti e farceli conoscere....
-
Altro che Signorini: io, ex concorrente del Grande Fratello, ho visto tutto il marcio della tv. Il racconto in esclusiva su MOW
Fabrizio Corona è il più bravo di tutti a comporre la narrazione e a capire i tempi dell’hype, ma la Milano dei vipperelli disperati che cercano gloria...
-
Ma vi siete accorti che le major hanno scaricato Sanremo e Carlo Conti? È il “fenomeno X Factor”, dove conta tutto tranne che la musica
L’ultima edizione di X Factor dimostra chiaramente che l’obiettivo dei talent show è creare una storia intorno ai quattro giudici piuttosto che intorno...
-
Ad Atreju Giorgia Meloni mette in mostra “il presepe degli intellettuali”: dal Pasolini “vate dei porci” al Gramsci di Alessandro Giuli. E la sinistra glielo lascia fare…
Pasolini “vate dei porci”. Era questa la definizione data nel 1968 da Giovane Italia (l’organizzazione juniores del Movimento Sociale Italiano) in...
-
La guardia di finanza irrompe al Teatro San Carlo e ora ne parlano tutti: ma dov’erano i giornaloni quando ve lo abbiamo detto due mesi fa? Non solo l’ipotesi peculato, vi raccontiamo tutto quello su cui la stampa è rimasta zitta per mesi
Ora che la guardia di finanza è entrata fisicamente al Teatro San Carlo nessuno può più far finta di niente. Neanche i giornali, che in questi mesi,...
-
Recitiamo il “De profundis” di Tommaso Labate: il suo Realpolitik fa 1,9% di share per l’anteprima, ma poi gli spettatori non salgono
Realpolitik è l'ennesimo flop della Mediaset di Pier Silvio Berlusconi: arrivato per attirare nuovi telespettatori, il talk show di Tommaso Labate non...
-
Cantanti senza idee e canzoni d’amore tutte uguali? Abbiamo la soluzione, anzi due: leggete Tolstoj o ascoltate queste
Tolstoj diceva che le famiglie felici sono tutte uguali, mentre ogni famiglia triste lo è a modo suo. Ecco, a sentire la musica che troviamo su Spotify...
-
L’Università è diventata il cesso pubblico dei militanti woke: dalla “pandemia della bianchezza” a Harry Potter considerato “offensivo e obsoleto”
“Harry Potter” è offensivo e obsoleto e dovremmo preoccuparci della “pandemia della bianchezza” (che non è, a dispetto nel nome, una malattia)....
-
È morta a 55 anni Sophie Kinsella, l’autrice di “I love shopping”, scrittrice luminosa e gentile
Sophie Kinsella era malata da tempo. Dopo la diagnosi, un tumore al cervello, ha scritto un romanzo bellissimo e autobiografico sulla sua malattia. L’autrice...



















