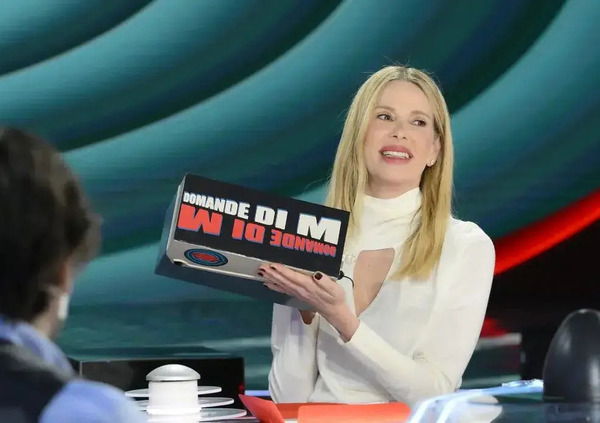Come si possa adorare (e curare edizioni di) Marguerite Duras, che alla parola ha dato tutto, il senso la storia e il loro contrario, in un’opera che non ha eguali nella letteratura recente – che in tanti, nella speranza di imitarne la profondità quasi teatrale, provano a imitare – e scrivere sul Corriere della Sera, anzi, nel periodico Sette, duemilaquattrocento battute circa di banalità, venderle alla carta stampata, che le compra…, e cederle all’irreversibilità dell’edicola e di Google – chi mai cancellerà questo articolo? – resta un mistero. Ma, come molti altri misteri, sussiste grazie alla penna di uno scrittore, in questo caso Rosella Postorino, che riesce a togliere significato alla realtà sociopolitica più significativa della storia postbellica dell’Occidente: l’Europa. Questo a voler essere gentili e a non far risalire il destino del Continente almeno al Medioevo, se non direttamente alla cultura greco-romana, come si dovrebbe, forse, da tradizione giuridica. Questo in un tentativo di impoverimento del soggetto tipico del nuovo establishment intellettuale. Nella lettura di Rosella Postorino l’Europa diventa “l’idea stessa di umanità”, quando, forse, l’Europa dovrebbe essere piuttosto la casa dell’umanesimo (da Thomas Mann a Jaques Maritain). L’Europa, un soggetto della maturità in quel viaggio dello Spirito che ha portato gli Stati-nazione a immaginare che sarebbe stato impossibile, dopo i grandi totalitarismi, sopravvivere isolati (lo ricorda un altro scrittore europeista, André Gide), è resa con infantilismo politico: “L’Europa è una cartina geografica colorata a pastelli su un quadernone, con quanto impegno mi sono concentrata sulle sfumature marroni delle Alpi, dei Carpazi, mentre mio padre – cassintegrato, emigrato – mi spiegava la Cee”.

E ancora: “L’Europa è una canzone di Cristina D’Avena, sigla di un telefilm di cui lei è protagonista, va in onda di sera; è la copertina del Corriere dei Piccoli in cui Gorbaciov stringe la mano di Reagan, la macchia color sugo sulla sua testa – sulle nostre, di teste, un «muro di Berlino» alto tre, quattro centimetri, perché ormai siamo alle medie e il ciuffo va fissato con la lacca, senza lesinare. L’Europa è un ragazzo albanese sbarcato al porto di Bari e chissà come e perché arrivato fin qui, nella Riviera ligure. Occupa una casa abbandonata, è senza famiglia, il taglio di capelli lo fa somigliare a un Playmobil, per questo mi imbarazza che voglia uscire con me”. C’è poi il miniaturismo esistenziale, cioè la tendenza a rendere piccolo ciò che si vuole affrontare perché, in realtà, ciò che si cerca di comunicare è il proprio sé: “L’Europa è un’ansia di riscatto spesso meschina, la mia, è Il conte di Montecristo rubato da una scatola all’oratorio, tanto chi se ne accorge, sono i turisti con cui parlare in francese o in tedesco, tra un bacio e l’altro, nelle estati dell’adolescenza, prima di partire per l’università”. C’è la suggestione ventotenista, verso la fine: “L’Europa è un’isola di tufo che non si sgretola e non frana, percossa dal vento e bruciata dal sole, è una prigione a cielo aperto in cui sono confinati alcuni giovani antifascisti, che proprio nel momento più atroce della guerra riescono a credere che la democrazia possa trionfare; affinché accada sognano, anzi progettano, un’unione di Stati europei”, ma solo per ricadere, appunto, nell’ombelico di Postorino: “L’Europa è la mia vita intera, una fede che avevo dato per scontata, l’illusione di essere protetta, o l’ipocrisia di una pace fittizia, la guerra sempre a un passo, e una marea di esseri umani respinti, malgrado sia questa la sede in cui i diritti si dichiarano difesi. L’Europa è una paura, è un desiderio: riguarda non solo gli europei, ma l’idea stessa di umanità”. Che si desideri, invece, avere scrittori – che per questo hanno fatto grande l’Europa – che sappiamo parlare della realtà.