Un libro che inizia come un faldone editoriale e finisce come un referto d’autopsia morale. Questo mondo non è casa (Rizzoli) di Viola Di Grado è un dispositivo a incastro: l’epigrafe di Hildegard von Bingen (“Un mondo già interpretato non è casa”) orienta il lettore, poi una catena di e‑mail - fidanzati, agenti, redattori - spalanca il tema: che cosa significa pubblicare l’intimità quando l’intimità è già stata monetizzata dalla cronaca nera? Il caso è quello dei diari di un analista torinese, Guido Pacher; a decidere la messa in commercio del suo quaderno non è un’etica, ma una contabilità del macabro (“il gusto macabro degli italiani predilige i racconti personali”). L’atto editoriale diventa offerta votiva: il sacrificio di un privato perché il pubblico abbia la sua liturgia (chi scrive questa recensione conosce la Storia, benissimo). La voce di Pacher è una lama: clinica, vanitosa, inquinata da un misoginismo che lavora come una statistica fasulla. Torino - fiume, balconi rugginosi, giardinetti interni - non è sfondo ma reagente: una città “algida e triste” (mai descrizione più azzeccato di Torino, onestamente) che impasta solitudini, Roipnol e cioccolaterie, mentre l’analista cataloga le donne nel suo lessico ragionieristico (“il livello di solitudine si raggiunge… tra il terzo e il quarto anno di assenza di rapporti stretti”). È un narratore che diagnostica con l’algebra l’anima altrui e autoassolve la propria: il monologo si nutre di Bion e Winnicott impolverati sugli scaffali, di analogie entomologiche e anatomie crude (denti, herpes, tonsille in formalina). In calce, note del “curatore” e tagli nel manoscritto raffreddano l’enfasi: come se un perito entrasse sulla scena e misurasse la temperatura delle metafore. L’ingresso di Linda Lago, paziente dai “capelli rasati” e dall’“amica immaginaria” Dalì, sposta l’asse dal referto alla favola nera. L’“immaginazione” per Linda non è evasione ma azione (“agire nel profondo”): lo capiamo nel bosco di Aitken Wood, tra sculture innestate negli alberi, quando inciampa in un cervo bianco trafitto da una freccia - icona medievale di passaggio tra mondi e di trasgressione della regola. A Blackpool, fra sirene metalliche e montagne russe, il matrimonio dell’amica Ramona è un carnevale di coppie che acceca la solitaria; poco dopo, nel “bar di piazza Solferino”, il marito cacciatore cade con un gin tonic al veleno - o forse con un infarto - subito dopo che Dalì ha “versato” la polvere. Realtà o proiezione?
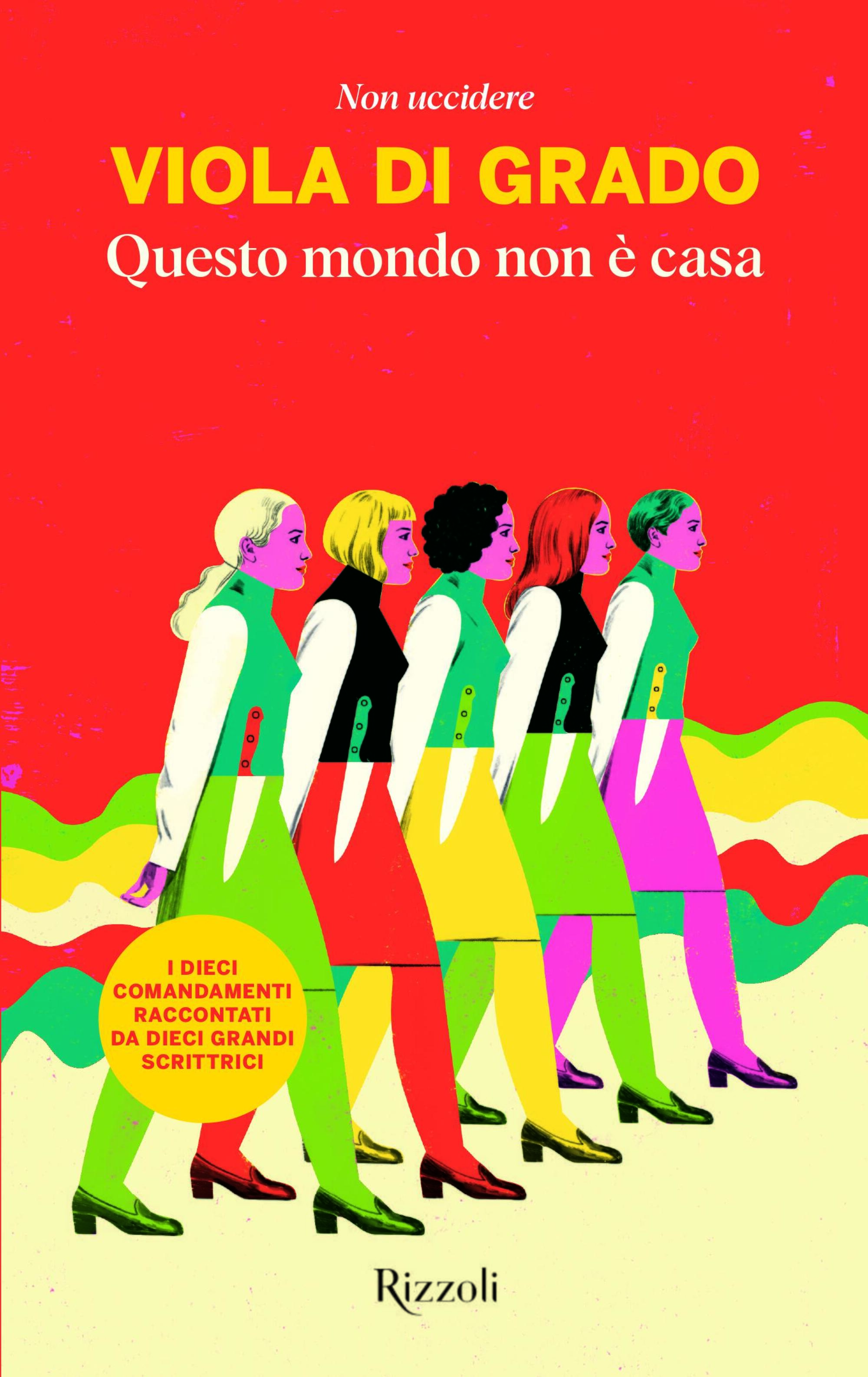
Il comandamento sul dorso - Non uccidere - è il centro magnetico che deforma le bussole. Non si uccide soltanto con le mani: si può “uccidere con l’immaginazione”, chiede Linda; Pacher liquida come “pensieri intrusivi” ciò che il libro tratta come atto etico, perché ogni fantasia porta una responsabilità di mondo. Il cervo bianco, il marito violento di Ramona, l’analista stesso: i morti (o i quasi‑morti) accatastano domande più che prove. Alla fine, nello studio, Pacher tenta la sopraffazione, e la “testa di Freud” - oggetto totemico del potere interpretativo - si abbatte sul suo cranio: è Dalì a scagliarla? è Linda? è la lingua del testo che si vendica dell’analista? La scena congela il frame come un’immagine a bassa risoluzione su Skype: si vedono i pixel della colpa, non l’autore materiale. La cultura che il romanzo convoca non è esibizione, è tatto. Marianne Moore—fraintesa e tradotta fino a diventare un paradosso (“la cura della solitudine è la solitudine”) - serve a distinguere loneliness da solitude; Kerner e i Rorschach “dagherrotipi del mondo invisibile” ribaltano la psicodiagnostica in spiritismo; Warhol e il suo registratore‑moglie portano il chiacchiericcio a dignità di forma; le bambole bisque (e la terribile Little Miss No Name ritirata dal mercato) spiegano l’economia affettiva della vetrina; il teatro bunraku delle “madri nascoste” inchioda il paradigma del controllo materno. La citazione è sempre una prova al microscopio: non cancella il corpo del racconto, ne evidenzia le fibrille.

Strutturato per carte processuali - e‑mail, ricevute, pagine strappate, glosse - il libro fa della forma un argomento: non c’è una narratrice onnisciente a garantire l’accesso al reale, solo carte che si contraddicono. L’idea di pubblicare i diari dell’analista - con l’agente che fa i conti e l’editor che delimita le pagine “dall’inizio delle sedute al giorno dell’omicidio” - è una messa in scena del nostro mercato della verità: non più romanzo‑verità, ma verità‑romanzo, dove i limiti legali (segreto professionale, doveri di segnalazione) vengono estetizzati prima che rispettati. È un mondo “già interpretato”, dunque disabitabile. Torino è un personaggio: il Po come farmacia dell’umore (“piangere vicino a un corso d’acqua è come piangere con qualcuno”), via Garibaldi come corridoio di accesso alla profondità, piazza Solferino come altare. L’architettura tiene insieme il romanzo a livello nervoso: i corridoi degli studi, i pianerottoli, la sedia al pianerottolo tra secondo e terzo piano, i giardinetti interni, le sirene dei luna park inglesi e quelle, mutissime, delle bambole in vetrina. In tutte le stanze, l’acustica della solitudine: citofoni senza risposta, latrati, televisori lontani, pioggia. La geografia è una risonanza magnetica dell’ansia. Il cuore critico del libro è l’attacco alla psicoanalisi ridotta a retorica (“io non devo agire/reagire”) che ricorda istintivamente Paul B. Preciado: Pacher parla come un terapeuta che scambia l’astinenza affettiva per rigore metodologico, fino a quando il corpo - erezione, nausea, sudore - smonta la sua scienza delle distanze. La voce di Linda, invece, fa reagire filosofia della mente, etimologia (la splendida pista sollus - “solo/solido”) e zoologia morale (dal cervo ai “non player characters” dei videogiochi): non è un caso se la svolta etica arriva quando lei pronuncia la parola bontà guardando un animale morto. È lì che il comandamento esce dal catechismo e rientra nel romanzo: non come precetto, ma come domanda che ferisce.

La scrittura di Di Grado è un organismo anfibio (ed è così da sempre): alterna registri - epistolario, memoriale clinico, verbale di polizia, didascalia museale - e li mette in cortocircuito con una precisione d’immagini che unisce l’alto e il basso (le tonsille come “scalpi di un nemico”, i palchi del cervo come “pensieri allo scoperto”, il fondotinta come “intonaco”). Il ritmo è governato da interruzioni, ellissi, graffi tipografici, pagina bianca: le cesure non sono vezzi, sono prove di realtà dentro un racconto che mette continuamente in discussione il confine tra immaginare e fare. E poi il finale: il ribaltamento del potere interpretativo (Freud‑testa/oggetto che “uccide” il suo sacerdote), la mano invisibile di Dalì - psicotropo narrativo o vero nume tutelare? - e un ultimo gesto che non vuole “interrompere il silenzio”. Qui il libro decide di non decidere: non è giallo giudiziario, è tragedia dell’interpretazione. A conti fatti, Questo mondo non è casa perché ogni “casa” che ci viene interpretata addosso - dalla famiglia, dalla cura, dall’editoria, dalla legge - rischia di trasformarci in oggetti di vetrina; per abitare bisogna disimparare, restituire al mondo l’opacità che gli spetta. Grazie Viola, da un conterraneo opaco troppo spesso in vetrina.














