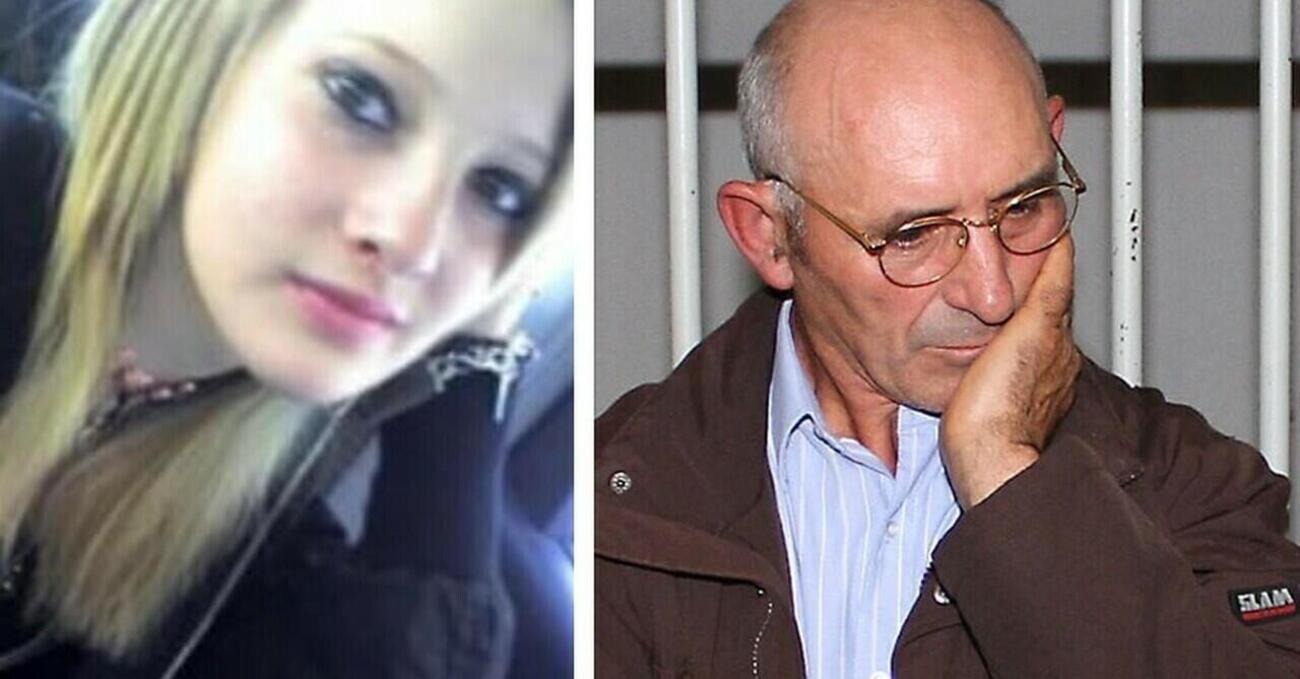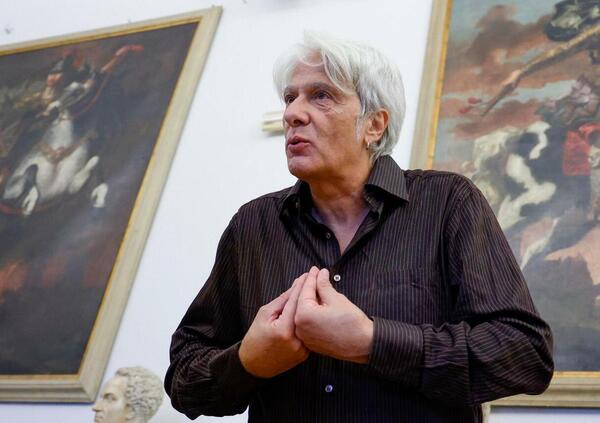Michele Misseri, lo zio simbolo nel delitto di Avetrana, continua a dichiararsi colpevole per la morte di Sarah Scazzi. Lo fa nonostante la giustizia abbia stabilito che l’unico suo ruolo sia stato quello relativo all’occultamento del cadavere. E lo fa con una reiterata ostinazione che lascia perplessi, soprattutto alla luce delle evidenti contraddizioni tra le sue confessioni e i riscontri oggettivi delle indagini. “Sono stato io”, ha ribadito in una recente intervista a La Stampa, tornando a raccontare una versione ormai sconfessata da trentasei magistrati. “Quando Sarah è scesa l'ho vista diversamente dal solito, non l'avevo mai vista così. L'ho presa di spalle, l'ho sollevata e mi ha dato un calcio all'indietro. Allora non ci ho visto più, ho preso un pezzo di corda ma non ricordo come l’abbia uccisa”. Lo zio di Avetrana ha anche aggiunto di aver tentato qualche giorno prima del delitto un approccio sessuale con una molestia descritta come una pacca sul sedere. Inquietante, se fosse vero. Se fosse. Però non è così. Ma perché Misseri non smette di rivendicare una colpa che non gli appartiene? Il quadro che emerge è quello di un uomo non solo intrappolato nella propria incapacità di gestire il peso della coscienza, ma anche in una sudditanza psicologica e familiare che ha segnato profondamente la sua vita. L’avvocato Franco Coppi ha definito il movente sessuale come il più solido e credibile, ma in realtà lo stesso Misseri dimostra di non padroneggiare i dettagli della dinamica omicidiaria. Il suo racconto rimane lacunoso e inconsistente rispetto agli accertamenti medico-legali: non sa come ha strangolato la nipote, non ricorda la sequenza esatta dei fatti e sembra costruire un resoconto raffazzonato nel disperato tentativo di colmare vuoti di memoria e di significato. Tutto ciò fa emergere un elemento centrale del suo comportamento: la sua costante necessità di aderire a un copione dettato da altri, quasi a confermare il suo ruolo di “anello debole” della catena familiare. Ma anche questa non è una novità dato che tale ricostruzione è stata messa nero su bianco in tre gradi di giudizio. Dunque, in quella che ormai ha assunto i toni della commedia, come testimonia anche la serie tv in uscita su Disney+, la risposta va ricercata nel rapporto di Michele Misseri con due delle donne della famiglia, la moglie Cosima Serrano e la figlia Sabrina Misseri. Un rapporto che rivela una dipendenza psicologica che va oltre la semplice dinamica familiare. Fin dall’inizio, Michele ha dimostrato un profondo bisogno di compiacere, di non deludere e, soprattutto, di non contraddire i diktat imposti dalle figure dominanti della sua vita. Questo pattern è emerso chiaramente quando, nel corso dell’interrogatorio in cui attribuiva la responsabilità a Sabrina, la sua preoccupazione primaria non era tanto quella di confessare il crimine, quanto quella di non far sapere alla moglie di aver “tradito” il patto di omertà. Un patto che Misseri aveva rispettato ciecamente per anni, obbedendo passivamente alle regole non dette della famiglia. Quell’agosto maledetto, però, il patto era diventato sanguinario. Troppo, anche per un contadino come lui.


La sua debolezza e il suo ruolo marginale sono stati anche la ragione per cui la giustizia non ha ritenuto attendibili le sue confessioni. Eppure, il “caso Misseri” va letto anche attraverso una chiave più complessa: quella del rimorso e della distorsione della realtà. Nel tentativo di giustificare il proprio senso di colpa, Misseri ha costruito una narrativa su misura, presentandosi come l’assassino mosso da un improvviso impulso sessuale. «Quando ho visto Sarah con quei pantaloncini, mi sono sentito attratto», ha raccontato. Una dichiarazione che non regge se confrontata con la sua storia personale e che appare più come un tentativo disperato di rendere il racconto plausibile. Qui emerge un aspetto criminologico importante: la costruzione del falso colpevole. Michele non solo ha cercato – e cerca – di convincere gli altri, ma anche sé stesso, di essere l’assassino, per trovare una sorta di espiazione che alleviasse il peso dell’aver “tradito” la sua famiglia. La genesi del comportamento di Misseri ci restituisce l’immagine di un uomo che, in condizioni normali, non avrebbe mai preso una decisione autonoma e che è stato schiacciato dalla dinamica familiare. L’elemento sessuale, di per sé, è chiaramente per Misseri una copertura credibile per giustificare il movente agli occhi degli inquirenti. L’uomo era abituato a seguire le direttive imposte da Cosima e Sabrina, e anche quando ha confessato l’omicidio, l’ha fatto per adeguarsi a un ruolo assegnato, senza mai esserne convinto fino in fondo. Nel contesto di una dipendenza psicologica così radicata, è importante sottolineare come la vera motivazione dietro le continue autoaccuse non sia mai stata la ricerca della verità, ma piuttosto il tentativo di recuperare una sorta di equilibrio interno dopo aver “tradito” il patto familiare. Michele è stato e rimane una pedina in balia delle dinamiche dominanti del sistema Cosima-Sabrina. Un uomo disorientato, privo di una bussola morale autonoma e incapace di reggere il peso delle sue stesse menzogne. L’attuale libertà di Michele Misseri, paradossalmente, non ha portato alcun sollievo. Al contrario, ha acuito la sua disperazione e il suo isolamento. Senza più il vincolo del carcere, si ritrova solo, escluso dalla famiglia e ignorato da quella stessa figlia, Valentina, che lo ha ripudiato. È rimasto un uomo svuotato, abbandonato a sé stesso, che nella solitudine sembra aggrapparsi a quelle stesse bugie che lo hanno condannato. Nella sua mente, continuare a dichiararsi colpevole è l’unico modo per trovare un senso a un’esistenza che non ha più punti di riferimento. Per Michele, non esiste più la verità: esiste solo il tormento di un uomo senza identità, la cui unica certezza è il rimorso di non aver protetto chi amava, ma anche il dolore di non saper più cosa sia davvero successo quel giorno.