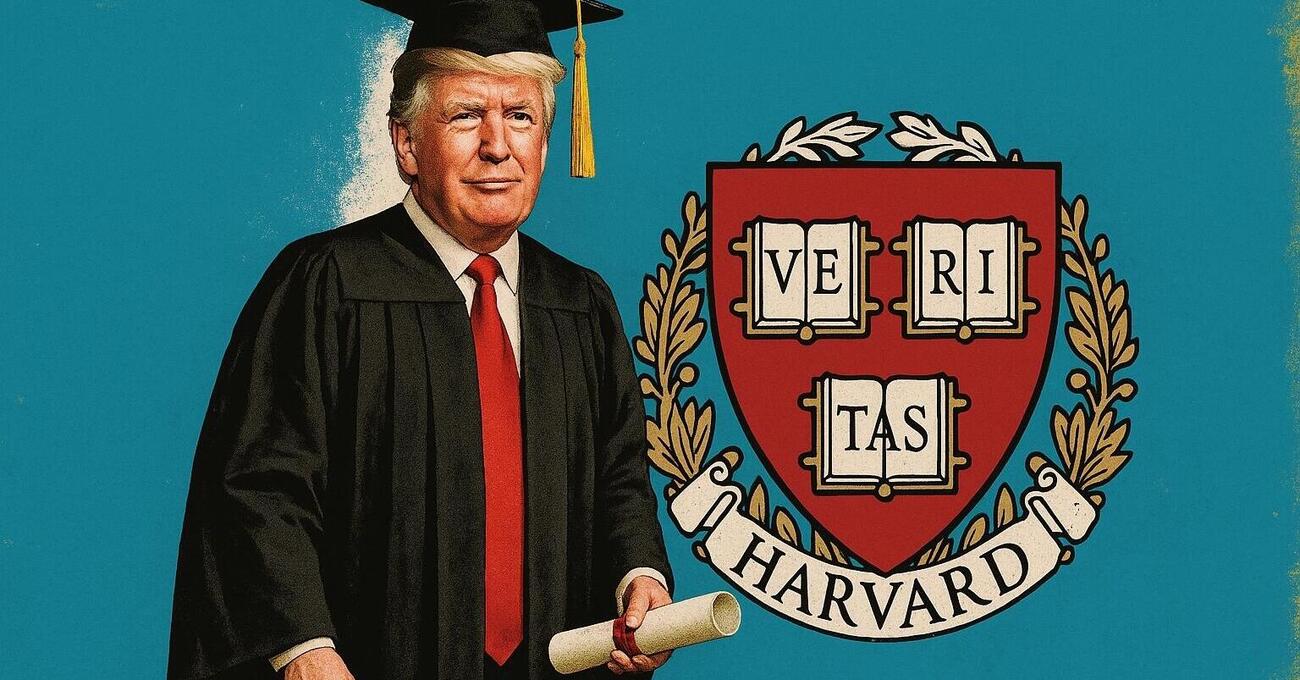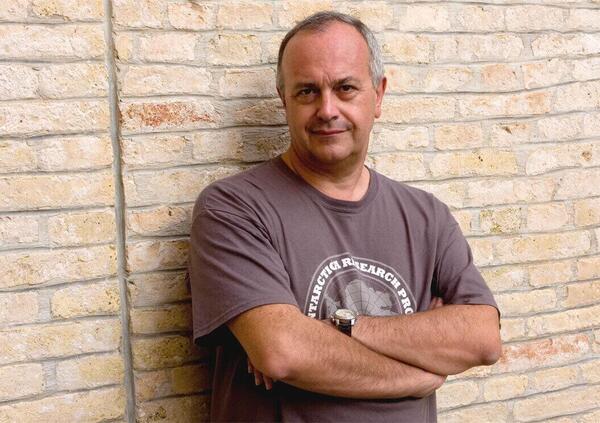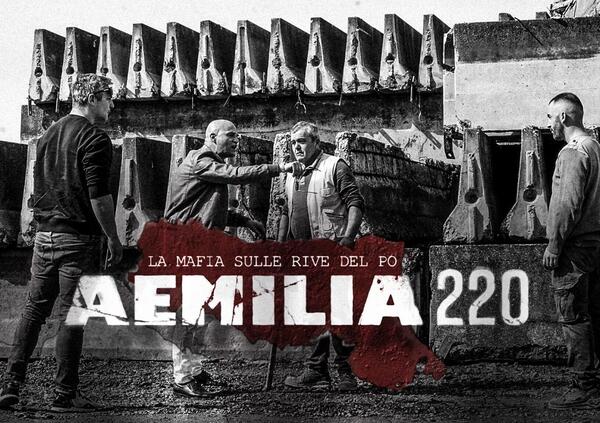Ma partiamo dalla fine. Nelle ultime ore alcuni giudici federali hanno bloccato la decisione dell’amministrazione Trump di revocare il visto agli studenti internazionali di Harvard. L’annuncio era arrivato solo poche ore prima e avrebbe, di fatto, reso gli studenti di una delle più note università al mondo degli immigrati senza documenti, obbligandoli a tornare nei rispettivi paesi d’origine. La decisione del giudice distrettuale Jeffrey White ha alzato i toni già altissimi di uno scontro che, ieri aveva visto il Dipartimento per la sicurezza nazionale pubblicare una nota in cui accusava i vertici di Harvard di aver creato un ambiente universitario non sicuro “consentendo ad agitatori antiamericani e filo-terroristi di molestare e aggredire fisicamente individui, tra cui molti studenti ebrei”. Alla nota ha fatto seguito Kristi Noem, che dirige il dipartimento stesso, in cui sosteneva che Harvard avesse fomentato l’ “antisemitismo” e si fosse “coordinata con il Partito Comunista Cinese nel suo campus”. Ma l’antisemitismo è in realtà solo una parte nella spiegazione dell’ostilità tra Trump e, in questo caso, anche di gran parte destra statunitense, e il mondo accademico. Alla base c’è infatti uno scontro culturale che va avanti da decenni e che negli ultimi anni, con la polarizzazione del dibattitto politico, ha fatto sì che il dibattito delle università si spostasse sempre più verso sinistra, non di rado assumendo posizioni dogmatiche e intransigenti. Un caso che fece scalpore fu quello di Ayaan Hirsi Ali, intellettuale di origini somale a cui la Brandeis University cancellò una laurea ad honorem dopo grosse polemiche su sue posizioni ritenute islamofobe. Parallelamente a questo arroccamento a sinistra, si è sviluppato un sentimento analogo a destra che, sentendosi sottorappresentata, ha cominciato a condannare i potentati intellettuali della Ivy League e delle altre grandi università americane, tacciate di essere la culla dell’ideologia “woke”, che per la destra censurerebbe ogni posizione in contrasto con quelle del pensiero liberal su aborto, diritti lgbt, crisi climatica e, in ultimo, il conflitto israelo-palestinese.

In questa guerra ideologica che spesso ha assunto le sembianze di uno scontro tra tifoserie il rettore di Harvard Alan Garber è diventato un’icona per i dem, perché si è opposto fermamente alla richiesta di rivedere i criteri di ammissione alle facoltà, cosa che tutte le altre università hanno fatto. Di recente, Graber è stato intervistato dal Financial Times, dichiarando che la guerra contro Trump non se l’è cercata, ma gli “è arrivata addosso”. Più di qualche osservatore ha notato che la frase sembri alludere all’aura di anti-Trump riversata su Graber dalla politica e anche dai media nonostante questi abbia spesso mantenuto un atteggiamento più dialogante con l’amministrazione. Ci sarebbe da crederci, soprattutto perché Harvard non intende rinunciare ai 700 milioni di dollari che, stando ai dati del 2024 citati da Bloomberg, riceve dal governo federale. All’università del Massachusetts l’amministrazione ha già sospeso 2,2 miliardi di fondi, che potrebbero arrivare fino a 9 miliardi. Per questa ragione Garber, che ha sostituito Claudine Gay, sommersa dalle critiche per aver difeso gli episodi di antisemitismo nei campus, aveva subito preso posizione sull’argomento, definendolo “un problema”. Ha poi eliminato i finanziamenti alle feste di laurea per i vari gruppi etnici e sociali in nome dell’unità dell’ateneo. Insomma, un approccio prudente e diverso da chi lo aveva preceduto, che sembrava mettere al centro la dignità dell’università come ente libero e universale, senza cadere nei trappoloni ideologici che hanno reso Harvard il bersaglio preferito della galassia MAGA. Ma secondo alcuni l’approccio prudente mostrato da Garber si sarebbe scontrato anche con i media dem, quelli più critici di Trump. Per esempio il New York Times che, secondo un’analisi di The Intercept avrebbe “distorto il dibattito sull'antisemitismo” riportando i risultati di un sondaggio condotto sugli studenti di Harvard in merito alla sicurezza. Il sito indipendente che si occupa di inchieste, sostiene che il Times avrebbe presentato i dati dipingendo un ateneo in cui “l’antisemitismo si è infiltrato nei corsi di studio, nella vita sociale, nelle assunzioni di alcuni docenti e non solo. Ma i dati – secondo The Intercept – mostrerebbero in realtà che sia la comunità araba e musulmana quella in cui l’insicurezza percepita tocca le vette più alte, in alcuni casi anche del 92 per cento. Sondaggi come quelli del New York Time hanno contribuito ad esacerbare gli animi e alzare i toni dello scontro, su cui poi è arrivata la valanga Trump: il fallimento definitivo della cautela mostrata da Garber al suo arrivo si è verificato quando, ad aprile, il governo ha chiesto ad Harvard di accedere alle richieste di ammissioni e decidere chi può e chi non può entrare nell’istituto. Da lì, è iniziata una guerra senza mezzi termini arrivata in queste ore nella fase più delicata.