La Corea del Sud? Nell’immaginario dell’occidentale medio è rappresentata dal trittico automobili-tecnologia-intrattenimento. All’interno di questo triangolo c’è però molto altro. C’è la storia, o meglio la strategia, di un Paese che si è riscoperto grande dopo essersi ripulito l’immagine a colpi di soft power. C’è anche un modello di successo che ha consentito a Seoul di dettare legge in alcuni dei più importanti settori economici del pianeta, dall’automotive alla telefonia. Così come negli anni ’90 non esistevano bambini che non avessero mai guardato un cartone giapponese, oggi non esistono ragazzi che non abbiano mai guardato, almeno una volta nella vita, una serie tv sudcoreana. I colossi automobilistici della Sud Corea, intanto, hanno fatto breccia in Europa, mentre i telefoni e i pc dell’ex Tigre asiatica sono sinonimi di qualità indiscussa. Come è potuto succedere tutto questo? Ne abbiamo parlato con Natan Mondin, autore del libro “La via coreana. Come la Corea del Sud sta conquistando l’Occidente” (Utet).
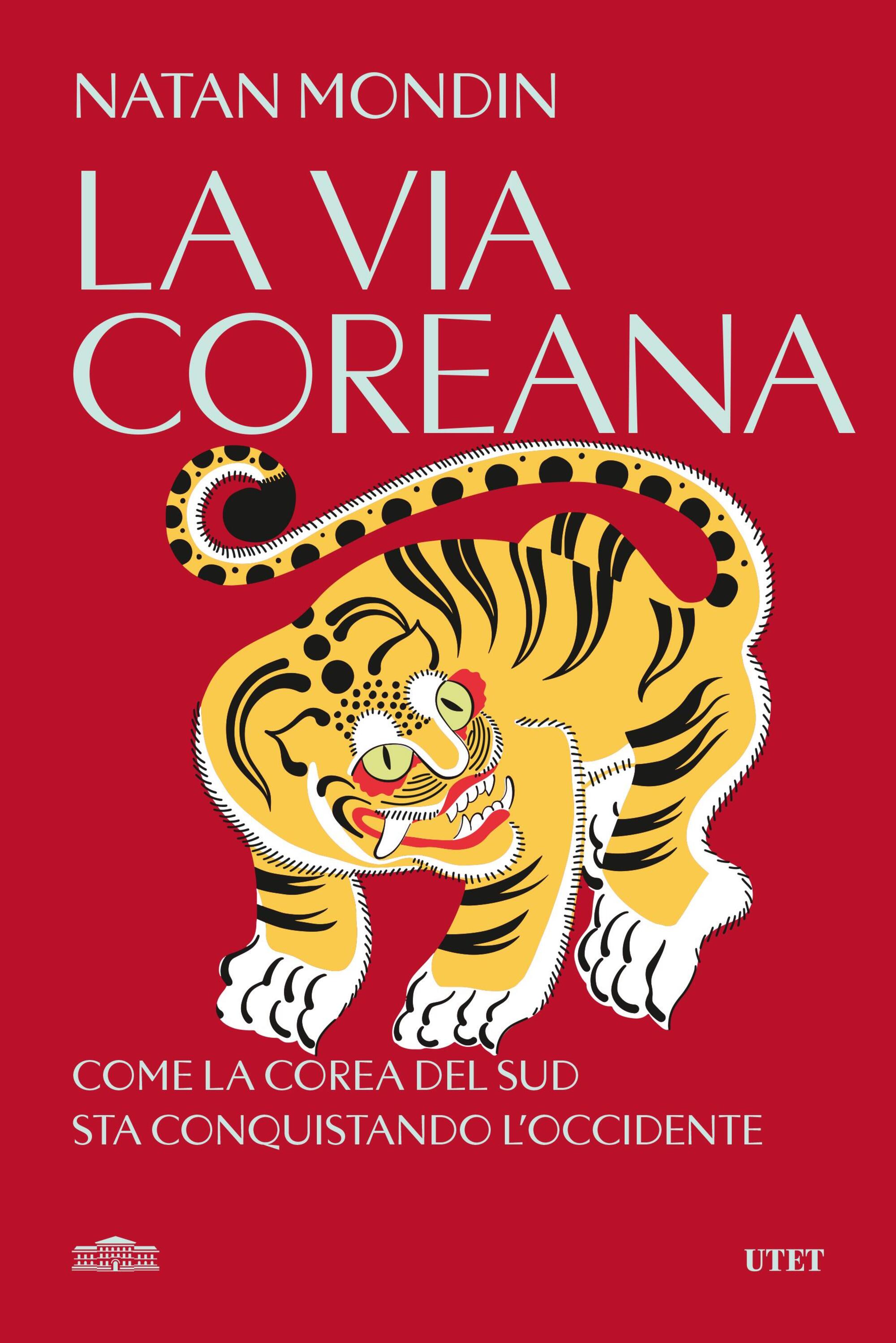

L’onda culturale sudcoreana arriva in Italia con la canzone Gangnam Style di Psy?
Il grande impatto della cultura sudcoreana in Italia avviene con Gangnam Style, però, di fatto, l’operazione di investimento da parte della Corea del Sud nella sua cultura parte molto prima. Almeno dal governo guidato da Kim Dae Jung, tra la fine degli anni ’90 e i primi Duemila, quando le autorità del Paese asiatico già parlavano del fatto che la loro cultura dovesse essere una chiave da usare per rinnovare l’immagine della Corea che circolava all’epoca nel mondo. Una Corea reduce dalla crisi finanziaria asiatica, da un’onta arrivata nel momento di massimo sviluppo della nazione.
Quindi Seoul ha puntato sulla cultura per rifarsi l’immagine...
Esatto. Per non essere più il Paese della Guerra di Corea e il Paese “fallito” della crisi asiatica. E Seoul ci ha guadagnato da questa mossa, e non solo in termini di soft power. In questo modo la Corea ha veicolato valori e un modo di vedere il mondo.
Il risultato è la Corea del Sud che conosciamo oggi, una sorta di Giappone in divenire?
Il modello è quello. Ci sono dei tratti che caratterizzano i popoli. In Corea c’è il sentimento han, un miscuglio di sensazione di essere stati negletti, messi da parte della storia, incompresi e schiacciati da popoli più forti come Cina e Giappone. Questo può avere due risvolti: uno negativo, che può portare alla vendetta, e una positivo, che consiste in un moto all’azione, nel prendere il “nemico” come esempio per poter fare meglio. È un po’ quello che la Corea ha fatto con il Giappone.
Dunque, il Giappone è il modello e va superato?
Sì. Samsung, per fare un esempio, ha preso come benchmark Sony per surclassarla sul fronte dei telefoni. Il Giappone era un modello di tecnologia e la Corea l’ha superata. Anche Hyundai sta per fare la stessa cosa a Toyota.

La Corea del Sud oggi attrae. Le persone vogliono visitarla solo perché Seoul ha saputo fare leva sul soft power?
C’è un termine bellissimo che è fascinazione. La Corea del Sud, fino a ora, non si è conosciuta e dunque esercita un fascino che è dato, in parte, da alcune cose che ci arrivano e che noi sentiamo essere belle pur senza comprenderle, e in parte da questo lavoro di soft power. La Corea rivisita l’Occidente in chiave orientale, proponendo temi e atmosfere che piacciono.
Film, serie tv, muica made in Korea: ci sono titoli e nomi che possono diventare la nuova moda del momento?
Sul fronte musicale c’è stato il grande boom dei Bts. Ma, come Gianni Morandi e Jovanotti, anche loro sono dovuti andare a fare la leva militare. Ma in Corea del Sud dura quasi 24 mesi, e questo comporta una loro battuta d’arresto nella discografia. Adesso iniziano ad affacciarsi nuovi gruppi, ce ne sono moltissimi.
Perché Samsung, Lg e Hyundai si sono mangiati la concorrenza? Sono stati più bravi o hanno adottato una ricetta più efficiente dei loro rivali?
Hanno usato il metodo dei benchmark: cioè prendere i migliori, analizzare il loro modello e interpretarlo in base al proprio contesto. C’è poi il sistema di reverse engeneering, ci sono i brevetti scaduti. Molti brevetti scaduti in Giappone sono stati venduti in Corea, ed è il caso del motore che equipaggiava il primo modello Hyundai: era Mitsubishi. Da noi è arrivato il Galopper, che era un Mitsubishi Pajero di due generazioni precedenti. Hyundai proponeva modelli di qualità simile ai concorrenti giapponesi ma a prezzi più bassi. Samsung fa il salto in avanti con un brevetto televisivo giapponese che ha portato avanti.

Sul fronte auto la Corea del Sud è un piccolo colosso. Basta citare Kia e Hyundai...
Kia e Hyundai sono competitor ma di fatto si rifanno allo stesso gruppo. Il connubio dello sviluppo sudcoreano nasce da una sorta di aggressività commerciale, del fatto di aver sempre fame. Il ragionamento è più o meno questo: “Io ti devo mostrare che nella competizione arrivo primo e non mi fermo finché non ti ho venduto la macchina e non ti ho convinto che hai bisogno di questa auto”. I sudcoreani sono riusciti nell’intento.
Come sono messi i coreani sul fronte elettrificazione auto?
Dal punto di vista tecnologico, la Sud Corea è autonoma. Sul fronte elettrico, i principali produttori di batterie per EV sono autoctoni: Samsung Sdi e Lg Chemical. In parallelo, questo Paese sta portando avanti la ricerca in ambito idrogeno. Lo stesso vale per quanto riguarda anche il biofuel.
Parliamo di cibo. C’è anche una forte ondata culturale di K-food. C’è qualche piatto curioso?
I sapori sono forti, molto distanti dai nostri. Ne vanno orgogliosi perché anche il cibo è espressione culturale. Viene fuori da una tradizione millenaria che ha subito contaminazioni e ha contaminato. Il cibo fortemente coreano è il kimchi, l’emblema della cucina sudcoreana, che è una cucina piccante che si basa sulla fermentazione. In Corea ci sono estate calde, inverni freddi, quindi difficoltà a coltivare qualcosa e dunque si fermentano cibi.
A suo avviso l’Italia potrebbe fare quanto sta facendo la Corea, ovvero veicolare con successo il proprio soft power nel mondo?
Non l’abbiamo mai fatto in maniera sistematica. Non sentiamo addosso alcuna responsabilità nei confronti dell’eredità culturale – e industriale – che abbiamo. Avremmo però tutte le carte in regola per farlo al meglio.













