È uscito il nuovo romanzo di Chiara Gamberale, Dimmi di te (Einaudi, 2024) e come ogni volta che esce un suo libro, vengo colta da un sentimento di attesa spasmodica: riuscirà la Gamberale a essere all’altezza di sé stessa? Ne L’isola dell’abbandono, infatti, la scrittrice dell’ego espanso – talmente espanso che prima o poi il Governo le chiederà di pagarci sopra l’imu – consegnò alla Storia della letteratura italiana la scena di sesso peggio scritta che si ricordi a memoria di donna, quella tra Arianna e un bonazzo surfista, quest’ultimo descritto con questi versi immortali: “Sa di mare, sa di sale, sa di buono”, roba che i romanzi dell’ultima influencer di turno, al confronto, paiono scritti direttamente da Ezra Pound. Riuscirà la Gamberale a utilizzare un registro linguistico altrettanto sciatto oppure un inedito sussulto d’orgoglio, o la mano pietosa di un editor, avranno cercato di alzare il livello almeno di qualche centimetro? Anche questa volta, non sono stata delusa. Similitudini come “servirebbe l’aiuto del pubblico come in quei quiz dove il concorrente non ha la risposta alla domanda”, o frasi trasportate di peso dai fotoromanzi che riempivano le ultime pagine del Cioè – la vecchia rivista della nostra adolescenza perduta – tipo “vogliono un amore che punta al mondo intero, punta alla luna, perché li risarciscono” o “alla vita sempre la stessa pregheria: fammi battere il cuore” – confermano il ruolo di Chiara come indiscussa madrina dell’antilingua, quel movimento trasversale che attraversa tutta la letteratura italiana contemporanea e che si sostanzia nello scrivere libri usando la prima frase che viene in mente, come quando si compila la lista della spesa.
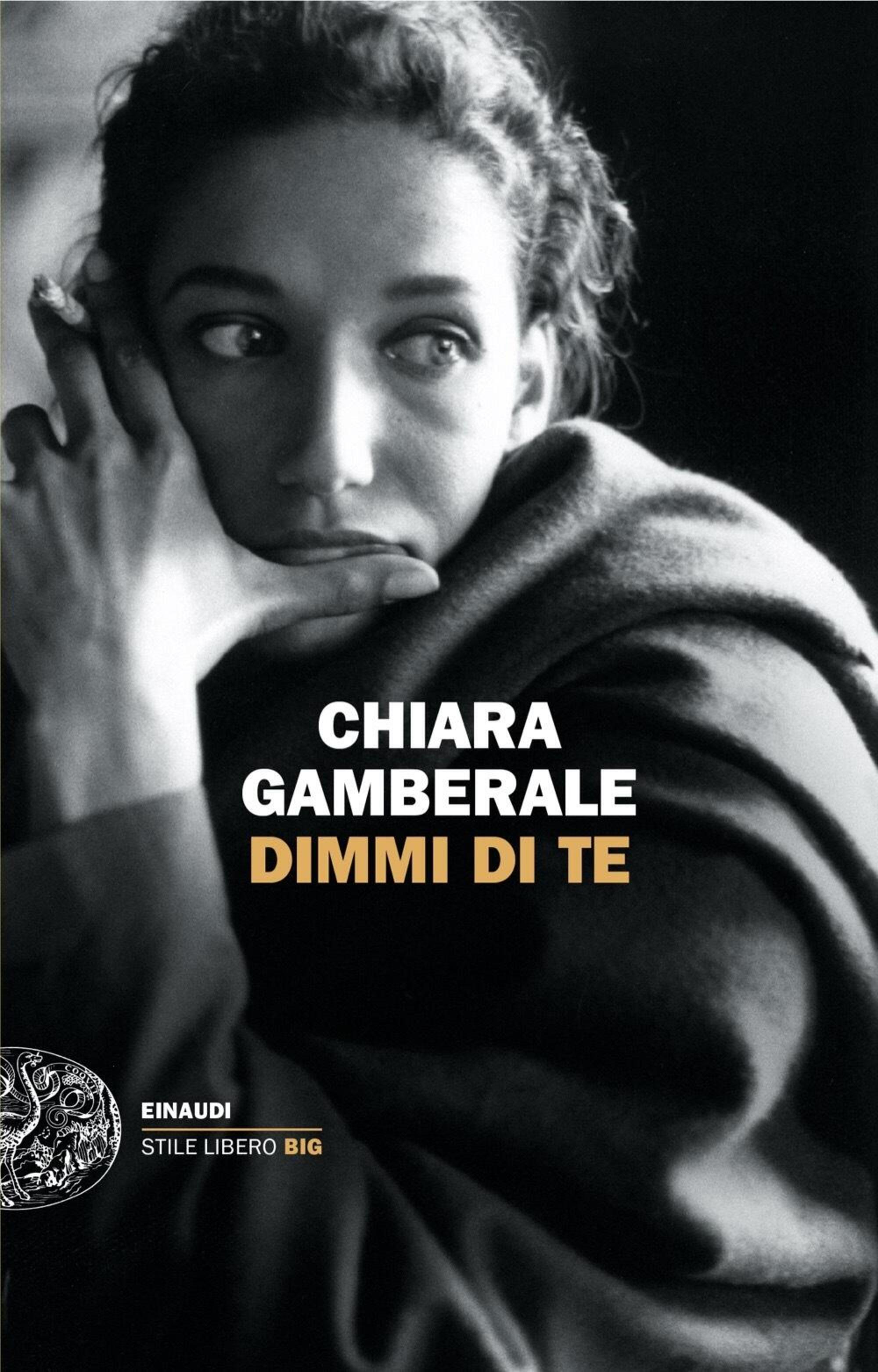

Peraltro, nel romanzo troviamo tutti quei topoi a cui ci hanno abituato la maggior parte delle scrittrici e degli scrittori italiani di oggi per bene, ovvero quelli che piacciono, quelli che vincono premi: la protagonista che di mestiere fa la scrittrice, l’ambientazione romana, l’estrazione borghese – la mansarda bohémienne e il Quartiere Triste – e una visione del mondo che finisce dove finisce il Grande Raccordo Anulare. Non manca, neanche, l’abusatissimo tema della fauxstalgia, la nostalgia di maniera per il passato perduto: ormai in Italia non esce un libro, un film o una serie tv che non tratti qualcosa di accaduto nel passato recente, ovvero il recent period history, metafora (questa si, magnifica) di un Paese con lo sguardo rivolto all’indietro, talmente depresso da essere incapace di immaginarsi qualunque tipo di futuro. Anche l’espediente narrativo è stravisto, il viaggio alla ricerca degli ex miti del liceo, sulla scorta di un film cult come Il grande freddo o, più probabilmente, di Compagni di scuola di Carlo Verdone. Intendiamoci: non c’è niente di male a utilizzare un topos poco originale o addirittura stereotipato, a patto che poi lo si carichi quantomeno di sfumature nuove; ma qui si resta saldamente ancorati al soporifero viaggio nel passato, alla ricerca del traumino responsabile di tutte le sofferenze dell’oggi, in questo caso il suicidio della migliore amica (giusto per restare in tema Il grande freddo).

Più in generale, Dimmi di te parte da una premessa generazionale in perfetto target quarantenni confusi (il target privilegiato dell’editoria di oggi) ma resta avvolto in un’indolenza della memoria, con personaggi sbiaditi, che potrebbero appartenere a qualsiasi epoca. Non c’è l’affondo su una generazione di equilibristi del lavoro e delle relazioni in cerca di una “stella polare” qualsiasi, non c’è una riflessione sul mondo che li ha illusi e su cosa abbia finalmente aperto loro gli occhi (come ne “Il grande freddo”). Ci sono una sfilza di luoghi comuni e idee superficiali – che di nuovo, paiono le prime che vengono in mente, buttate giù di getto: da Stefano, l’amore platonico soprannominato Terence in onore di Candy, Candy, a Ivan, il rappresentante di Istituto “il più anarchico, il più strano, il più irresistibile degli artisti” (e questa sarebbe una descrizione?). Il ritratto dell’adolescenza riportata in vita dal suo peregrinare antropologico, tra un aperitivo a Palermo e una visita al maneggio fuori Roma, è pigro, artefatto e astratto, scarno di dettagli microscopici ma che renderebbero l’idea della vita e dei ricordi vero. Per esempio: parlando di Riccarda, la bella della scuola, la descrive come una che indossava “i jeans giusti, le Adidas del colore giusto, le commozioni giuste (cfr. quelle per Kurt Cobain, tanto per cambiare)”. Dov’è la componente referenziale del linguaggio?

Del resto i libri della Gamberale sono come i libri harmony, si assomigliano un po’ tutti, e non ci sarebbe niente di male, letteratura di consumo per cougar inquiete del quartiere Prati da consumarsi dopo i pasti; è che lei - occhi ridotti a fessure, sguardo pensoso fuori campo e l’immancabile bianco e nero – pare convinta di essere una nuova Goliarda Sapienza e si fa un po’ fatica a rimanere seri quando si legge la frase che il custode del cimitero di Ventotene rivela alla protagonista a conclusione della sua travagliata quest interiore, e che dovrebbe costituire il climax del romanzo, la perla di saggezza che resterà incisa nella memoria del lettore: “non siamo noi ad acchiappare i nostri sogni. Sono i nostri sogni che acchiappano noi”. Tutto questo casino, insomma, per una rivelazione da uomo di mezza età al terzo grappino, quando a proposito della passione per la corsa si lancia in sontuose banalità tipo “non sono io ad aver scoperto il running, è il running che ha scoperto me”. In una parola: schadenfreude.












