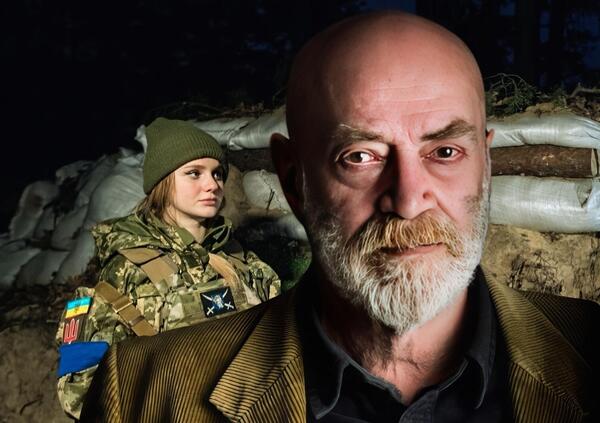Fermo, questa cittadella quasi in fondo alle Marche e a metà più o meno spaccata d’Italia, “firma fides romanorum colonia”, è un non luogo tutto speciale: di una desolazione a volte traumatica quando assolata, di una cupezza definitiva se piove, poca gente in giro, pochissima, l’intreccio medievale di viuzze di vicoli come quello degli Aceti che cala a strapiombo si direbbe fin dentro le profondità degl’inferi terreni, borgo o villaggio di salitelle, di discese che ingrossano i polpacci alla gente che risulta di un localismo fanatico e vagamente razzista, resiliente, catafratto alla globalizzazione: “Tu però non sei di qui, tu sei di Milano, si sente; sei un milanese”, e per quanto vogliano dissimulare, la smorfia diffidente affiora, sempre. Diffidente e forse un po’ complessata: “Sì, d’accordo, il Duomo, ma vuoi mettere il Girfalco?”. Qui litigano, come dappertutto, ma su una cosa restano d’accordo oltre le generazioni, le classi sociali, le arti e mestieri che poco sopravvivono, l’economia calzaturiera quasi travolta, il piccolo commercio del centro appassito, sostituito da locali e pizzerie, Piazza del Popolo tra portici Dugenteschi e Sisto V che sorveglia incazzato, pizzeria diffusa: “Fermo la città più bella del mondo”. Ah, dunque voi avete girato il mondo. “Mai! Mai uscito da Fermo. Che vado a trovà peggio se vivo nella città più bella del mondo!”. Vuoi mettere il Girfalco.


A pochi metri dal Girfalco, che sarebbe il Duomo di Fermo, bello, ma anche quello decadente, poco frequentato, l’hotel Casina delle Rose in attesa di chi lo riesumi da anni e annorum è diventato colonia felina, tutti gatti neri, mai visti tanti neri tutti insieme, a pochi metri dalla cattedrale dove Napoleone, il predone, mandava a fregare i mattoni, da cui il motteggio indispettito, “i francesi sono ladri? Non tutti, ma una bona parte di sicuro”, a un soffio in salita da qui c’era, e c’è, la casa di Mario Dondero, il fotografo comunista. Che passa da fermano, miracolo, e invece era proprio milanese, era un “giamaicano”, dall’immaginifico bar Jamaica degli intellettuali, gli artisti come Jannacci, i magnaccia, gli zanza, roba lontana, anni Sessanta e Dondero c’era e dirigeva la congrega. Milanese del mondo, fotografo moralista – niente tinte “perché fotografare una guerra a colori non è etico”, sosteneva Emergency, lavorava coi grandi fogli di sinistra, l’Unità, Paese Sera, ma anche con le testate borghesi e a un certo punto scopre Fermo; lo seduce quella malinconia greve, ombre medievali a danzare muri di mattoni scrostati dove una vecchia scritta può resistere agli uomini che passano e vanno, la identifichi ancora sessantenne ricordandola quando, bambino, ci venivi in vacanza. Qui c’era e c’è la sua casa studio, cento metri quadri nel profumo di muffa e di vegetazione fresca, alimentata dalla brezza che sale dal mare di San Giorgio, sette chilometri più giù e se vuoi disperderti per quei dedali trovi dal silenzio torpido delle colombe tubanti una musica in fuga da bifore antiche, sono gli studenti del Conservatorio, molti i cinesi, e in quegli spifferi barocchi o romantici ti vien voglia di abbandonarti al pianto, non sai perché, forse perché stai invecchiando, perché la vita se n’è andata e hai scoperto che è solo caso nel caos. La casa di Dondero, col suo patrimonio di scatti e diapositive in bianco e nero, i figli la vogliono vendere; si sa come vanno queste cose, lui, il fotografo del mondo, scomparso da quasi dieci anni, gli eredi che dicono: ma noi cosa dobbiamo ancora accollarci questo patrimonio ingombrante di ricordi, di tasse e di ristrutturazioni. Mentalità milanese che ai fermani non piace tanto. Così è sorta una Associazione Belvedere piena di buone intenzioni quasi guareschiane: “La casa di Dondero la prendiamo noi”. Però con un piccolo aiuto dagli amici, siccome i soldi non ci stanno, col crowfunding, la beneficenza diffusa. Poca roba: bastano trentamila euro, roba che a Milano manco le piastrelle del cesso ci compri. E questo invece è un patrimonio da oltre quattrocentomila momenti del mondo e del tempo. Laura Strappa, ultima compagna di Mario, ci crede; e questa, sì, sarebbe una storia a lieto fine, crudele e poetica, guareschiana, se vi pare, che non può finire che così: ogni tanto il bene deve pur trionfare su questo male mediocre di influencer, di balorde pecore matte che si scannano, si avvelenano, si scaraventano da un cavalcavia, con tutti che calcolano solo in soldi, senza più distinguerli fra puliti e criminali, anzi meglio se criminali, e quanto ha venduto il tale scrittore, quanti clic il sedicente musico, e cosa rende ogni clic?

Una storia medievale, se si vuole, fuori tempo, fuori luogo, ma di uno slancio, di una tenerezza che forse trionferà. E che però non si accontenta, vuole qui un’appendice. Dondero conosceva il mondo, i suoi orrori e forse per questo a un certo punto aveva deciso che era abbastanza, si era lasciato raggiungere dalla vecchiaia, adottando Fermo desolata e seducente quale definitiva dimora. Ma l’istinto della sensazione, la caccia alla sensazione non lo abbandona, così un giorno capita da un altro vecchio, il poeta Lugano Bazzani, che sta sul mare, a Porto San Giorgio. Lugano è un poeta, un donnaiolo, povera Maria, che sa tutto e tutto perdona, è uno che non ha studiato ma coltissimo, non ha mai lavorato se non da cronista, all’Unità, a Paese Sera pure lui, capace di intuire come nessuno gli umani, i loro abissi, i loro riscatti. È un pessimista ed è un comunista, ma, avverte, “si canta sempre dell’uomo”. Dondero fotografava sempre l’uomo, anche nella bufera furibonda della Storia. Com’è come non è, un bel giorno i due s’incontrano, Mario capita a far visita a Lugano: questo lo riceve in pigiama e calzini spaiati, sdraiato sul letto perché gli piace vittimizzarsi, e pare uscito da quella canzone di Renato Zero: “Svegliatevi poeti, eccovi qui, spettinati e scalzi…”. Preciso. Ha un busto, gli hanno fatto un busto di bronzo: lo usa per lasciarci il cappello. Entra Dondero e Lugano comincia a irretirlo coi suoi racconti, la sua saggezza paradossale, da poeta. Sono due grandi cuori, e sono due percettivi, due sensuali che si incontrano e s’intrecciano, si sfidano a loro modo il marchigiano nato e vissuto e l’altro, d’adozione, di rimbalzo. Lugano non esce mai da quella casupola, dalla sua stanza in particolare, che dà su un fazzoletto di giardino con un albero fiorito: qui, come un Salgari lirico, non immagina pirati e tigri feroci, ma i vortici della disperazione che presto mette in versi. Lugano parla, e parla, e racconta e Mario scatta, cattura; poi non ricordo dove uscì quel servizio che solo due poeti, due matti potevano mettere insieme. Dondero dev’essersene tornato bello stravolto a casa, nel suo rifugio sette chilometri più su, “in cima a una collina sta Fermo fabbricata”, se due giorni dopo una forza misteriosa lo sospinge ancora, quasi di risacca, nella stanzetta dell’amico ormai: “Io non so cos’è: ho visitato il mondo, ma devo tornare qui; qui c’è qualcosa”. Altro che qualcosa, c’era tutto il mondo che nel mondo non si trova. C’erano atmosfere e sensazioni, ondate silenziose come dai quadri di una pinacoteca, e lampi di leggerezza del poeta che, dopo averti accompagnato in fondo alla consapevolezza, ti lancia una fune d’ironia. Mario era milanese, scafato e fragile. Lugano era sornione e languido; l’unico insonne che, se ti vedeva passare in bicicletta alle quattro del mattino, non ti faceva la domanda del resto del genere umano, “che ci fai in giro a quest’ora”, no, lui ti diceva: vieni, e parliamo della vita. Allora salivi in veranda e parlava solo lui. Tu ipnotizzato. Finché aggiornava e gli uccelli cominciavano a ricamar l’aurora e lui ti guardava affettuoso sornione: “Adesso puoi andare a riposare”. E tu, come Mario, andavi via stordito ma già bisognoso di tornare.