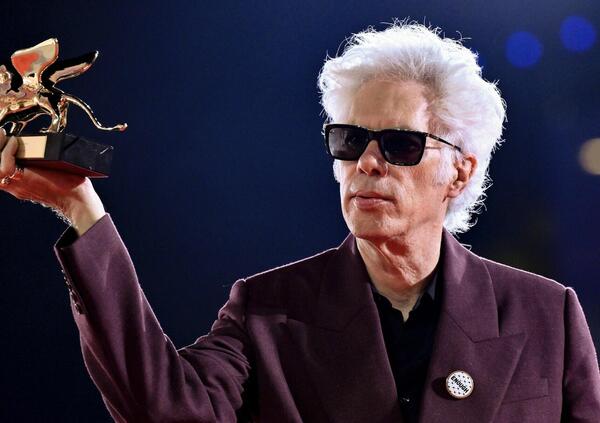Lucia Mascino. Il palcoscenico, il cinema, la forze delle parole e la sensibilità di un’attrice che abbiamo conosciuto (tra i vari progetti) in Amori che non sanno stare al mondo e I Delitti del BarLume, diretta a teatro anche da Filippo Timi, Giuseppe Piccioni, Lucia Calamaro e Serena Sinigaglia. Lucia Mascino è venuta a trovarci nella Terrazza dell’Hotel Excelsior e le abbiamo chiesto tante cose: le sorti della commedia all’italiana, l’importanza di chiamarsi Eleonora Duse in un tempo in cui è tutto commentato, visto, letto online e offline. Lei, la Duse, che l’attrice anconetana ha studiato molto bene. E poi la vita, il cinema. Anzi ‘la vita prima del cinema’, come diceva Comencini ne Il tempo che ci vuole. E sulla Global Sumud Flotilla…

Lucia Mascino. Serie tv, film, teatro. In un’epoca come la nostra tra social e intelligenza artificiale che cosa dovremo recuperare dal linguaggio teatrale?
A teatro vivi un'esperienza unica che non sarà mai uguale alla replica successiva. È il presente, il ‘qui e ora’, sia per gli attori che per il pubblico. Condividi quegli istanti solo con chi è in sala, probabilmente molti di meno rispetto a chi mette like o commenta sui social, ma la condivisione è di tutt'altra natura.
Hai recitato in diverse commedie, qual è lo stato di salute della commedia italiana?
Con un passato così forte come il nostro è difficile fare paragoni. Un passato così grande, così immenso di scrittura, di interpretazione, di nomi, di chimica che si creava non è facile da confrontare con l'oggi. Però ci sono ancora commedie di valore, penso ad esempio alla commedia garbata di Aldo, Giovanni e Giacomo, che fanno ridere tutte le generazioni le cui battute si ripetono per anni e che ancora adesso, diretti da Massimo Venier, hanno fatto dei film molto divertenti e toccanti (non perché ho partecipato). Poi penso a Gigi Proietti e alla sua grandezza, quanto ci manca.
Probabilmente non è così solo in Italia.
Anche all'estero il linguaggio della recitazione si evolve, è come l'architettura, non può essere sempre uguale negli anni. In questo momento in testa ci sono gli inglesi, prima ancora degli americani, che hanno raggiunto una recitazione 'nuda' dove la soglia del vero è proprio accanto, vicinissima. Capaci anche nella commedia di spogliarsi della caricatura, della macchietta. Io sono una grande amante di Totò, di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, ma adesso parlo della recutazione non grottesca, di cui loro erano maestri. E comunque anche Totò a suo modo era sottrattivo. Tornando alla recitazione naturalistica mi sembra che il linguaggio stia andando ancora più avanti e gli italiani devono accorgersene.
Cosa intendi?
Abbiamo una grande espressività e questo è un valore, ma serve togliere più che aggiungere. Non per mummificarci, le esagerazioni nella vita esistono, ma non bisogna perdere il fluido della naturalezza, bisogna lasciar accadere più che forzare.
E I Delitti del BarLume in questo senso?
Il BarLume è una serie leggera, che contiene vari generi, vari linguaggi. È allo stesso tempo brillante, comica, demenziale e seria. È un caso unico in Italia, per questo è così seguita perché ha uno stile che non ha simili, nella sua libertà è solida perché scritta molto bene ed è recitata da ottimi attori. Sempre modestamente parlando.
Tornando al teatro, Eleonora Duse è protagonista di questa edizione della Mostra, un'attrice che in un certo senso non si è fatta molto vedere.
Sì, beh io sono un po’ fissata (ride, ndr) con la Duse perché è stata la prima a parlare di verità del ruolo, è stata la persona che ha trasformato la recitazione da qualcosa di esterno (nell'Ottocento recitavano attacandosi alle tende per rappresentare il dolore) a qualcosa di attraversato, di intimo. È stata la prima a introdurre in teatro una recitazione cinematografica. Erano gli anni di Stanislavskij e sarebbero arrivati poi quelli di Strasberg. Quando avevo 25 anni seguivo una coach americana, Geraldine Baron, che faceva dei seminari ad Asolo proprio perché la Duse è sepolta lì (per stare vicina ai migliaia di giovani soldati morti durante la prima guerra mondiale). Ho letto diversi libri sulla sua vita e sono racconti magnifici che ti fanno capire la sua grandezza, la sua importanza e anche la sua ricerca. Era interessata al cinema che era linguaggio nuovo che si stava sviluppando, ma ha fatto in tempo a girare solo un piccolo film, Cenere. Geraldine ce lo mostrava ogni anno, il seminario si chiudeva così. La Duse era maestra di concentrazione, infatti, ad esempio, per non perderla quando recitava al teatro della Pergola si faceva costruire una galleria di tulle nero per passare dal camerino al palco. Non vedo l’ora di vedere Duse di Pietro Marcello con la grandissima attrice Valeria Bruni Tedeschi.
Qual è un particolare, un momento che hai vissuto sul set che ancora oggi porti con te?
Ce ne sono stati tanti. Non posso vedere la sequenza finale del film Amori che non sanno stare al mondo di Francesca Comencini senza piangere per l'emozione che ho vissuto recitando quel ruolo.
Proprio in Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini c’è una battuta che ha fatto la storia, suo padre Luigi (Fabrizio Gifuni nel film) dice: “Prima la vita e poi il cinema”. Alla Mostra di di Venezia abbiamo visto che oltre all’arte c'è stata possibilità di parlare di tanto altro: lavoro, guerra, diritti.
Quella che stiamo vivendo è una situazione che non può essere solo politica, deve essere prima di tutto umana. C'è urgenza e necessità di tirare fuori la nostra voce. Per questo sono entusiasta di questo movimento della Global Sumud Flotilla e ho aderito a Venice 4 Palestine.
Perché farlo durante la Biennale a Venezia?
Dicono: occupatevi di cinema. Ma il cinema parla della vita, la racconta. Ci saranno sempre le emozioni, il legame tra un genitore e un figlio, le relazioni tra le persone. Di questo parliamo. È come se qualcosa si stesse distruggendo qui accanto a te e bisognasse continuare a non parlarne. Ma perché? Ben venga che la Mostra del Cinema sia diventata un luogo per confrontarsi su Gaza.