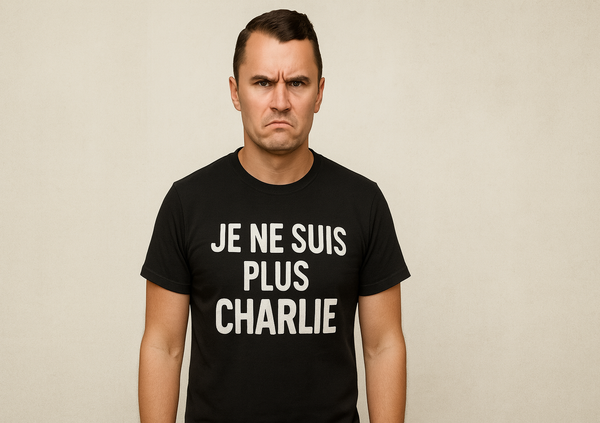Nel tennis, più che in qualunque altro sport, l’uomo è solo. Non la solitudine elegante dell’intellettuale, ma quella nuda, animalesca, del corpo che suda, geme, si curva sotto il sole e guarda verso il nulla, circondato da un pubblico e da un’entità su un seggiolone che lo giudicano.
Lì, in quella geometria arida del rettangolo di gioco, non c’è più differenza tra il deserto e il Golgota: il giocatore è un Cristo minore, un Adamo in pantaloncini che si ritrova orfano di divinità a ogni cambio campo, chiamato a ogni game a ripetere il gesto sacrilego di colpire la creazione e di percepire l’abbandono da parte del Creatore.
E al centro – simbolo perfetto dell’oscillazione metafisica – c’è il nastro. Una linea tesa tra cielo e terra, tra l’errore e la salvezza, che a volte si fa carne, anzi rimbalzo. Quando la pallina vi si infrange e ricade, è come se Dio – un Dio burlone, forse vendicativo, certamente non neutro – dicesse al tennista: “Ti ho visto”. O “ti ho sentito”.
Lucia Bronzetti e la Madonna (con nastro) di Wuhan
A Wuhan, tra umidità e smog, Lucia Bronzetti ha vissuto la sua piccola apocalisse.
Una risposta: la palla colpisce il nastro, si impenna, rimane un istante sospesa – il tempo di perdere o trovare la fede – e ricade. Sul lato sbagliato, il suo. E lei, in un moto di confessione più autentico di mille credo, si volta verso il suo angolo, allarga le braccia e dice: “Ho bestemmiato troppo”. La frase più teologicamente compiuta del XXI secolo, e forse di ogni epoca.
Non un mea culpa, non un pentimento, ma una rivelazione. Il riconoscimento intimo del nesso misterioso che lega nel suo mondo la colpa al rimbalzo, la parola al destino. Non più Eva che morde il frutto, ma l’atleta che deduce che il peccato verbale ha conseguenze gravitazionali.
In quell’istante Wuhan non è più la città dei virus pandemico, ma una nuova Fatima o Medjugorje postmoderna: una rivelazione popolare, una grazia rovesciata, dove il divino – o un suo stagista cinese – si rivela non alla povera pastorella ma alla tragica tennista eliminata in due set.
Lucia Bronzetti non ha visto la Vergine: ha visto il nastro, e il nastro, strumento di correzione karmica, le ha parlato. E ha detto “30-0 Yuan Ye. Andrai al tie-break e partorirai con dolore la sconfitta”. La tennista romagnola ha scoperto che Dio non è morto: ha solo fatto outsourcing, come tutti, in Cina, sul bordo elastico di una rete, per pescare non uomini ma palle corte, per manifestarsi non nella grazia, ma nella beffa. Un Dio che ogni tanto si diverte a giocare a tennis. E probabilmente – conoscendolo – sbaglia anche qualche smash.

Lorenzo Musetti, o del bestemmiatore migliorato
Se la Bronzetti è la mistica della colpa, Musetti è il poeta del peccato. Non c’è tennista italiano più teologico di lui. Artista della racchetta e del paradosso, Musetti abita l’interstizio fra Caravaggio e Mosconi. “Sono migliorato con le bestemmie”, ha dichiarato, come se parlasse del rovescio o del servizio. È il più puro dei penitenti: sa di non poter tacere (“non è facile non esternare”), e tuttavia promette di provarci. “Noi toscani siamo un po’ così”, dice, quasi evocando un’etnologia della colpa scolpita del marmo del suo corpo carrarino. Lorenzo amministra il sacrilegio come un pittore che dosa il blu di un affresco, nella consapevolezza scellerata che non si può rinunciare al colore dell’offesa senza compromettere la profondità del cielo.
C’è in lui una tensione dantesca: desidera incontrare il Papa, ma non può trattenere la bestemmia appena avverte il silenzio di Dio su una palla break. Nei video e nelle gif dei fan che sui social lo immortalano come profeta del circuito Atp, la sua imprecazione non è suono ma gesto, vibrazione, arte performativa: una danza sacrilega che rimanda a una tradizione mediterranea in cui la blasfemia è l’unico linguaggio del sacro rimasto.
Jannik Sinner e il cane prima dell’ascesi
Jannik Sinner è l’altra faccia del mistero. Lui, che porta nel nome la colpa originaria – Sinner, il peccatore – ha scelto la via del silenzio, del gelo, dell’ascetismo di stampo quasi protestante. Ma in un video del 2019, quando era ancora diciasettenne adolescente e rosso di carne oltre di capelli e la sua anima era ancora sanguinante e non robotica, si sente la parola proibita – pochi punti dopo un “vaffanculo a tutti” – durante un match contro Barrios-Vera: non la bestemmia porcina del collega toscano, ma un’invocazione divina canina.
Il richiamo a un cane, sì: forse Anubi (simbolo egizio, psicopompo, come Socrate che nei Dialoghi di Platone esclama “Per il cane!”, ma non il cane che porti al parco, bensì il cane che ti porta nell’Oltretomba) forse solo un più culturalmente e geograficamente conforme pastore tedesco.
Era il suo grido di vita, il suo abbaiare allo spirito prima della conversione alla freddezza tecnologica, prima di diventare il monaco di ghiaccio della nostra contemporaneità sportiva, automa del ranking e del montepremi. Eppure, nella perfezione algoritmica del suo gioco, a volte si avverte la nostalgia di una parola che restituisca calore al freddo sistema del mondo. Soprattutto quando incontra Carlos Alcaraz.
Il miracolo napoletano di Blancaneux
Poi, come in tutte le agiografie, arriva il miracolo: un tennista francese, Geoffrey Blancaneaux, che in Florida viene richiamato per aver bestemmiato. In italiano. Interrogato dall’arbitro, si giustifica: “A Napoli lo dicevano tutti”. Un caso di trasmissione spirituale, per osmosi da frequentazione di torneo tennistico, della bestemmia. Altro che sangue di San Gennaro: il vero prodigio partenopeo è la blasfemia che passa di bocca in bocca, infusione linguistica dello Spirito Santo rovesciato, propagazione della reliquia per contatto, o per contagio.arriva il miracolo
Il francese non sapeva ciò che diceva, ma lo diceva nella lingua in cui Dio (o almeno il Dio bronzettiano di Wuhan) poteva capirlo, come un convertito in modalità glossolalia, ma con più cazzimma.
È la Pentecoste ribaltata del tennis globalizzato. Dalle lingue di fuoco alla lingua di fango.
Il rovescio di Dio
Musetti, Bronzetti, il giovane Sinner, Blancaneux, tutti compiono lo stesso gesto: lanciano un richiamo sgraziato, nella speranza che qualcosa o qualcuno li ascolti o perlomeno li osservi, anche solo per giudicarli, se non per amarli. La bestemmia diventa così il più italiano dei salmi: disperata, lirica, inutile. Un tentativo umano-troppo-umano non di insolentire Dio, ma di richiamarlo all’ordine. Come un bambino che, non trovando più il padre, lo invoca a modo suo, con i propri strumenti primordiali. Una straziante richiesta di compagnia nella solitudine del campo della vita.
La bestemmia, si dirà, è un’offesa. Eppure, come ogni peccato originario, contiene in sé il seme della redenzione. Il tennista che bestemmia non nega Dio: lo sfida, lo reclama, lo pretende presente nel suo box, o almeno come spettatore neutrale. Gli grida: “Esisti? Dammi un segno! Ti senti offeso? Querelami!”.
E la bestemmia, in realtà, è il contrario del nichilismo: è la richiesta disperata di un senso. Perché in fondo l’italiano (o il francese convertito), anche quando nega Dio, lo fa con troppa passione per riuscire davvero a smettere di crederci. Alla fine, la bestemmia non è che il rovescio della preghiera. A una mano come Musetti o bimane come Sinner? Fate vobis. E andate in pace.