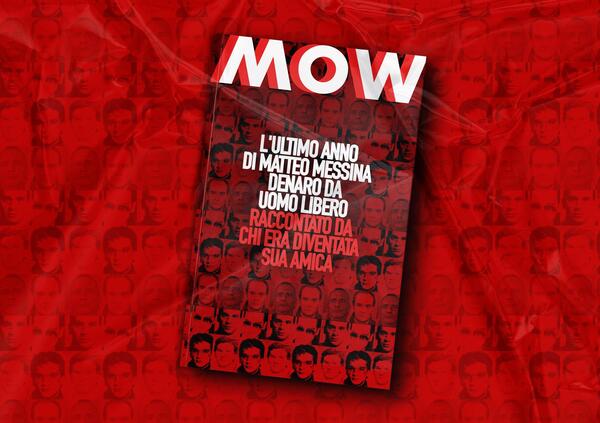Mario Ravidà è un uomo che sembra burbero. In realtà, però, è soltanto un uomo integro, che si è trovato in un luogo dove è stata fatta la storia e lì, in quel luogo, si è semplicemente guardato intorno. E ha fatto il suo lavoro. Che, purtroppo, non è servito. Perché la scoperta che aveva fatto è stata nascosta, cancellata. Avrebbe potuto contribuire a raccontare una verita, visto che molto tempo dopo possiamo dire che in tutta questa vicenda di verità ce ne sono poche, ancora troppo poche. Il luogo è via D'Amelio, 31 anni fa. Mario Ravidà all'epoca è un agente della Criminalpol di Catania e il giorno dopo la strage costata la vita al magistrato Paolo Borsellino e a cinque agenti della scorta, viene chiamato a Palermo per «dare una mano». Lui arriva e, assieme al collega Arena, individua preziosi elementi di indagine subito dopo l’attentato. Elementi che però non sono stati approfonditi e a quanto pare, forse, nemmeno messi agli atti. Solo che lui, quanto fosse importante ciò che aveva trovato, lo capisce soltanto 18 anni dopo. Adesso è in pensione e al telefono ci ha raccontato tutto quello che di questa storia non è mai tornato. Partendo dall'inizio.
«Ero sovrintendente della polizia a Catania – ci spiega Ravidà – e facevo servizio alla Criminalpol. La Criminalpol era diretta da Agostino (detto Tuccio) Pappalardo. Pappalardo telefona a casa la sera stessa dell’attentato, dunque il 19 luglio, e mi dice preparati, perché tu e altri tuoi colleghi dovete andare a Palermo per dare ausilio alle attività investigative dopo quanto successo. Ho detto va bene, mi sono preparato, e la mattina dopo l’attentato partiamo io e altri due colleghi. Arriviamo a Palermo, dove la Criminalpol era diretta da Di Costanzo, che conoscevo per altri fatti, e in cui lavorava anche il vicedirigente Tucci, con cui avevo un buon rapporto perché era stato dirigente anche a Catania. Andiamo direttamente sul posto, in via D’Amelio, per capire meglio ciò che era successo. Le macchine erano ancora fumanti e l'odore della carne bruciata non sono ancora riuscito a togliermelo dalla testa. Un collega va verso i palazzi distrutti e comincia a sentire le persone, mentre io e il collega Francesco Arena ci guardiamo attorno». Ravidà e Arena capiscono subito che doveva essere stato usato un esplosivo con telecomando: «Non c’era altro metodo, lì vicino non si poteva mettere nessuno». Escludono che chi l'ha azionato si fosse posizionato nel giardino che sta in fondo a via D’Amelio, perché i danni causati dall’esplosione erano tremendi. «Chiunque si fosse posizionato nei pressi di via D’Amelio secondo noi sarebbe stato coinvolto nell’esplosione». Poi, dietro il giardino che delimita via D’Amelio, vedono un palazzo in costruzione, di fatto definito in tutta la sua struttura. «Pensiamo che quello potrebbe essere stato il luogo ideale in cui posizionarsi». Ravidà e il suo collega fanno il giro dall’altro lato per raggiungere il palazzo in costruzione e notano che una lamiera che delimitava il perimetro aveva una porticina aperta. «Quindi entriamo. Le scale erano ancora grezze, non c’era nemmeno il passamano, e cominciamo a salire in questo palazzo. Gli appartamenti erano senza porte e incontriamo una persona. A quel punto ci presentiamo come poliziotti e gli chiediamo cosa stesse facendo là. Dice di essere tale Graziano, il costruttore del palazzo e che all’ultimo piano c’era anche il fratello, nell’ufficetto edile. Ci fa salire ed effettivamente c’era il fratello in questo ufficio grezzo in cui però c’era un telefono. Il collega, visto che non erano ancora diffusi i telefonini, chiede se lo poteva usare, chiama la centrale operativa e dà i nominativi dei due Graziano, per vedere se avevano dei precedenti. Nel frattempo io mi affaccio nel ballatoio che delimitava l’appartamento all’ultimo piano. E qui noto qualcosa di strano». Ciò che Ravidà nota è una lastra di vetro bella spessa apparentemente incrinata dall’esplosione ma ancora integra, e a terra vicino alla lastra un mare di cicche, venti-trenta, tutte posizionate proprio sotto la lastra. «E noto che c’era una visuale su via D’Amelio perfetta, una visuale aperta. Si vedeva tutto quello che poteva succedere. Un posto di osservazione eccezionale. Rientro e il collega mi informa che uno o entrambi avevano precedenti per associazione mafiosa ed erano conosciuti a Palermo. Senza dire niente a loro salutiamo, ringraziamo e scendiamo. Nel mentre salgono sei o sette colleghi della Criminalpol che conoscevamo di vista e che avevamo visto al briefing della mattina. Ci chiedono dei Graziano e noi diciamo che erano nel loro ufficio di sopra. Chiediamo se dovesse intervenire la scientifica e loro rispondo che si sarebbero messi loro a fare tutto. Noi eravamo in difficoltà perché non conoscevamo bene l'ambiente palermitano e lì ci sentivamo comunque ospiti e poi, soprattutto, all'epoca tante cose non erano note, non avevamo la minima idea di cosa potesse esserci dietro. Quindi ritorniamo in ufficio e facciamo una relazione. In questa relazione inseriamo i nominativi dei Graziano, quello che ci aveva detto la centrale operativa sui loro precedenti penali, i numeri di telefono di due cellulari di cui i Graziano erano in possesso, descriviamo i luoghi, parliamo della lastra, parliamo delle sigarette, diamo la relazione a Di Costanzo e ritorniamo sul posto. Intanto si erano fatte le due, le tre e andiamo a pranzo. Nel pomeriggio o la mattina successiva ci richiama il dirigente Di Costanzo e ci dice che non avevano più bisogno del nostro ausilio. E questa già ci è sembrata una cosa stranissima, perché di solito quando andavamo in missione fuori sede non stavamo mai meno di un mese, un mese e mezzo, a volte tre. Abbiamo atteso i funerali dei colleghi che ci sono stati dopo qualche giorno e siamo rientrati a Catania. Di questa storia non abbiamo saputo più nulla per circa diciotto anni».



18 anni dopo
Nel 2010 Ravidà e Arena sono a Palermo per testimoniare al processo ai carabinieri del Ros (Reparto speciale operativo) Mori e altri (poi assolti) per aver favorito la latitanza di Bernardo Provenzano, boss dei boss. «Nel frattempo eravamo stati spostati alla Dia di Catania e avevamo conosciuto Michele Riccio, colonnello dei carabinieri e dirigente della Dia di Genova, con il quale eravamo entrati in sintonia e che era l’unico a conoscere la vera identità di Luigi Ilardo, suo confidente, boss della mafia catanese che, una volta uscito dal carcere era rientrato in Cosa nostra come infiltrato (fu ucciso nel 1996, cinque giorni prima di entrare nel programma di protezione e tre giorni dopo aver partecipato a una riunione con magistrati e carabinieri tra cui anche il colonnello Mori). Grazie alla fonte Ilardo avevamo arrestato una cinquantina di persone del clan Santapaola. Agostino Pappalardo, colui che ci aveva chiamato per andare a Palermo il giorno della strage, è stato poi coinvolto nella questione del processo Stato-mafia per le sue diciamo discordanze di vedute che ha avuto proprio con Riccio. Contrasti in seguito ai quali Riccio è uscito dalla Dia per ritornare nei Ros di Mori. In occasione della testimonianza ci avvicina un giornalista, Nicola Biondo, e tra un discorso e l’altro siamo arrivati a parlare di via D’Amelio. Gli abbiamo raccontato del palazzo. Lui che era di Palermo e conosceva bene la situazione è rimasto impressionato e ci ha chiesto se questa cosa l’avessimo detta o raccontata a qualcuno. Noi abbiamo risposto che ci eravamo limitati a fare quello che era di nostra competenza in quel momento, ossia fare una relazione. A lui sembrava molto strano perché, pur occupandosi del caso, non aveva mai sentito di quella relazione. Nel frattempo erano morti anche Di Costanzo e il suo vice. Secondo Biondo, dovevamo informare i magistrati di Caltanissetta. Lui parlò con Caltanissetta e da lì fecero chiamare sia me che Arena. Facciamo la nostra deposizione e scopriamo che della nostra relazione non c’era traccia nel fascicolo della strage. Poi ci chiamarono al Borsellino Quater e abbiamo fatto la nostra testimonianza sulla questione del palazzo. In quel momento apprendiamo che in contemporanea alla strage c’era stata una telefonata anonima che avvertiva la polizia che c’erano stati strani movimenti di persone proprio sul palazzo che noi avevamo indicato. Però la relazione era sparita e nessuno aveva fatto indagini sui contatti telefonici che potevano avere avuto i Graziano, perché nessuno chiese i tabulati e all’epoca la Sip dopo dieci anni li distruggeva».
Poco dopo, in un articolo di stampa, si riferì che una ricostruzione della scientifica accertò che il telecomando sarebbe stato azionato dal palazzo dei Graziano. E Ravidà commenta: «Mi sembra stranissimo che a oggi nessuno abbia seguito seriamente questa pista. Abbiamo poi saputo che i Graziano avevano contatti con i Madonia di Palermo, indiziati per la strage e accusati dell’omicidio del mio collega Agostino e della moglie, un caso tuttora misterioso. I Graziano erano in contatto anche con il funzionario dei servizi segreti Bruno Contrada, a cui avevano dato degli appartamenti, non so a che titolo. E nelle fasi in cui sparì l’agenda rossa dall’auto di Borsellino e di cui fu poi accusato il capitano dei carabinieri Arcangioli i suoi uomini stavano ispezionando proprio il palazzo dei Graziano, e quindi erano proprio lì, ma non rilevarono nulla».

Queste cose Ravidà le ha raccontate anche in un’intervista a La7 registrata diciotto anni dopo la strage. Un’intervista mai andata in onda. Ora in pensione, dopo la Criminalpol Ravidà è passato alla Dia, dove è rimasto fino al 2011: «Poi – ci dice – ci furono le vicende relative all’omicidio di Ilardo, che mi hanno riguardato perché avevo un confidente e dopo sei anni dall’omicidio sono venuto a sapere con certezza chi erano gli autori materiali dell’omicidio, persone legate al clan Santapaola. Faccio la relazione di questa notizia che ho ricevuto nel 2001, per circa dodici anni non succede niente, perché nessuno ha voluto fare indagini, dopodiché si pente la persona che mi aveva dato la notizia, Eugenio Sturiale, e viene accettato come collaboratore di giustizia, testimone oculare dell’omicidio di Ilardo, che lui ha raccontato essere stato compiuto dalla squadra operativa di un certo Maurizio Zucchero, sospettato di aver avuto contatti con strutture istituzionali non meglio identificate. Perché? Perché era un ergastolano ma sempre agli arresti domiciliari e perché da un’intercettazione ambientale dei parenti dicevano che avrebbero ammazzato chiunque dicesse che Zucchero era uno sbirro, ossia che collaborasse con le istituzioni. Anche un altro pentito, Pietro Riggio, conferma questa versione». Insomma, Mario Ravidà, sia nella vicenda Borsellino, sia in quella Ilardo era riuscito a recuperare informazioni che avrebbero potuto velocizzare le indagini, portarle subito su un binario corretto. Invece prima di trovare riscontri alle sue intuizioni sono passati anni, troppi anni, e a essere nutrite non sono state le piste giuste ma quelle false, i famosi depistaggi che hanno reso la strage di via D'Amelio, l'omicidio Ilardo e tante tantissime altre vicende dei misteri inestricabili. E se si vuole rendere davvero onore agli anniversari, oltre alle commemorazioni, anche di queste cose dovremmo ricordarci.