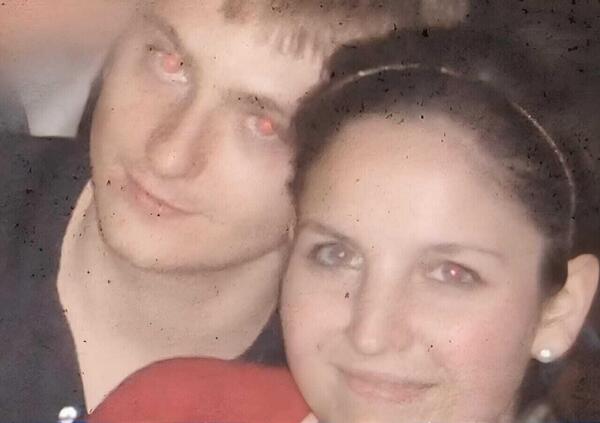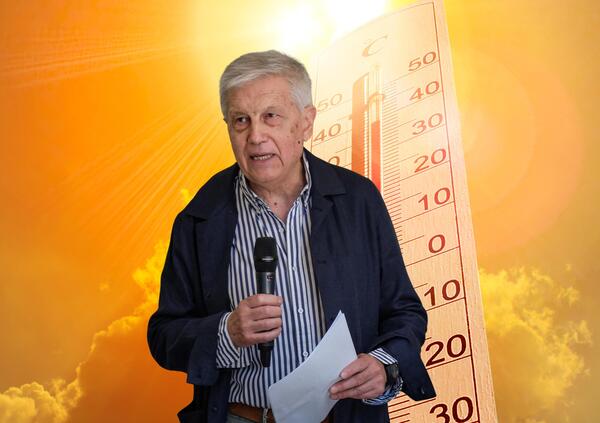La Casa Bianca è pronta a spedire a Bruxelles l’attesa “lettera dei dazi” che potrebbe spostare gli equilibri del commercio transatlantico. Nel frattempo, l’Unione Europea digerisce con difficoltà una tariffa del 10 % sulle importazioni, ma il vero rischio è il salto al 50 %, paventato da Trump come tagliando definitivo. Non parliamo di numeri astratti: l’Ispi stima che il dazio del 10 % riduca il Pil europeo dello 0,1 %, mentre se la tariffa salisse al 50 % il danno raggiungerebbe addirittura lo 0,7 %. Il peso della stangata non è equamente distribuito tra i Paesi membri. Italia e Germania, motori industriali e commerciali d’Europa, si ritrovano nel mirino. A maggio, il dazio medio sulle merci italiane si attestava all’8 %, mentre quello tedesco sforava l’11 %, con la Francia più defilata che si fermava al 6,4 %. In caso di raddoppio delle tariffe, le previsioni indicano che l’Italia rischierebbe di perdere circa lo 0,6 % di Pil, mentre la Germania toccherebbe lo 0,8 %, cifre che potrebbero avere un impatto devastante su crescita, investimenti e occupazione. Ma la faccenda si complica ulteriormente se si aggiunge il fattore valutario. Il dollaro, indebolitosi del 13 % rispetto all’euro da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, rappresenta un “dazio fantasma” che secondo Confindustria porta l’effettivo aggravio per le imprese italiane al 23 %. Anche l’Ispi, più prudente, calcola comunque un impatto reale del 21 %, considerando l’effetto combinato tra tariffe e svalutazione. In pratica, ogni prodotto esportato rischia di costare fino a un quarto in più, senza possibilità di scaricare totalmente i costi sul consumatore finale.

Bruxelles, consapevole della gravità della situazione, tenta una difficile manovra diplomatica. L’obiettivo è trovare un compromesso che mantenga un tetto massimo al 10 % e protegga i settori più esposti come l’automotive, la farmaceutica e l’agroalimentare. L’Unione spera di ottenere un’intesa simile a quella raggiunta dal Regno Unito, che ha già siglato un “mini‑accordo” con Washington. Il vicepresidente della Commissione Europea Maroš Šefčovič è volato negli Stati Uniti per negoziare un’intesa di principio, puntando a chiudere prima dell’avvio delle nuove tariffe previste inizialmente per il 9 luglio e successivamente rimandate all'1 agosto. Se le trattative si chiuderanno positivamente, le industrie europee potrebbero guadagnare tempo e respiro in vista di un’estate commerciale incandescente. Tuttavia, se dovesse prevalere lo stallo, l’Unione è pronta a reagire con fermezza. Bruxelles ha messo a punto misure ritorsive per un valore complessivo di circa 95 miliardi di euro, colpendo prodotti simbolo degli Stati Uniti come bourbon, motociclette, aerei e componenti elettronici. L’arsenale commerciale europeo è caricato e pronto a colpire, in un contesto in cui il terreno politico è già rovente. Cedere troppo significherebbe dare un’immagine di debolezza e mancanza di leadership, mentre una risposta troppo aggressiva potrebbe alimentare una spirale di protezionismo pericolosa tanto quanto le stesse tariffe. La sfida che si gioca in questi giorni non è solo economica ma anche geopolitica. L’Unione Europea vuole dimostrare di essere un blocco compatto, capace di proteggere la propria industria e di reagire in modo unitario alle pressioni americane. All’interno dei confini comunitari, però, emergono frizioni: mentre Germania, Italia e Irlanda spingono per una soluzione rapida e pragmatica, la Francia e altri partner invocano una linea più dura, per evitare di sacrificare interessi strategici a vantaggio di una tregua solo apparente. Il clima è teso, i mercati già scontano l’incertezza e le borse europee oscillano in attesa di sviluppi concreti. I future calano, l’euro è sotto pressione e la fiducia degli investitori traballa. La posta in gioco va oltre il breve termine: da questa crisi si deciderà non solo il peso del Pil, ma anche la capacità dell’Europa di essere protagonista nel nuovo ordine economico globale.