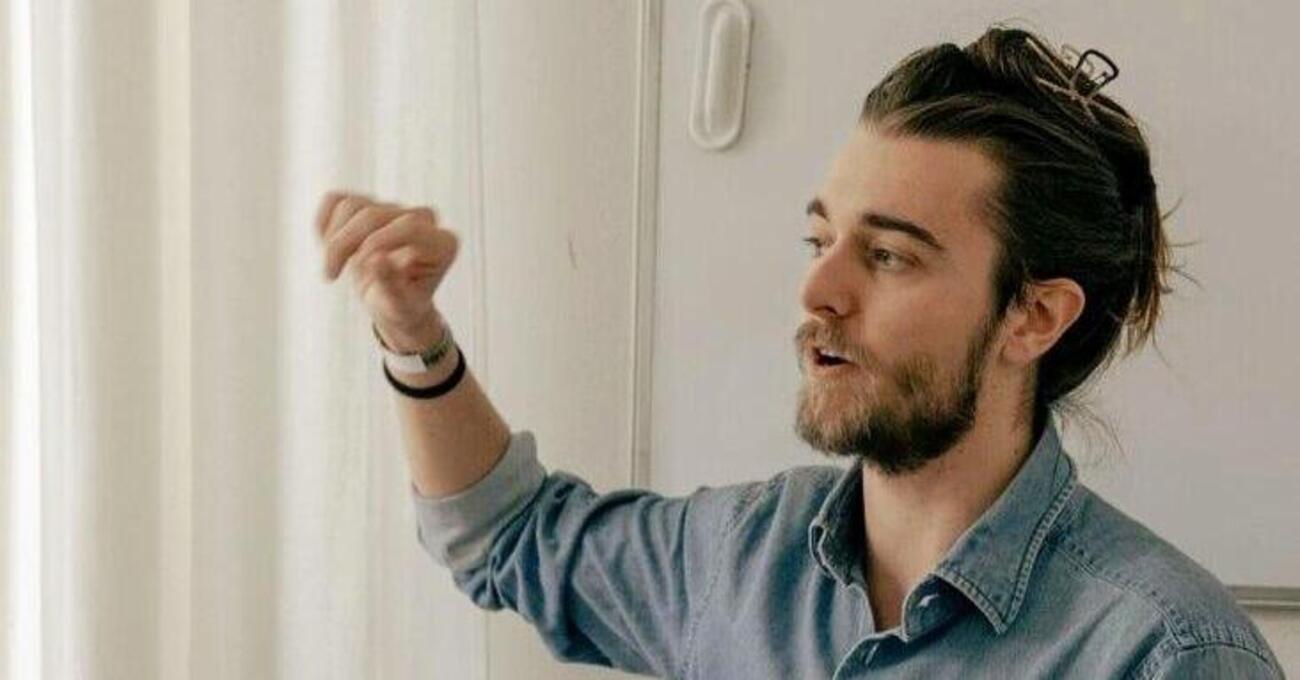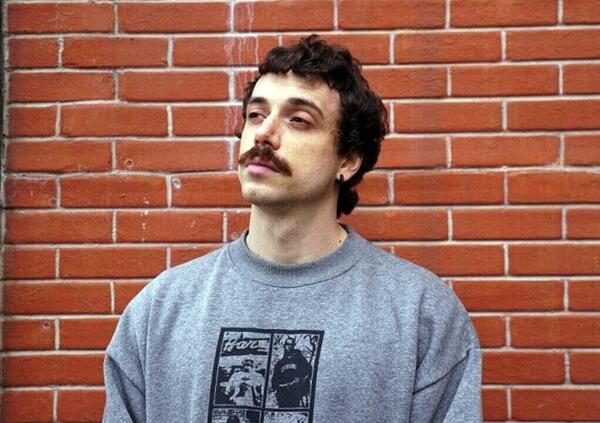A scuola, sul lavoro, per svago: il prompting è un'attività a cui oggi nessuno si può sottrarre. Detta facile, è quando facciamo fare qualcosa all'intelligenza artificiale. Creare testi, immagini, video. Se i vecchi elettrodomestici erano nati per alleviare le fatiche fisiche dei lavori domestici, Chatgpt e simili svolgono lo stesso compito relativamente alle fatiche intellettuali dei lavori creativi. Ora che l'utilizzo delle intelligenze artificiali è diventato un fenomeno di massa, però, come spesso accade per tutto ciò che rappresenta una novità, insorgono diversi problemi. Il principale è: delegare l'attività creativa e intellettuale, tanto razionale quanto irrazionale, alle macchine, ci renderà inutilmente bestiali rispetto a ciò che storicamente ci distingue dal resto del genere animale? Prompting, scritto da Niccolò Monti e pubblicato da Edizioni Tlon, indaga questo versante tematico, ancora poco spacchettato dal dibattito. La sfida principale riguarda l'idea di opera: come dobbiamo considerare ciò che viene prodotto dalla macchina? L'autore è ancora chi scrive i comandi o il computer stesso? Il limite è sottile, si capisce, e vale la pena di considerare diversi fattori per sviscerare la questione.


Anzitutto: cos'è un prompt? Niccolò Monti scrive: “In termini performativi, un prompt potrebbe essere avvicinato a quello che in linguistica e in semiotica si definisce un atto linguistico, ossia parole, frasi, gesti o interi testi la cui funzione è nell’effetto che sortiscono; si tratta di enunciati carichi di una forza pragmatica, come quando facciamo una promessa o impartiamo un ordine. E qui starebbe la funzionalità performativa di un prompt: impartire un ordine al programma, fargli fare qualcosa. Se da un lato l’impressione potrà essere che il prompt generi direttamente gli output, senza porsi ulteriori domande, dall’altro lato resta aperta e sospesa la spiegazione di cosa avvenga in quel frangente, quando il prompt viene inviato al modello generativo, poniamo a Chatgpt, affinché esso lo “legga”. Cosa si può dire che faccia un prompt?”. La filosofia è, o dovrebbe essere questo: affrontare la difficoltà per ridurla a qualcosa di semplice. L'informatica è il contrario: nascondere operazioni complesse sotto la schermata di un'interfaccia utente che dev'essere il più semplice possibile, facile da utilizzare. Si fa una richiesta a Chatgpt e la risposta arriva in pochi secondi. Nel caso di Gemini può anche capitare di doverci litigare dopo che ti ha insultato a morte. Un breve lasso di tempo in cui, a livello di elaborazione dati, succede di tutto. E il risultato dipende sempre dalla domanda. Stiamo parlando di estetica: la bellezza dipende dalla bravura, dall'accuratezza e dalla precisione di ciò che scriviamo nel prompt. Ok, ma si può parlare di arte? Monti richiama la scrittura automatica proposta dal Surrealismo, proponendo un paragone, senz'altro suggestivo, con ciò che viene prodotto. Tanto che, seppur circoscritto, c'è anche un inizio di movimento: il promptismo.
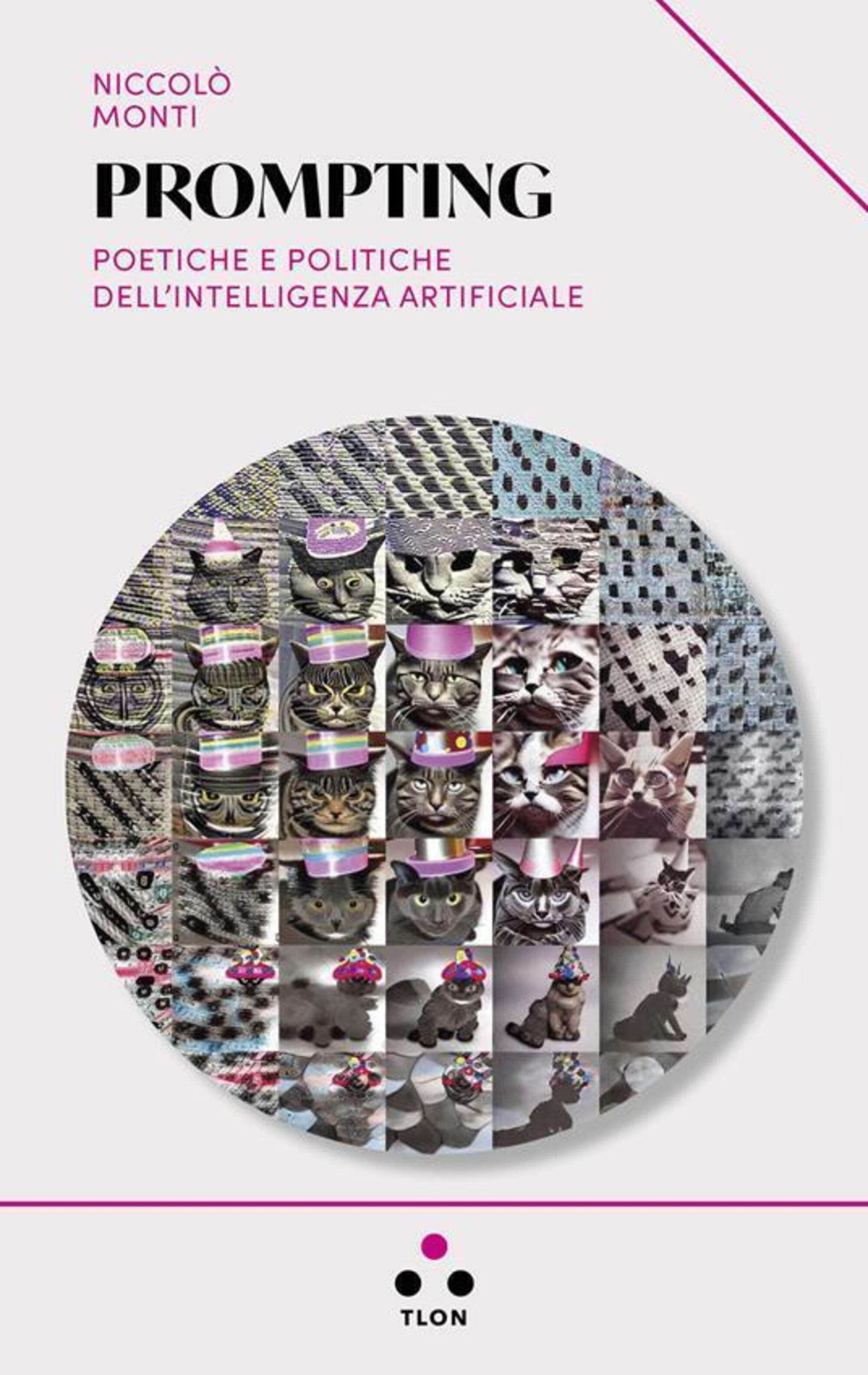
Da Prompting: “Il promptismo è al contempo un insieme – un movimento, o una comunità che tenta di definirsi – e una serie – i nuovi modi di creare suggeriti con l’arrivo dei modelli generativi, di cui una poetica cerca di mettere in luce le potenzialità e difendere la dignità. Non si può ignorare che si tratta di un discorso estetico fortemente derivato da un discorso tecnico, e perciò correlato agli interessi industriali (o a volte anche anti-industriali) che sostengono la diffusione dei modelli Ia. Se da un lato la contingenza non sarà lasciata da parte, dall’altro estetica e tecnica saranno correlate anche per via delle condizioni favorevoli che, dall’inizio del secolo scorso, hanno portato al prompting”. In altre parole, la tecnologia ha soddisfatto un'esigenza artistica già iniziata nel secolo scorso, con il Surrealismo e il Futurismo. “La scrittura automatica surrealista non sarà esattamente la stessa cosa di una scrittura automatizzata, non da un punto di vista storico né strettamente artistico. Eppure, sia la prima sia la seconda – della quale è un esempio il prompting – sono riconducibili alla stessa condizione tecnologica: automatico e creativo non si escludono”. Si può creare con l'intelligenza artificiale, questo è il punto. La creatività non esclude l'automazione. Anzi: l'atto creativo in sé, non è già una mediazione tra la riflessione e l'istinto? E l'istinto, non è qualcosa di automatico? Come sottolinea Monti: “La parentela che va riconosciuta tra la via surrealista e la via promptista sta nella pretesa di sfruttare l’automatico – della vita psichica oppure della macchina – in un senso operativo, come parte integrante della preparazione dell’opera e non come l’esito di un esercizio”. La differenza, però, volendo spingere ancora la riflessione del libro, è proprio nell'esercizio che conduce all'esito. C'è un abisso. È passata un'epoca da quando Andy Wharol creava opere d'arte digitali con un mouse su un computer Amiga 1000, e Oliviero Toscani a MOW aveva spiegato di non aver visto una sola immagine prodotta con intelligenza artificiale che non fosse “una cagata”, e che l'Ia non era creatività ma “dipendenza dalla tecnologia”. La creazione di un'opera d'arte, nella storia dell'umanità, coincide con la scoperta e l'utilizzo degli strumenti.
I primi dipinti sulle pareti delle grotte, le prime sculture. La mano, da sola, non crea nulla di duraturo, ma fino a che punto è giusto considerare Chatgpt e Grok come l'ultima evoluzione della pietra? C'è un abisso, dicevamo, perché nel processo creativo l'opera è sempre rifinita direttamente dalla mano, o dal linguaggio umano. Nel prompting l'uomo non arriva mai a produrre l'opera, se non nel concepirla e modellarla. Vale la pena di riprendere la distinzione tra attore e autore, così come l'aveva pensata Tomas Hobbes. All'autore appartengono le parole, mentre l’attore agisce in nome dell'autore, viene autorizzato. Così, attraverso il prompting, l'intelligenza artificiale ci illude di essere autori mentre invece siamo attori. Le parole, il dataset, le informazioni e i collegamenti appartengono a Chatgpt. Noi la facciamo soltanto funzionare, più o meno creativamente bene. Anche se poi, in fondo, le parole gliele abbiamo regalate noi, in quanto umanità, e non facciamo altro che chiedergliele indietro. Da questo punto di vista, forse siamo più funzionali noi a lei, che non viceversa. La questione sarebbe comunque da approfondire, e chissà cosa penserebbe Walter Benjamin, con la sua teoria estetica sull'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica, ora che le opere non si possono più soltanto riprodurre, ma perfino creare in maniera altrettanto industriale. Basterà l'unicità apparente e combinatoria del risultato, a renderle qualcosa di creativo?