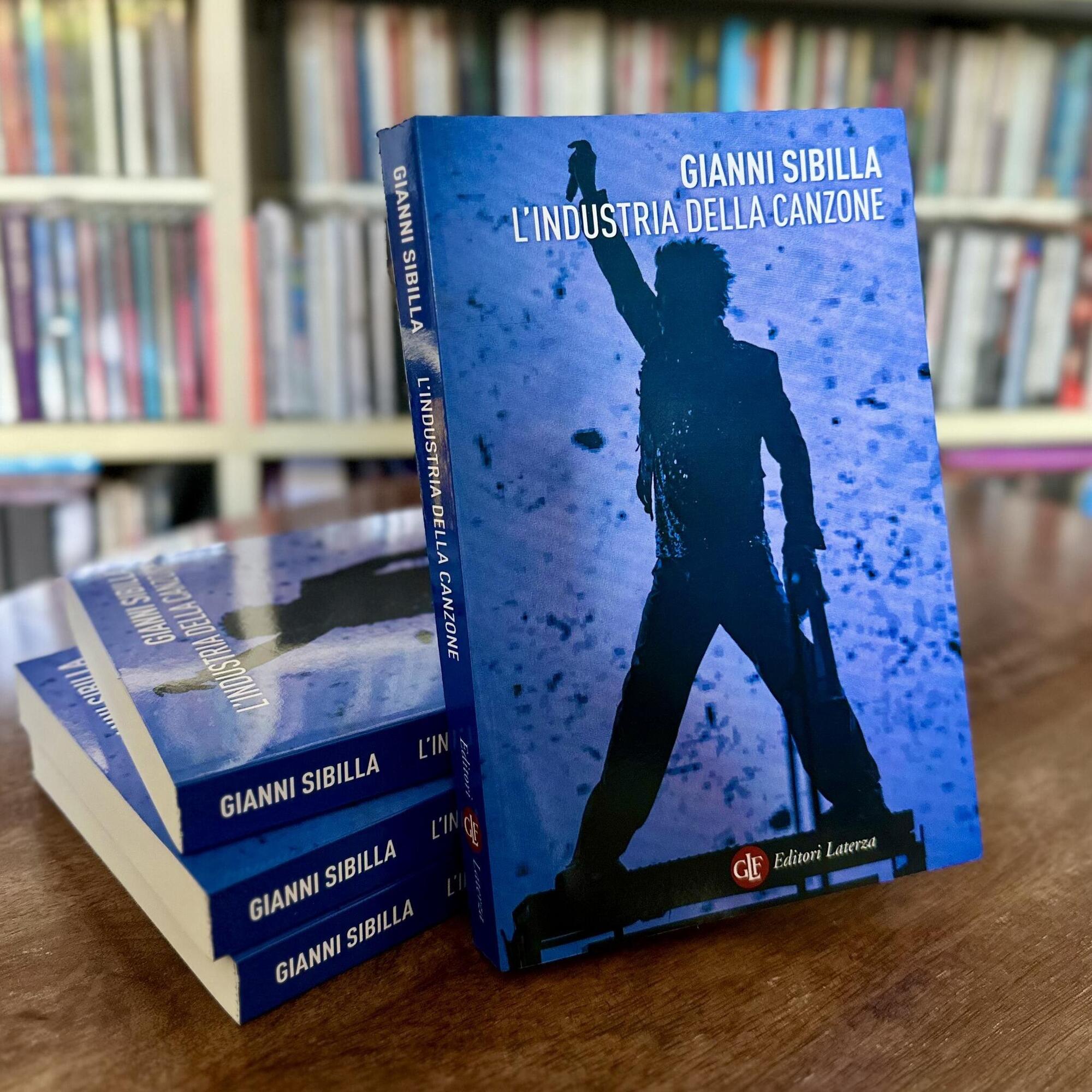Un titolo come “L’industria della canzone” (Editori Laterza) non tragga in inganno. Gianni Sibilla, l’autore del volume, sarà anche colui che, provvidenzialmente, ci spiega i trucchi del mago (l’industria), ma il suo atteggiamento, quando si parla (o si scrive) di musica quasi mai risulta cinico. Grande fan di Bruce Springsteen, U2, R.E.M. (e tanti altri), Sibilla – direttore didattico del Master in Comunicazione musicale dell’alta scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica di Milano, dove insegna "Mercati e media musicali" alla facoltà di Scienze Linguistiche; docente anche all'Università IULM di Milano – non è affatto nuovo al mercato editoriale (diversi i titoli pubblicati). Dal 2001 caporedattore di Rockol, vent’anni fa circa usciva con il fondamentale “I linguaggi della musica pop” (Bompiani), mirabile excursus sui meccanismi visibili e invisibili che regola(va)no il mondo pop. Oggi torna sul luogo del delitto. Ancora una volta con un mucchio di cose da dire.
“L’industria della canzone” potrebbe rivelarsi una lettura obbligatoria per chi desidera mettere un piede in questa industria. Allo stesso tempo potrebbe aprire la mente a chi troppe volte, pensando o parlando di canzoni, fatica ad accettare che anche di industria si tratti…
Questo testo nasce sia per mettere a fuoco alcuni concetti chiave sulla musica pop, sia per raccontare in modo accessibile il dietro le quinte della canzone. È indirizzato soprattutto ai miei studenti e a chi vuole farsi un’idea di come funziona la musica. Non pretendo di spiegare questo mondo a chi già ci lavora… Però, agendo io stesso ormai da diverso tempo in questo contesto anche da professionista, e studiando da molto tempo il rapporto tra musica e media in università, ho provato a osservare e raccontare i meccanismi ricorrenti che regolano questo ecosistema. È un libro per chiunque voglia capire come mai passiamo così tanto tempo ad ascoltare canzoni, che ci inseguono in ogni momento della nostra giornata. Ho provato a smontare il giocattolo e mostrare gli ingranaggi.
La sensazione è che fosse più semplice smontare il giocattolo prima, con il vecchio sistema discografico. È vero?
Sì e no. Oggi ci sono molti più ingranaggi, sicuramente: la musica è molto più frammentata di prima, basti a pensare a tutti i device che abbiamo a disposizione per ascoltarla e in quanti luoghi diversi la fruiamo. Alcune dinamiche, però, sono storiche e ricorrenti. Paradossalmente Taylor Swift non è molto diversa da Elvis: ha molti più strumenti a disposizione, ma la sua fama e il suo successo nascono sempre dalla capacità di scrivere canzoni che parlano ad un pubblico, dalle sue performance spettacolari, dal sapere utilizzare bene i media per raccontarsi, dalla capacità di sapersi creare un fandom fedele. Uno dei problemi di come si parla di musica oggi è che, inevitabilmente, ci si concentra sul presente: credo sia importante mettere in prospettiva, capire da dove arrivano le forme di comunicazione della musica, alcune presenti già da molto tempo anche se oggi sono all’ennesima potenza. Non è sempre tutto nuovo e rivoluzionario.

Un libro simile è anche necessario per spiegare quanto ci sia di poco misterioso nel successo della trap pop-izzata o del pop trap-izzato, a seconda dei punti di vista. La trap ha definitivamente conquistato l’industria?
È il nuovo pop. È una scena che vanta alcuni strumenti peculiari, molto generazionale, però alla fin fine arriva negli spazi tradizionali. Lazza e Ghali che vanno a Sanremo, Sfera Ebbasta che fa San Siro. Pensiamo, un paio di anni fa, al Love Mi di Fedez, che somigliava molto ad una versione aggiornata del vecchio Festivalbar, ad una generazione di nuovi artisti nati con lo streaming e i social media, che arrivavano in Piazza del Duomo e in prima serata in tv. Per le altre generazioni è facile dire “fa tutto schifo”, ma credo che prima di giudicare sia necessario capire le ragioni del successo. E poi non nascondiamoci: anche tanta musica della mia generazione era brutta, ma ovviamente ricordiamo solo le cose migliori, quelle che sono rimaste. Non so cosa rimarrà della trap, bisognerà vedere cosa resiste al tempo, ma è la musica che sta segnando una buona parte di una generazione. Ripeto: gli elementi della musica brutta, le melodie banali, gli stereotipi, la ripetizione seriale di modelli di successo, ci sono sempre stati anche in passato. La differenza è che oggi c’è molta più musica in giro perché è molto più facile farla e distribuirla.
Nel mondo ampiamente globalizzato in cui viviamo ha senso di parlare di “industrie” al plurale? Intendo dire: quanto la scena italiana è simile o differente dalle scene di altre nazioni europee?
Se guardiamo alle industrie del live, dei media e della discografia, la maggior parte delle aziende sono multinazionali, lavorano su priorità globali. Le varie industrie dell’intrattenimento – che una volta lavoravano a compartimenti quasi stagni – sono sempre più interconnesse tra di loro. Per dire: la musica registrata è distribuita dalle piattaforme streaming, che sono tech company e come tali ragionano e che a loro volta influiscono su come la musica viene fatta: è quella che alcuni studiosi chiamano “piattaformizzazione della produzione culturale”. Poi, certo, i mercati locali sono fondamentali: in Italia si ascolta prevalentemente musica italiana e in classifica vanno rap e trap, oltre che pop, mentre se uno guarda la classifica inglese, i generi che funzionano sono molto diversi. Ma i modelli produttivi e le forme di comunicazione e marketing sono simili ovunque.
C’è un paragrafo sullo storytelling, assolutamente necessario in un volume che esce nel 2024. Perché è così importante?
È una parola abusata, “storytelling”. Di fatto la musica pop ha sempre vissuto di storie e racconti, anche prima che questa parola diventasse di moda nel marketing. E più in generale l’atto del raccontare è la base dell’esistenza di qualsiasi cultura. Nella musica si faceva storytelling prima di chiamarlo in questo modo: le carriere artistiche sono sempre state pensate come racconti e le popstar come personaggi. Nella musica però è centrale la credibilità: se uno storytelling è un bluff, se è troppo sganciato dalla realtà prima o poi il gioco viene scoperto. La musica è sempre stata fatta di storie: un artista ci piace di più quando ci piace la sua storia, non solo le sue canzoni.

Quanto storytelling hai visto nel trionfo di Geolier allo stadio “Maradona” di Napoli?
Geolier mi sembra un artista che sa il fatto suo, con un approccio interessante e diverso da quello di altri rapper: a Sanremo ha evitato la polemica pure avendo perso, anzi ha sottolineato gli aspetti positivi di quello che aveva fatto in quel contesto, del fatto che sul podio c’erano tre artisti ventenni. Ha una sua storia e la sa raccontare bene: il trionfo nello stadio è una delle forme di racconto classiche di questi tempi e nel suo caso l’apice di un percorso.
Il capitolo relativo al live è forse uno fra i più urgenti, ma se oggi è diventato necessario spiegare cos’è un live, significa che qualcosa è davvero cambiato negli ultimi…
Negli ultimi 40 anni circa… Non recentemente.
Ecco, appunto.
La parola “live” è molto affascinante ma altrettanto fraintesa. I concerti diventano dei mega-spettacoli già con i Pink Floyd negli anni ’70 e ’80, solo per citare un esempio. “Live” è un termine ancora associato all’autenticità, ad un’esperienza senza filtri, ma l’esperienza di un concerto è sempre tecnologicamente mediata. In un concerto la dimensione spettacolare è sempre centrale, comunque lo si intenda, anche se si tratta di una performance essenziale. E in termini di tecnologia, anche nel rock e nel pop si usano spesso sul palco l’autotune per pulire la voce e le basi registrate: è il segreto di Pulcinella, lo si fa per produrre ogni sera uno spettacolo all’altezza delle aspettative. Pensiamo alla recente diatriba Dave Grohl/Taylor Swift. Entrambi hanno voluto sottolineare la loro aderenza a un suono live “assoluto”, ma pure i Foo Fighters hanno megaschermi sul palco e la produzione di Taylor Swift è probabilmente la più grande mai fatta in un live: sono scelte, per quello che vuoi raccontare sul palco e con quali strumenti. Non sarebbe stato uno scandalo se avessero ammesso che nel concerto c’è anche della tecnologia. Poi c’è chi si misura in una performance acustica, magari in un teatro, ma questo è un altro discorso, un’altra scelta ancora”.
E ora l’eterno equivoco: l’artista pop come oggetto culturale o industriale?
L’uno e l’altro. Nella musica, rispetto ad altri campi dell’intrattenimento e della cultura, l’accostamento di “cultura” e “industria” talvolta viene ancora visto come un ossimoro. Non è così: talvolta alcuni progetti hanno scopi più apertamente artistici, altre volte puntano dritti ai numeri dello streaming. Il nocciolo è che non si può avere successo senza un progetto artistico dietro. Allo stesso modo, qualsiasi progetto artistico, se vuole affermarsi, ha bisogno dell’industria. La musica è industria, è un lavoro e quindi: chi la fa mira a farsi ascoltare e a guadagnarci, per poterne vivere. Senza canzoni, però, non c’è industria.
Cosa fa, oggi, per un artista, la nuova discografia?
Una volta il capo di un’etichetta discografica mi ha detto: “Noi siamo nel business delle carriere degli artisti”. Gli attori dell’industria musicale sono tanti e interconnessi, e lo scouting oggi si fa soprattutto attraverso i social media, ma il compito della discografia non è solo creare successi immediati – cosa che peraltro si è sempre fatta – ma ragionare anche sul medio e lungo periodo, sulle carriere, sul valorizzare il catalogo con canzoni che riaffiorano dal passato grazie a TikTok o una serie tv. Alcuni compiti e obiettivi della nuova discografia sono identici a quelli della vecchia discografia, ma con nuovi strumenti: sviluppare gli artisti, ad esempio, il cosiddetto “artist development”. Ma inevitabilmente è tutto più veloce e il sistema vive di una interconnessione profonda tra discografia, piattaforme, live, media.
Credi che avesse ragione Ghemon a lamentarsi dell’odierna schiavitù dei numeri?
Sì, aveva assolutamente ragione. La musica è un’industria, i numeri sono fondamentali per capire cosa funziona e cosa no: era così anche prima dell’era del digitale. Ma, come raccontava una bella intervista di qualche anno fa del semiologo Paolo Fabbri, viviamo nell’epoca della quantofrenia, dell’assolutizzazione dei big data, ma il senso di un testo culturale non è spiegabile solo con la statistica. È un bene che con lo streaming l’industria della musica sia uscita dalla crisi di inizio millennio, e che dopo la pandemia si facciano di nuovo grandi numeri dal vivo. Ma la musica non può essere solo classifiche e sold out di posti sempre più grandi. il successo non dovrebbe essere la principale forma di racconto della musica”.