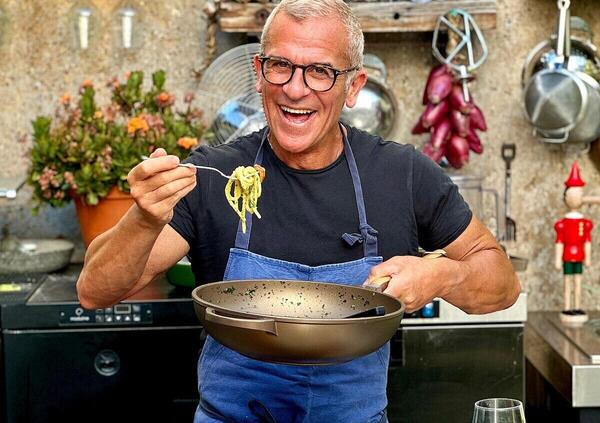C’è una cosa a cui noi italiani teniamo più della bandiera tricolore: la cucina. Primi piatti, pizza, caffè, prodotti tipici patrimonio della nostra nazione: in una parola, miti. Eppure c’è chi come il professor Alberto Grandi, studiando la storia della gastronomia italiana, ha scoperto che le ricette di cui ci vantiamo non hanno avuto una vita così lunga. O meglio, non sono state sempre come le conosciamo oggi. Nel libro La cucina italiana non esiste (Mondadori) e nel podcast Doi: denominazione di origine inventata, entrambi realizzati insieme a Daniele Soffiati, Grandi demolisce alcune delle convinzioni più solide riguardanti l’orgoglio culinario italiano. La pizza, per esempio, è diventata parte della quotidianità del nostro Paese solo dopo il ritorno degli emigrati italiani negli Stati Uniti: “Prima di quel viaggio in America era una cosa della quale gli stessi napoletani si vergognavano”. Stesso discorso per la pasta, dato che prima dell’esodo “gran parte degli italiani non la mangiava”. Non è chiaro, sembra chiedersi Grandi, perché la capacità di adattamento tipicamente nostrana non si possa applicare alla cucina: “In Italia c'è la tradizione dell'invenzione”. Neanche la cucina delle nonne, quindi, sarebbe propriamente l’esito ultimo di una tradizione secolare: gli italiani hanno “rubato”, trasformato, reinventato. Questo, però, dovrebbe essere un dato positivo. Ma Alberto Grandi ci ha parlato anche delle certificazioni (Tra cui Dop e Igp), delle ambiguità delle politiche a “chilometro zero”, della qualità (scarsa) del nostro caffè, di carne sintetica (“Il tipico prodotto europeo? La carne coltivata impanata nella farina di grilli”) e, ovviamente, di carbonara con la panna in stile Gualtiero Marchesi. E ha ricordato un aneddoto riguardante uno scontro televisivo con Max Mariola a tema pecorino romano.

Alberto Grandi, fuori dall'Italia se ne sono accorti dei miti della cucina italiana?
Al netto delle mie interviste nell'ultimo anno no. Secondo me c'è anche all'estero tanta voglia di credere in questi miti, fanno piacere a tutti. È marketing, ma fa piacere anche a chi lo subisce. L'idea di mangiare quello che mangiava Lorenzo il Magnifico fa gola a chiunque.
I nostri rivali in cucina, come magari la Francia e la Spagna, hanno una tradizione più solida rispetto alla nostra?
La cucina in Europa è una cosa mobile e frutto di contaminazioni, questo è abbastanza assodato. La Francia ha una storia un po' diversa perché prende in mano la dimensione gastronomica intorno alla metà del Seicento e da quel momento non la molla più. Però in realtà anche loro si sono inventati questo modello di cucina secolare, anche se dopo noi abbiamo superato abbondantemente i maestri.
Generalmente la capacità italiana di adattarsi viene elogiata, perché in cucina questo non accade?
È un tema molto interessante che secondo me va di pari passo con la questione della crisi di identità dell'Italia. Ci aggrappiamo alla cucina per avere un'identità e quindi siamo meno flessibili, siamo rigidi, ma in realtà la cucina come tutti gli altri ambiti del nostro modo di essere è estremamente adattabile. Noi siamo quella roba lì. L'Italia in cucina è, come dico sempre citando Guicciardini, “Francia o Spagna purché se magna”: questa è la vera essenza dell'italiano. Poi la puoi vedere in positivo o in negativo, ma è così. Per me è un dato positivo riconoscere la capacità di adattarsi, di fare proprie le tradizioni che vengono da fuori. Questo vale per la cucina, ma anche per tutto il resto. Una cosa sulla quale insisto molto è che l'Italia è un paese di trasformazione anche in cucina: siamo dei trasformatori, anche perché le materie prime mediamente ci arrivano da fuori.
La tradizione italiana è quella di non avere tradizione?
Abbiamo parafrasato Eric Hobsbawm, che ha scritto il libro L’invenzione della tradizione: noi diciamo che in Italia c'è la tradizione dell'invenzione, questa è la chiave del nostro lavoro, perché se la cucina italiana è quella cosa mitica, medievale o rinascimentale, per cui mangiamo le stesse cose da sempre, allora quella cucina lì non esiste. Quello che gli italiani mangiavano 150 anni fa non c'entra niente con quello che mangiamo oggi.
Sempre rimanendo ai paradossi: si parla di un'Italia che progredisce dal punto di vista tecnologico, ma che in cucina aspirerebbe a rimanere uguale a se stessa.
Il cibo del contadino sembra che sia esente da qualsiasi tipo di contaminazione dell'industria, mentre in realtà noi viviamo di cibo industriale. Questo è un altro mito da combattere. L'esempio che faccio sempre: un anno fa ho comprato l'automobile, ho girato un po' di concessionari, ma nessuno è venuto a dirmi “ti do la macchina di 60 anni fa”. Tutti mi hanno proposto l’ultimo modello che risparmia benzina, che è migliore, più sicuro. E lo stesso per il cibo: non si capisce per quale motivo noi dovremmo mangiare le cose che mangiavano i nostri nonni, che morivano anche più giovani.
Ci sono anche quelli che tentano di coltivare il biologico.
I contadini che fanno il biologico lo fanno perché hanno una loro nicchia. Io sono un liberale, quindi se riescono a vendere i loro prodotti sono contento per loro, però non stanno salvando il mondo, non stanno salvando l'agricoltura e l'alimentazione in Italia, stanno salvando il loro business.
Nel vostro libro affrontate anche la questione delle denominazioni come Dop (Denominazione di origine protetta, ndr): il consumatore si può affidare a queste etichette?
Allora, anche questa è una domanda difficile, nel senso che secondo me i sistemi dei consorzi e dei controlli funzionano. Dop e Igp, i marchi europei, chiamiamoli così, funzionano. Dopodiché se questo sia un vantaggio per il consumatore è tutto da dimostrare, dal punto di vista economico non sono assolutamente convinto. Il fatto che tu mi dica che il prosciutto di Parma proviene al 100% da suino italiano come dovrebbe garantirmi la sua eccellenza? La provenienza del prodotto che differenza fa rispetto alla qualità del prodotto stesso? Se la provenienza va sopra la qualità, allora c'è un intento protezionistico che va oltre.

Lei ha parlato anche di una sorta di “mito del chilometro zero”: cosa intende?
Racconto un episodio di quando ero assessore all'ambiente a Mantova. Mi trovavo le associazioni ambientaliste che dicevano che la nostra provincia era tra le più inquinate d'Europa, ma che allo stesso tempo volevano il chilometro zero. Se davvero il territorio è così inquinato io voglio il “chilometro 10mila”. Se imponi nelle mense un modello di consumo a chilometro zero stai premiando produttori che non è detto siano i più efficienti. Dovrebbe decidere il mercato se le carote mantovane sono le migliori.
I discorsi che fa la rendono un po' scomodo sia a destra che a sinistra, ma si è fatto un'idea del suo odiatore tipo?
Questa è una bella domanda. Sicuramente di destra, gastronazionalista, è quello che pensa che il nostro cibo sia il migliore del mondo e che tutti cospirino contro la cucina italiana. Questi sono gli stessi che vantano i successi della nostra cucina e poi quando vanno all'estero mangiano la carbonara con la panna e fanno una scenata, quando Gualtiero Marchesi l’ha fatto già anni fa di riproporre la ricetta in quel modo.
Il suo odiatore se la prende anche con la carne sintetica, giusto?
Ovviamente sì. Tra l'altro mi è appena capitato di partecipare a una trasmissione radiofonica dove si discuteva del prodotto tipico europeo: io ho proposto proprio la carne coltivata, una fetta di carne coltivata impanata con la farina di grilli. Ci sono state delle reazioni molto scomposte (ride, ndr).
Passiamo ai piatti che voi citate nel libro. Qual è la ricetta per cui vi attaccano più duramente?
Certamente la pizza, lì si è scatenato l'inferno. Devo dire ancora una volta che questa è una parte anche un po' sorprendente, nel senso che la storia della pizza è ormai consolidata: è noto che all’inizio fosse una schifezza. Gli italiani vanno in America e la arricchiscono, la standardizzano, la rendono un prodotto di grande qualità. Poi torna a Napoli e diventa il simbolo della città. Ma prima di quel viaggio in America era una cosa della quale gli stessi napoletani si vergognavano. Io non capisco che danno sto facendo a raccontare la storia: perché ti devi arrabbiare se io ti dico che in 60 anni hai trasformato un prodotto della povertà in un prodotto della ricchezza? Invece no, si deve dire che la pizza è sempre stata così, che noi siamo sempre stati migliori. Come dico sempre, anche un po’ in maniera provocatoria, se uno mangiava pizza e maccheroni a casa e stava bene non andava in America a fare lo schiavo.
Anche la pasta è stata cambiata dal ritorno degli italiani emigrati, giusto?
Assolutamente, gran parte degli italiani non mangiava pasta, non era parte della loro quotidianità, ma lo diventa in America. Molti tornano e a quel punto la pasta diventa il cibo che è oggi.
Criticare la pasta significa criticare una serie di primi piatti che ormai sono un simbolo nazionale più della bandiera tricolore. Pensiamo per esempio alle tagliatelle a Bologna.
Sì, poi c'è anche quest'ansia di certificazione. Bologna ha fatto un po' scuola quando ha depositato la ricetta del ripieno di tortellini, la lunghezza della tagliatella, il ragù alla bolognese. Queste, però, sono tutte invenzioni, perché qui stiamo parlando di una tradizione che è solamente orale. Certificare queste ricette significa ucciderle. Peraltro io ho studiato a Bologna, ho vissuto lì quattro anni e ci sono tornato poco tempo fa: mi ha molto stupito in negativo. Quello che ho provato è standardizzato, è esattamente ciò che tutti si aspettano. Questo vale in generale per l'Italia che pensa di poter campare di turismo e di enogastronomia. Siamo un paese dove lo sport nazionale è fregare il turista.
Il tortellino fritto, che lei racconta nel libro essere inizialmente considerato un ornamento, ora è diventato street food.
Questa cosa è interessante, sì. D’altro canto, però, siamo sempre lì, cioè il tortellino fritto adesso è diventato street food, ma 15 anni fa avrebbe fatto orrore.
Ci sono ristoranti che vendono la carbonara anche a 30 euro non tanto per il piatto in sé, quanto per la performance dello chef: un esempio di questo è Max Mariola.
Tanto tempo fa il cuoco più che per la bontà del piatto ti doveva stupire per la presentazione, per la coreografia che ci stava intorno. I grandi chef del Rinascimento e del basso medioevo avevano questa funzione e quindi ci sta la dimensione coreografica. Io sono un liberale e se uno è disposto a pagare 30 euro per un piatto di carbonara mi sta bene. Con Mariola a dire il vero ho anche litigato in tv.
Come mai?
Io ovviamente stavo esponendo le mie posizioni e Mariola è intervenuto tirando fuori una forma di pecorino e dicendo: “Questo signore qua lo sa che questo formaggio l'hanno inventato i legionari romani”. Io ho risposto che lui deve fare il suo mestiere, mentre io mi occupo del mio. Quel formaggio lì i legionari romani non l'hanno mai mangiato. Solo perché uno sa fare il soffritto non significa che possa darmi una lezione sul mio ambito di competenza.
Il formaggio è un altro dei temi caldi: negli ultimi 50 anni sono aumentate notevolmente le denominazioni, no?
C’è stata un'esplosione, anche se molto dipende dai cambiamenti normativi. Il parmigiano reggiano è il prodotto top europeo che cambia più frequentemente il proprio disciplinare. Ogni anno lo cambiano, lo mettono a posto. Non è che facciano dei cambiamenti stravolgenti. Semplicemente devono adeguare le tecnologie, nuovi prodotti, nuove nicchie di mercato.
Nel libro parlate del “parmesan” americano come un prodotto originale e non fatto per “rubare” spazio al parmigiano italiano?
Esattamente, quando hanno creato il parmesan non lo hanno fatto per togliere quote di mercato al parmigiano, che poi cento anni fa in America nemmeno ci arrivava. Lo fanno perché questa era la loro sapienza e lo facevano in quel modo lì. Tant'è vero che ancora oggi il parmesan ha la crosta nera. Se volessero davvero togliere quote di mercato al parmigiano l'avrebbero adeguato anche nell'aspetto.
Un'altra città che vive di cibo è Roma: gli chef che cucinano piatti venduti come frutto di tradizioni secolari sanno di mentire oppure semplicemente non conoscono la storia?
Entrambe le cose. C'è anche da dire che le ricette sono veloci a cambiare. Quando si dice la “carbo crema”, la cacio e pepe, sono tutte ricette consolidata ma che cambieranno. Non ci ricordiamo più di quando la carbonara si faceva con la pancetta, l'uovo stracciato, quando si usava il parmigiano e non il pecorino, quando ci si metteva l'aglio. Non ce lo ricordiamo più perché ormai ci siamo abituati e quindi anche con sincerità raccontiamo questa storia come se quella fosse da sempre la ricetta della carbonara.
Ma c'è un piatto profondamente italiano con una tradizione alle spalle? Lei ha citato lo zabaione, ma c’è altro?
Sicuramente lo zabaione è uno di quelli. È anche vero, questo l'abbiamo scritto e io lo dico tutte le volte che mi capita, che fare la storia dell'alimento, cioè la storia della singola ricetta, è un po' fuorviante dal punto di vista della storia dell'alimentazione. Il caso dello zabaione è abbastanza interessante perché è una ricetta che scrivono in tanti ed è sempre uguale. Altri esempi come lo zabaione sinceramente non mi vengono. Anche il pesto alla genovese è abbastanza stabile, però noi sappiamo che si faceva con la rucola, il basilico è arrivato dopo.

Davvero preferisce l'hamburger alla pizza come ha detto in un’altra intervista?
A me piace tutto, sono abbastanza goloso, quindi non ho preclusioni. Devo dire che quando vado in America ingrasso parecchio.
Lei ha espresso anche qualche dubbio sul caffè italiano: non è buono come pensiamo?
Su quello non ho dubbi. Io non sono un grande intenditore, tra l’altro non mi piace l'espresso al bar, preferisco la moka. Di fatto il nostro espresso è una miscela di caffè bruciato. Questo permette poi ai produttori di rifornirsi di materia prima non eccellente, perché nel momento in cui bruci tutto non è necessaria. Noi beviamo davvero un caffè di scarsa qualità. Però, ancora una volta, se si adatta al nostro gusto ben venga. Il nostro espresso è un caffè che ha la sua dignità, ma che non è necessariamente il migliore del mondo. Al contrario, è uno di quelli scarsi.
E cosa c’entrano Michelangelo, il marmo di Carrara e il lardo di colonnata?
È incredibile questa storia, che si trova anche nel sito della fiera del lardo di Colonnata, per cui Michelangelo, quando andava da quelle parti a scegliere i blocchi di marmo, faceva la spesa e comprava il lardo. Non sta scritto da nessuna parte, non c'è uno straccio di prova, è narrazione pura e non c'è niente di dimostrabile. Anzi, è dimostrabile facilmente il contrario.
Tempo fa c’è stato un dibattito sul vino tra chi dice che un bicchiere fa bene e chi invece sostiene che anche in piccole dosi faccia male: lei a chi dà ragione?
Il dato di fatto è che l'alcol fa male, in qualunque forma. Io non sono un dietologo e neanche un medico, quindi vado su un campo che non è il mio. Registro un elemento sul quale tutti sono d'accordo: l'alcol è un veleno per il nostro corpo. Il tema vero è che nessuno potrà mai dire che il vino fa bene. Nella migliore di ipotesi non fa niente, ma di sicuro non fa bene.
Secondo lei questo mercato degli influencer e del food è arrivato a saturazione?
Non so se c'è già arrivato, ma ci sta arrivando. Io lo riscontro nelle reazioni ai contenuti che facciamo: un anno fa erano tutte negative, di gente che mi minacciava di morte. Adesso capita di meno. Ovviamente qualcuno c’è ancora, però mi sembra che questa roba abbia stufato.
Anche l'esportazione di prodotti italiani di cui andiamo fieri in realtà non è così incredibile.
Se andiamo a vedere la composizione del nostro export troviamo solo prodotti industriali. La Nutella, il prosecco, la pasta Barilla, l'aceto balsamico: questi sono i grandi prodotti che noi esportiamo. Però di tipico cosa c'è? Il dato fondamentale è che importiamo più cibo di quello che esportiamo. La nostra bilancia agroalimentare è strutturalmente in passivo. Il che vuol dire, tradotto in termini generali, che il mondo può fare a meno di noi e noi non possiamo fare a meno del mondo. Il salame di Varsi, il cioccolato di Modica o la caciotta di Pienza non hanno nessun tipo di rilevanza. Se tenessimo conto solo di queste specialità la cucina italiana sarebbe famosa come quella del Liechtenstein.
Come vede la cucina del futuro?
Ci saranno nuovi ingredienti come la carne coltivata, la farina di insetti, gli Ogm, tutte cose che a quel punto faranno parte delle nostre tradizioni. Ma l'abbiamo già visto sotto i nostri occhi quest'estate con il granchio blu, che da animale killer è diventato un cibo da ristorante.
Del veganesimo cosa pensa?
Io ho già detto che secondo me andrà a finire che diventeremo tutti vegani.
Alcuni dicono che sia un vezzo di noi occidentali, che negli ultimi 50 anni abbiamo mangiato carne a sbaffo.
In parte è vero, cioè noi ci possiamo permettere oggi di fare i vegani. Solo 50 anni fa se stavi bene mangiavi la carne, l'esatto opposto rispetto a questo atteggiamento. Però c’è da dire che con l'attuale pressione demografica, e soprattutto con l'incremento del benessere a livello globale, una dieta proteica per 8-9 miliardi di persone è impossibile. Ragionevolmente bisognerà trovare delle alternative. Un pezzo sarà un'estensione del veganesimo, un altro pezzo sarà la carne coltivata, un altro pezzo ancora saranno i grilli, gli insetti. Insomma, ci sarà un cambiamento anche semplicemente per rispondere a un'esigenza collettiva. Ho fatto una tavola rotonda tempo fa, c'era il direttore di vendita della Coop: mi ha detto che negli ultimi dieci anni la vendita di carne è calata del 20%. Quindi devo dire che il mercato si sta muovendo.
Sulla carne sintetica e gli insetti non c’è totale accordo sull'effettiva natura green di questi prodotti.
È chiaro che la sostenibilità maggiore o minore rispetto all'agricoltura e all'allevamento tradizionale andrà valutata. Più che sulla questione della sostenibilità, però, occorre soffermarsi sul tema etico, che è molto importante. C'è una quota sempre più rilevante di consumatori che non accettano che gli animali vengano trattati come in certi allevamenti.